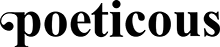Info
Portrait de Luis Bunuel
Salvador Dalí
1989
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía


Maria Luisa Spaziani (Torino, 7 dicembre 1922 – Roma, 30 giugno 2014) è stata una poetessa, traduttrice e aforista italiana. Biografia Maria Luisa Spaziani nacque in un’agiata famiglia borghese di Torino, dove il padre era proprietario di un’azienda che produce macchinari per l’industria chimica e dolciaria. Ancora studentessa, a soli diciannove anni, diresse una piccola rivista, prima chiamata «Il Girasole» e poi «Il Dado», il cui redattore capo era Guido Hess Seborga, che la fece conoscere negli ambienti letterari; ottenne e pubblicò inediti di grandi nomi nazionali come Umberto Saba, Sandro Penna, Leonardo Sinisgalli, Vasco Pratolini, e internazionali, come Virginia Woolf. Intanto frequentava l’Università di Torino, facoltà di Lingue, laureandosi infine con una tesi su Marcel Proust, relatore il francesista Ferdinando Neri. La cultura francese e la Francia con i suoi autori in seguito sarebbero diventati una sorta di stella polare nel suo immaginario e nel suo vissuto, grazie anche a una serie di soggiorni a Parigi a partire dal 1953, anno del conseguimento di una borsa di studio. Nel gennaio del 1949 conobbe Eugenio Montale durante una conferenza del poeta al teatro Carignano di Torino, e fra i due nacque, dopo un periodo d’assidua frequentazione a Milano, un sodalizio intellettuale caratterizzato anche da un’affettuosa amicizia.Ebbe quindi inizio anche la prima stagione poetica di Maria Luisa Spaziani, che mise insieme un gruppo di liriche e le inviò alla Mondadori. Durante il soggiorno francese del 1953 scrisse nuovi testi, che vennero aggiunti all’originario disegno della raccolta. La casa editrice Mondadori rispose favorevolmente e pubblicò nel 1954 Le acque del Sabato, nella prestigiosa collana Lo Specchio. Nel 1956 la fabbrica del padre subì un tracollo economico, che costrinse la giovane, di ritorno da un viaggio premio negli Stati Uniti promosso per giovani di talento da Henry Kissinger, a cercare un impiego stabile, come insegnante di francese in un collegio di Torino. Il contatto con studenti adolescenti le fece vivere una stagione di luminosa felicità che traspare nelle poesie più originali della sua prima produzione poetica, Luna lombarda (1959), poi confluite nel volume complessivo Utilità della memoria (1966). Negli anni 1955 e 1957 Maria Luisa Spaziani insegnò lingua e letteratura francese presso il liceo scientifico del collegio Facchetti di Treviglio. A tale periodo e a tali luoghi dedicò la poesia Suite per A. con la quale nel 1958 vinse il Premio Lerici (presidente di giuria Enrico Pea). Nel 1958 dopo dieci anni di fidanzamento, testimone di nozze il poeta Alfonso Gatto, sposò Elémire Zolla, studioso della tradizione mistica ed esoterica. Senza più gli slanci amorosi che caratterizzavano i primi anni, il lungo legame con Zolla s’incrinò quasi subito finendo nel 1960, anno in cui il matrimonio venne sciolto. La Spaziani venne quindi chiamata ad insegnare all’Università di Messina lingua e letteratura tedesca fino a quando non si liberò, nello stesso ateneo, l’incarico di lingua e letteratura francese; proprio in quegli anni in ambito accademico cura volumi come Pierre de Ronsard fra gli astri della Pléiade (1972) e II teatro francese del Settecento (1974). Fervida e proficua la sua attività di traduttrice dall’inglese, dal tedesco e dal francese: Pierre de Ronsard, Jean Racine, Gustave Flaubert, P.J. Toulet, André Gide, Marguerite Yourcenar, Marceline Desbordes Valmore, Francis Jammes. La statura intellettuale di Maria Luisa Spaziani superò i confini nazionali: nei viaggi in Francia e negli Stati Uniti la poetessa ebbe tra l’altro modo di conoscere personalità di rilievo assoluto del Novecento letterario come Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot, Jean-Paul Sartre. Buona parte del libro di poesie L’occhio del ciclone (1970) fu ispirato dalla sua esperienza vissuta in Sicilia, con i suoi paesaggi e il suo mare, cui fanno seguito raccolte sempre più “diaristiche” e “impure” come Transito con catene (1977) e Geometria del disordine (1981), che si aggiudica il Premio Viareggio per la poesia. Nel 1979, del lavoro poetico di Maria Luisa Spaziani, autrice ormai affermata, con introduzione di Luigi Baldacci, venne pubblicata un’antologia (una seconda, ampliata sarebbe poi uscita nel 2000, e una terza seguì nel 2011) negli “Oscar” Mondadori. Tenne la presidenza infine nel 1982, dopo esserne stata nel 1978 fondatrice, per onorare la memoria del poeta, il Centro Internazionale Eugenio Montale, ora Universitas Montaliana, e il Premio Montale. Negli anni 80 fu autrice e/o conduttrice di alcuni programmi per Radio Rai. Gli ultimi anni Coronamento della storia e del percorso poetico dell’autrice è infine Giovanna d’Arco (1990), poema in ottave di endecasillabi senza rima che testimonia un lungo interesse dell’autrice per questo personaggio. In quest’opera Maria Luisa Spaziani si proponeva di reinventare in una narrazione popolaresca e fabulosa in versi, attraverso il personaggio di Giovanna d’Arco, i suoi oltre cinquant’anni d’ininterrotta e costante attività letteraria, giornalistica e di ricerca. Il poemetto, in un adattamento per frammenti, ha trovato una trasposizione teatrale poetica e visionaria nella regia di Fabrizio Crisafulli (Jeannette, 2002). Maria Luisa Spaziani ha scritto numerosi articoli, apparsi su riviste e quotidiani, saggi critici e una raccolta di racconti, La freccia (2000). È stata tre volte candidata al Premio Nobel per la letteratura, nel 1990, 1992 e 1997. È stata presidente onorario del Concorso L’anima del bosco, nato nel 2006 e promosso da Magema Edizioni, e presidente onorario del Premio Internazionale Torino in Sintesi riguardante il genere aforistico. Nel 2012 la sua carriera fu onorata con la pubblicazione del Meridiano Mondadori dedicato alla sua opera poetica. Per diversi anni aveva fatto parte della giuria del Premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa e del Premio Internazionale Mario Luzi. Maria Luisa Spaziani si è spenta a Roma il 30 giugno 2014, all’età di novantun anni. Opere principali Poesia Primavera a Parigi, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1954 Le acque del sabato, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1954 Luna lombarda, Venezia, N. Pozza, 1959 Il gong, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1962 Utilità della memoria, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1966 L’occhio del ciclone, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1970 Ultrasuoni, Samedan, Munt press, 1976 Transito con catene, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1977 Poesie, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1979– introduzione di Luigi Baldacci Geometria del disordine, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1981– Premio Viareggio La stella del libero arbitrio, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1986 Giovanna D’Arco, romanzo popolare in sei canti in ottave e un epilogo, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1990 Torri di vedetta, Milano, Crocetti, 1992 I fasti dell’ortica, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1996 La radice del mare, Napoli, Tullio Pironti editore, 1999 La traversata dell’oasi, poesie d’amore 1998-2001, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2002 La luna è già alta, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2006 L’incrocio delle mediane, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2008 L’opera poetica, Milano, Mondadori, 2012 Narrativa Donne in poesia, interviste immaginarie a celebri poetesse dell’Ottocento e del Novecento, Venezia, Marsilio, 1992 La freccia, racconti, Venezia, Marsilio, 2000 Montale e la Volpe, scritti autobiografici, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2011 Saggistica Marcel Proust e altri saggi di letteratura francese, 1959 Il teatro francese del Seicento, 1960 Ronsard fra gli astri della Pleiade, Torino, Eri, 1972 Racine e il “Bajazet”, Roma, Lo faro, 1973 Il teatro francese del Settecento, Roma, Lo faro, 1974 Il teatro francese dell’Ottocento, Roma, Lo faro, 1975 Il teatro francese del Novecento, Messina, EDAS, 1976 Teatro La vedova Goldoni, 2000 La ninfa e il suo re Teatro comico e no, Roma, Bulzoni, 1992 Traduzioni Amicizie violente di Winston Clewes, Mondadori La vittima di Saul Bellow, Feltrinelli Poesie di Sully Prudhomme, Fabbri Editori Poesie di Paul-Jean Toulet, Einaudi Götz von Berlichingen in “Teatro” di Johann Wolfgang von Goethe, Einaudi Novelle orientali di Marguerite Yourcenar, Rizzoli Fuochi di Marguerite Yourcenar, Bompiani (Premio Piombino 1986 per la traduzione) Il colpo di grazia di Marguerite Yourcenar, Feltrinelli Alexis o il trattato della lotta vana di Marguerite Yourcenar, Feltrinelli Così sia ovvero Il gioco è fatto di André Gide, SE Le meteore di Michel Tournier, Garzanti Il gallo cedrone di Michel Tournier, Garzanti Gaspare, Melchiorre e Baldassarre di Michel Tournier, Garzanti Il dubbio e la grazia di Alain Bosquet, Città Armoniosa Madame Bovary di Gustave Flaubert, Oscar Mondadori Britannico – Bajazet – Atalia di Jean Racine, Garzanti Liriche d’amore di Marceline Desbordes-Valmore, Ignazio Maria Gallino Editore Clairières dans le ciel di Francis Jammes, RueBallu Edizioni Onorificenze e riconoscimenti Cavaliere dell’Ordine delle Palme accademiche (Francia) Palazzo Farnese (sede dell’ambasciata), Roma 2011 Nel 2017 Le scuole elementari Casati e Battisti di Torino sono diventate Istituto Comprensivo Maria Luisa Spaziani

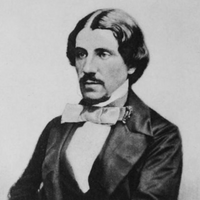
William Allingham (19 March 1824– 18 November 1889) was an Irish poet, diarist and editor. He wrote several volumes of lyric verse, and his poem 'The Faeries’ was much anthologised; but he is better known for his posthumously published Diary, in which he records his lively encounters with Tennyson, Carlyle and other writers and artists. His wife, Helen Allingham, was a well-known water-colorist and illustrator. Biography William Allingham was born on 19 March 1824 in the little port of Ballyshannon, County Donegal, Ireland, and was the son of the manager of a local bank who was of English descent. His younger brothers and sisters were Catherine (b. 1826), John (b. 1827), Jane (b. 1829), Edward (b. 1831; who lived only a few months) and a still-born brother (b. 1833). During his childhood his parents moved twice within the town, where the boy enjoyed the country sights and gardens, learned to paint and listened to his mother’s piano-playing. When he was nine, his mother died. He obtained a post in the custom-house of his native town, and held several similar posts in Ireland and England until 1870. During this period were published his Poems (1850; which included his well-known poem, 'The Fairies’) and Day and Night Songs (1855; illustrated by Dante Gabriel Rossetti and others). (Rossetti’s Letters to Allingham (1854–1870), edited by Dr. Birkbeck Hill, would be published in 1897.) Lawrence Bloomfield in Ireland, his most ambitious, though not his most successful work, a narrative poem illustrative of Irish social questions, appeared in 1864. He also edited The Ballad Book for the Golden Treasury series in 1864, and Fifty Modern Poems in 1865. In April 1870 Allingham retired from the customs service, moved to London and became sub-editor of Fraser’s Magazine, eventually becoming editor in succession to James Froude in June 1874– a post he would hold till 1879. On 22 August 1874 he married the illustrator, Helen Paterson, who was twenty-four years younger than he. His wife gave up her work as an illustrator and would become well known under her married name as a water-colour painter. At first the couple lived in London, at 12 Trafalgar Square, Chelsea, near Allingham’s friend, Thomas Carlyle, and it was there that they had their first two children– Gerald Carlyle (b. 1875 November) and Eva Margaret (b. 1877 February). In 1877 appeared Allingham’s Songs, Poems and Ballads. In 1881, after the death of Carlyle, the Allinghams moved to Sandhills near Witley in Surrey, where their third child, Henry William, was born in 1882. At this period Allingham published Evil May Day (1883), Blackberries (1884) and Irish Songs and Poems (1887). In 1888, because of William’s declining health, they moved back to the capital, to the heights of Hampstead village. But in 1889, on 18 November, William died at Hampstead. According to his wishes he was cremated. His ashes are interred at St. Anne’s church in his native Ballyshannon. Posthumously Allingham’s Varieties in Prose was published in 1893. William Allingham A Diary, edited by Mrs Helen Allingham and D. Radford, was published in 1907. It contains Allingham’s reminiscences of Alfred Tennyson, Thomas Carlyle and other writers and artists. Assessment and influence Working on an un-ostentatious scale, Allingham produced much lyrical and descriptive poetry, and the best of his pieces are thoroughly national in spirit and local colouring. His verse is clear, fresh, and graceful. His best-known poem remains his early work, “The Faeries”. Allingham had a substantial influence on W. B. Yeats; while the Ulster poet John Hewitt felt Allingham’s impact keenly, and attempted to revive his reputation by editing, and writing an introduction to, The Poems of William Allingham (Oxford University Press/ Dolmen Press, 1967). Allingham’s wide-ranging anthology of poetry, Nightingale Valley (1862) was to be the inspiration for the 1923 collection Come Hither by Walter de la Mare. We daren’t go a-hunting/For fear of little men... was quoted by the character of The Tinker near the beginning of the movie Willy Wonka & the Chocolate Factory, as well as in Mike Mignola’s comic book short story Hellboy: The Corpse, plus the 1973 horror film Don’t Look in the Basement. Several lines of the poem are quoted by Henry Flyte, a character in issue No. 65 of the Supergirl comic book, August 2011. This same poem was quoted in Andre Norton’s 1990 science fiction novel Dare To Go A-Hunting (ISBN 0-812-54712-8). Up the Airy Mountain is the title of a short story by Debra Doyle and James D. Macdonald; while the working title of Terry Pratchett’s The Wee Free Men was “For Fear of Little Men”. The Allingham Arms Hotel in Bundoran, Co. Donegal is named after him. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/William_Allingham


Oliver Goldsmith (10 November 1728– 4 April 1774) was an Irish novelist, playwright and poet, who is best known for his novel The Vicar of Wakefield (1766), his pastoral poem The Deserted Village (1770), and his plays The Good-Natur’d Man (1768) and She Stoops to Conquer (1771, first performed in 1773). He is thought to have written the classic children’s tale The History of Little Goody Two-Shoes (1765). Biography Goldsmith’s birth date and year are not known with certainty. According to the Library of Congress authority file, he told a biographer that he was born on 10 November 1728. The location of his birthplace is also uncertain. He was born either in the townland of Pallas, near Ballymahon, County Longford, Ireland, where his father was the Anglican curate of the parish of Forgney, or at the residence of his maternal grandparents, at the Smith Hill House in the diocese of Elphin, County Roscommon where his grandfather Oliver Jones was a clergyman and master of the Elphin diocesan school, and where Oliver studied. When Goldsmith was two years old, his father was appointed the rector of the parish of “Kilkenny West” in County Westmeath. The family moved to the parsonage at Lissoy, between Athlone and Ballymahon, and continued to live there until his father’s death in 1747. In 1744 Goldsmith went up to Trinity College, Dublin. His tutor was Theaker Wilder. Neglecting his studies in theology and law, he fell to the bottom of his class. In 1747, along with four other undergraduates, he was expelled for a riot in which they attempted to storm the Marshalsea Prison. He was graduated in 1749 as a Bachelor of Arts, but without the discipline or distinction that might have gained him entry to a profession in the church or the law; his education seemed to have given him mainly a taste for fine clothes, playing cards, singing Irish airs and playing the flute. He lived for a short time with his mother, tried various professions without success, studied medicine desultorily at the University of Edinburgh from 1752 to 1755, and set out on a walking tour of Flanders, France, Switzerland and Northern Italy, living by his wits (busking with his flute). He settled in London in 1756, where he briefly held various jobs, including an apothecary’s assistant and an usher of a school. Perennially in debt and addicted to gambling, Goldsmith produced a massive output as a hack writer for the publishers of London, but his few painstaking works earned him the company of Samuel Johnson, with whom he was a founding member of “The Club”. There, through fellow Club member Edmund Burke, he made the acquaintance of Sir George Savile, who would later arrange a job for him at Thornhill Grammar School. The combination of his literary work and his dissolute lifestyle led Horace Walpole to give him the epithet inspired idiot. During this period he used the pseudonym “James Willington” (the name of a fellow student at Trinity) to publish his 1758 translation of the autobiography of the Huguenot Jean Marteilhe. Goldsmith was described by contemporaries as prone to envy, a congenial but impetuous and disorganised personality who once planned to emigrate to America but failed because he missed his ship. At some point around this time he worked at Thornhill Grammar School, later basing Squire Thornhill (in the Vicar of Wakefield) on his benefactor Sir George Savile and certainly spending time with eminent scientist Rev. John Mitchell, who he probably knew from London. Mitchell, sorely missed good company, which Goldsmith naturally provided in spades.Thomas De Quincey wrote of him 'All the motion of Goldsmith’s nature moved in the direction of the true, the natural, the sweet, the gentle’. His premature death in 1774 may have been partly due to his own misdiagnosis of his kidney infection. Goldsmith was buried in Temple Church in London. The inscription reads; "HERE LIES/OLIVER GOLDSMITH". There is a monument to him in the centre of Ballymahon, also in Westminster Abbey with an epitaph written by Samuel Johnson. Works * See The Vicar of Wakefield, The Good-Natur’d Man, The Traveller, and She Stoops to Conquer. The Citizen of the World * In 1760 Goldsmith began to publish a series of letters in the Public Ledger under the title The Citizen of the World. Purportedly written by a Chinese traveller in England by the name of Lien Chi, they used this fictional outsider’s perspective to comment ironically and at times moralistically on British society and manners. It was inspired by the earlier essay series Persian Letters by Charles de Secondat, Baron de Montesquieu. The Hermit * Goldsmith wrote this romantic ballad of precisely 160 lines in 1765. The hero and heroine are Edwin, a youth without wealth or power, and Angelina, the daughter of a lord “beside the Tyne.” Angelina spurns many wooers, but refuses to make plain her love for young Edwin. “Quite dejected with my scorn,” Edwin disappears and becomes a hermit. One day, Angelina turns up at his cell in boy’s clothes and, not recognising him, tells him her story. Edwin then reveals his true identity, and the lovers never part again. The poem is notable for its interesting portrayal of a hermit, who is fond of the natural world and his wilderness solitude but maintains a gentle, sympathetic demeanor toward other people. In keeping with eremitical tradition, however, Edwin the Hermit claims to "spurn the [opposite] sex." This poem appears under the title of “A Ballad” sung by the character of Mr. Burchell in Chapter 8 of Goldsmith’s novel, The Vicar of Wakefield. The Deserted Village * In the 1760s Goldsmith witnessed the demolition of an ancient village and destruction of its farms to clear land to become a wealthy man’s garden. His poem The Deserted Village, published in 1770, expresses a fear that the destruction of villages and the conversion of land from productive agriculture to ornamental landscape gardens would ruin the peasantry. Other works * The Complete Poetical Works of Oliver Goldsmith (ed) Austin Dobson, 1887, kindle ebook March 2011 ASIN B004TP31VM * The ironic poem, An Elegy on the Death of a Mad Dog was published in 1766. * A History of the Earth and Animated Nature (1774) * Goldsmith is also thought to have written the classic children’s tale The History of Little Goody Two-Shoes. Memorials concerning Oliver Goldsmith * Goldsmith lived in Kingsbury, now in North-West London between 1771 and 1774 and Oliver Goldsmith Primary School and Goldsmith Lane there are named after him. * The Oliver Goldsmith Summer School is held every June Bank Holiday at Ballymahon with poetry and creative readings being held at Goldsmith’s birthplace in nearby Pallas, Forgney. * In the play Marx in Soho by Howard Zinn, Marx makes a reference to Goldsmiths’ poem, The Deserted Village. * A statue of him by JH Foley stands at the Front Arch of Trinity College, Dublin (see image). * A statue of him stands in a limestone cell at the ruin of his birthplace in Pallas, Forgney, Ballymahon, County Longford. The statue is a copy of the Foley statue that stands outside Trinity college Dublin and is the focus point of the annual Oliver Goldsmith Summer School. * His name has been given to a new lecture theatre and student accommodation on the Trinity College campus: Goldsmith Hall. * Somerset Maugham used the last line from An Elegy on the Death of a Mad Dog in his novel The Painted Veil (1925). The character Walter Fane’s last words are The dog it was that died. * Auburn, Alabama, and Auburn University were named for the first line in Goldsmith’s poem: “Sweet Auburn, loveliest village of the plain.” Auburn is still referred to as the ‘loveliest village on the plain.’ * There is a statue in Ballymahon County Longford outside the town library by Irish Sculptor Éamonn O’ Doherty (1939 - 2011)which was unveiled in 1999. * London Underground locomotive number 16 (used on the Metropolitan line of the London Underground until 1962) was named Oliver Goldsmith. * Longford based band Goldsmith are named after the famous writer. * Athlone Institute of Technology library is named the Goldsmith Library In popular culture * Two characters in the 1951 comedy The Lavender Hill Mob quote the same line from Goldsmith’s poem “The Traveller”– a subtle joke, because the film’s plot involves the recasting of stolen gold. * During the opening credits of the SKY One adaptation of Sir Terry Pratchett’s Christmas story “The Hogfather”, a portrait of Goldsmith is shown as part of a hall of memorials to those “exhumed” by the “Ankh-Morpork Assassins’ Guild”. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Goldsmith

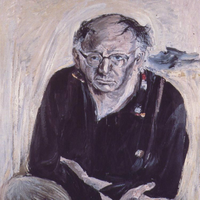
Patrick Kavanagh (21 October 1904– 30 November 1967) was an Irish poet and novelist. His best-known works include the novel Tarry Flynn, and the poems “On Raglan Road” and “The Great Hunger”. He is known for his accounts of Irish life through reference to the everyday and commonplace. Life and work Early life Patrick Kavanagh was born in rural Inniskeen, County Monaghan, in 1904, the fourth of the ten children of Bridget Quinn. His grandfather was a schoolteacher called “Keaveney”, which a local priest changed to “Kavanagh”. The grandfather had to leave the area following a scandal and never taught in a national school again. Patrick Kavanagh’s father, James, was a shoemaker and farmer. Kavanagh’s brother Peter became a university professor and writer, two of their sisters were teachers, three became nurses, and one became a nun. Patrick Kavanagh was a pupil at Kednaminsha National School from 1909 to 1916, leaving in the sixth year at the age of 13. He became apprenticed to his father as a shoemaker and worked on his farm. He was also goalkeeper for the Inniskeen Gaelic football team. He later reflected: “Although the literal idea of the peasant is of a farm labouring person, in fact a peasant is all that mass of mankind which lives below a certain level of consciousness. They live in the dark cave of the unconscious and they scream when they see the light.” He also commented that, although he had grown up in a poor district, "the real poverty was lack of enlightenment [and] I am afraid this fog of unknowing affected me dreadfully.” Writing career Kavanagh’s first published work appeared in 1928 in the Dundalk Democrat and the Irish Independent. Kavanagh had encountered a copy of the Irish Statesman, edited by George William Russell, who published under the pen name AE and was a leader of the Irish Literary Revival. Russell at first rejected Kavanagh’s work but encouraged him to keep submitting, and he went on to publish verse by Kavanagh in 1929 and 1930. This inspired the farmer to leave home and attempt to further his aspirations. In 1931, he walked 80 kilometres to meet Russell in Dublin, where Kavanagh’s brother was a teacher. Russell gave Kavanagh books, among them works by Feodor Dostoyevsky, Victor Hugo, Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson and Robert Browning, and became Kavanagh’s literary adviser. Kavanagh joined Dundalk Library and the first book he borrowed was The Waste Land by T. S. Eliot. Kavanagh’s first collection, Ploughman and Other Poems, was published in 1936. It is notable for its realistic portrayal of Irish country life, free of the romantic sentiment often seen at the time in rural poems, a trait he abhorred. Published by Macmillan in its series on new poets, the book expressed a commitment to colloquial speech and the unvarnished lives of real people, which made him unpopular with the literary establishment. Two years after his first collection was published he had yet to make a significant impression. The Times Literary Supplement described him as “a young Irish poet of promise rather than of achievement,” and The Spectator commented that, “like other poets admired by A.E., he writes much better prose than poetry. Mr Kavanagh’s lyrics are for the most part slight and conventional, easily enjoyed but almost as easily forgotten.” In 1938 Kavanagh went to London. He remained there for about five months. The Green Fool, a loosely autobiographical novel, was published in 1938 and Kavanagh was accused of libel. Oliver St. John Gogarty sued Kavanagh for his description of his first visit to Gogarty’s home: “I mistook Gogarty’s white-robed maid for his wife or his mistress; I expected every poet to have a spare wife.” Gogarty, who had taken offence at the close coupling of the words “wife” and “mistress”, was awarded £100 in damages. The book, which recounted Kavanagh’s rural childhood and his attempts to become a writer, received international recognition and good reviews. In 1939 Kavanagh settled in Dublin. In his biography John Nemo describes Kavanagh’s encounter with the city’s literary world: “he realized that the stimulating environment he had imagined was little different from the petty and ignorant world he had left. He soon saw through the literary masks many Dublin writers wore to affect an air of artistic sophistication. To him such men were dandies, journalists, and civil servants playing at art. His disgust was deepened by the fact that he was treated as the literate peasant he had been rather than as the highly talented poet he believed he was in the process of becoming”. In 1942 he published his long poem The Great Hunger, which describes the privations and hardship of the rural life he knew well. Although it was rumoured at the time that all copies of Horizon, the literary magazine in which it was published, were seized by the Garda Síochána, Kavanagh denied that this had occurred, saying later that he was visited by two Gardaí at his home (probably in connection with an investigation of Horizon under the Special Powers Act). Written from the viewpoint of a single peasant against the historical background of famine and emotional despair, the poem is often held by critics to be Kavanagh’s finest work. It set out to counter the saccharine romanticising of the Irish literary establishment in its view of peasant life. Richard Murphy in the The New York Times Book Review described it as “a great work” and Robin Skelton in Poetry praised it as “a vision of mythic intensity”. Kavanagh worked as a part-time journalist, writing a gossip column in the Irish Press under the pseudonym Piers Plowman from 1942 to 1944 and acted as film critic for the same publication from 1945 to 1949. In 1946 the Archbishop of Dublin, John Charles McQuaid, found Kavanagh a job on the Catholic magazine The Standard. McQuaid continued to support him throughout his life. Tarry Flynn, a semi-autobiographical novel, was published in 1948 and was banned for a time. It is a fictional account of rural life. It was later made into a play, performed at the Abbey Theatre in 1966. In late 1946 Kavanagh moved to Belfast, where he worked as a journalist and as a barman in a number of public houses in the Falls Road area. During this period he lodged in the Beechmount area in a house where he was related to the tenant through the tenant’s brother-in-law in Ballymackney, County Monaghan. Before returning to Dublin in November 1949 he presented numerous manuscripts to the family, all of which are now believed to be in Spain. Kavanagh’s personality became progressively quixotic as his drinking increased over the years and his health deteriorated. Eventually, a dishevelled figure, he moved among the bars of Dublin, drinking whiskey, and displaying his predilection for turning on benefactors and friends. Later career In 1949 Kavanagh began to write a monthly “Diary” for Envoy, a literary publication founded by John Ryan, who became a lifelong friend and benefactor. The Envoy’s offices were at 39 Grafton Street, but most of the journal’s business was conducted in a nearby pub, McDaid’s, which Kavanagh subsequently adopted as his local. Through Envoy he came into contact with a circle of young artists and intellectuals including Anthony Cronin, Patrick Swift, John Jordan and the sculptor Desmond MacNamara, whose bust of Kavanagh is in the Irish National Writers Museum. Kavanagh often referred to these times as the period of his “poetic rebirth”. In 1952 Kavanagh published his own journal, Kavanagh’s Weekly: A Journal of Literature and Politics, in conjunction with, and financed by, his brother Peter. It ran to some 13 issues, from 12 April to 5 July 1952. The Leader lawsuit and lung cancer In 1954 two major events changed Kavanagh’s life. First, he sued The Leader for publishing a portrait of him as an alcoholic sponger. The highly skilled lawyer John A. Costello, acting in defence of The Leader, won the case when it came to trial. (Costello had been Attorney General of Ireland (1926–1932) and later became Taoiseach (1948–1951 and 1954–1957). He and Kavanagh eventually became good friends.) Second, shortly after Kavanagh lost this case, he was diagnosed with lung cancer and was admitted to hospital, where he had a lung removed. It was while recovering from this operation by relaxing on the banks of the Grand Canal in Dublin that Kavanagh rediscovered his poetic vision. He began to appreciate nature and his surroundings, and took his inspiration from them for many of his later poems. Turning point: Kavanagh begins to receive acclaim In 1955 Macmillan’s rejected a typescript of poems by Kavanagh, which left the poet very depressed. Patrick Swift, on a visit to Dublin in 1956, was invited by Kavanagh to look at the typescript. Swift then arranged for the poems to be published in the English literary journal Nimbus(19 poems were published). This proved a turning point and Kavanagh began receiving the acclaim that he had always felt he deserved. His next collection, Come Dance with Kitty Stobling, was directly linked to the mini-collection in Nimbus. Between 1959 and 1962 Kavanagh spent more time in London, where he contributed to Swift’s X magazine. During this period Kavanagh occasionally stayed with the Swifts in Westbourne Terrace. He gave lectures at University College Dublin and in the United States, represented Ireland at literary symposiums, and became a judge of the Guinness Poetry Awards. In London he often stayed with his publisher, Martin Green, and Green’s wife Fiona, in their house in Tottenham Street, Fitzrovia. It was at this time that Martin Green produced Kavanagh’s Collected Poems (1964) with prompting from Patrick Swift and Anthony Cronin". In the introduction Kavanagh wrote: “A man innocently dabbles in words and rhymes, and finds that it is his life.” Marriage and death Kavanagh married his long-term companion Katherine Barry Moloney (niece of Kevin Barry) in April 1967 and they set up home together on the Waterloo Road in Dublin. Kavanagh fell ill at the first performance of Tarry Flynn by the Abbey Theatre company in Dundalk Town Hall and died a few days later, on 30 November 1967, in a Dublin nursing home. His grave is in Inniskeen adjoining the Patrick Kavanagh Centre. His wife Katherine died in 1989; she is also buried there. Legacy Nobel Laureate Seamus Heaney is acknowledged to have been influenced by Kavanagh. Heaney was introduced to Kavanagh’s work by the writer Michael MacLaverty when they taught together at St Thomas’s, Belfast. Heaney and Kavanagh shares a belief in the capacity of the local, or parochial, to reveal the universal. Heaney once said that Kavanagh’s poetry “had a transformative effect on the general culture and liberated the gifts of the poetic generations who came after him.” Heaney noted: “Kavanagh is a truly representative modern figure in that his subversiveness was turned upon himself: dissatisfaction, both spiritual and artistic, is what inspired his growth.... His instruction and example helped us to see an essential difference between what he called the parochial and provincial mentalities”. As Kavanagh put it: “All great civilizations are based on the parish”. He concludes that Kavanagh’s poetry vindicates his “indomitable faith in himself and in the art that made him so much more than himself”. The actor Russell Crowe has stated that he is a fan of Kavanagh. He commented: “I like the clarity and the emotiveness of Kavanagh. I like how he combines the kind of mystic into really clear, evocative work that can make you glad you are alive”. On 24 February 2002, after winning the BAFTA Award for Best Actor in a Leading Role for his performance in A Beautiful Mind, Crowe quoted Kavanagh during his acceptance speech at the 55th British Academy Film Awards. When he became aware that the Kavanagh quote had been cut from the final broadcast, Crowe became aggressive with the BBC producer responsible, Malcolm Gerrie. He said: “it was about a one minute fifty speech but they’ve cut a minute out of it”. The poem that was cut was a four-line poem: When the Irish Times compiled a list of favourite Irish poems in 2000, ten of Kavanagh’s poems were in the top 50, and he was rated the second favourite poet behind W. B. Yeats. Kavanagh’s poem “On Raglan Road”, set to the traditional air “Fáinne Geal an Lae”, composed by Thomas Connellan in the 17th century, has been performed by numerous artists as diverse as Van Morrison, Luke Kelly, Dire Straits, Billy Bragg, Sinéad O’Connor, Joan Osborne and many others. There is a statue of Kavanagh beside Dublin’s Grand Canal, inspired by his poem “Lines written on a Seat on the Grand Canal, Dublin”: Every 17 March, after the St Patrick’s day parade, a group of Kavanagh’s friends gather at the Kavanagh seat on the banks of the Grand Canal at Mespil road in his honour. The seat was erected by his friends, led by John Ryan and Denis Dwyer, in 1968. A bronze sculpture of the writer stands outside the Palace Bar on Dublin’s Fleet Street. There is also a statue of Patrick Kavanagh located outside the Irish pub and restaurant, Raglan Road, at Walt Disney World’s Downtown Disney in Orlando, Florida. His poetic tribute to his friend the Irish American sculptor Jerome Connor was used in the plaque overlooking Dublin’s Phoenix Park dedicated to Connor. The Patrick Kavanagh Poetry Award is presented each year for an unpublished collection of poems. The annual Patrick Kavanagh Weekend takes place on the last weekend in September in Inniskeen, County Monaghan, Ireland. The Patrick Kavanagh Centre, an interpretative centre set up to commemorate the poet, is located in Inniskeen. Kavanagh Archive In 1986, Peter Kavanagh negotiated the sale of Patrick Kavanagh’s papers as well as a large collection of his own work devoted to the late poet to University College Dublin. The purchase was enabled by a public appeal for funds by the late Professor Gus Martin. He included in the sale his original hand press which he had built. The archive is housed in a special collections room in UCD’s library, and the hand press is on loan to the Patrick Kavanagh Centre, Inniskeen. The contents include: Early literary material containing verses, novels, prose writing and other publications; family correspondence containing letters to Cecilia Kavanagh and Peter Kavanagh; letters to Patrick Kavanagh from various sources (1926–40). Later literary material containing verses, novels, articles, lectures, published works, galley page proofs, Kavanagh’s Weekly, and adaptations of Kavanagh’s work (1940–67). Documents concerning libel case of Kavanagh v The Leader (1952–54). Personal correspondence, including with his sisters, Peter Kavanagh, Katherine Barry Moloney (1947–67). Printed material, press cuttings, publications, personal memorabilia, and tape recordings (1940–67). Peter Kavanagh’s papers include thesis, plays, autobiographical writing, and printed material, personal and general correspondence memorabilia, tape recordings, galley proofs (1941–82) and family memorabilia (1872–1967). Copyright Ownership of the copyright is vested in Trustees of The Patrick and Katherine Kavanagh Trust by virtue of the terms of the will of the late Kathleen Kavanagh, widow of the poet, who in turn became entitled to the copyright on the death of her husband. The proceeds of the trust are used to support deserving writers. The Trustees are Leland Bardwell, Patrick MacEntee, Eiléan Ní Chuilleanáin, Eunan O’Halpin, and Macdara Woods. This was disputed by the late Peter Kavanagh who continued publishing his work after Patrick’s death. This dispute led some books to go out of print. Most of his work is now available in the UK and Ireland but the status in the United States is more uncertain. Works Poetry * 1936– Ploughman and Other Poems * 1942– The Great Hunger * 1947– A Soul For Sale * 1958– Recent Poems * 1960– Come Dance with Kitty Stobling and Other Poems * 1964– Collected Poems (ISBN 0 85616 100 4) * 1972– The Complete Poems of Patrick Kavanagh, edited by Peter Kavanagh * 1978– Lough Derg * 1996– Selected Poems, edited by Antoinette Quinn (ISBN 0140184856) * 2004– Collected Poems, edited by Antoinette Quinn (ISBN 0-713-99599-8) Prose * 1938– The Green Fool * 1948– Tarry Flynn (ISBN 0141183616) * 1964– Self Portrait– recording * 1967– Collected Prose * 1971– November Haggard a collection of prose and poetry edited by Peter Kavanagh * 1978– By Night Unstarred. A conflated novel, completed by Peter Kavanagh * 2002– A Poet’s Country: Selected Prose, edited by Antoinette Quinn (ISBN 1843510103) Dramatisations * 1966– Tarry Flynn, adapted by P. J. O’Connor * 1986– The Great Hunger, adapted by Tom Mac Intyre * 1992– Out of That Childhood Country John McArdle’s (1992), co-written with his brother Tommy and Eugene MacCabe, is about Kavanagh’s youth loosely based on his writings. * 1997– Tarry Flynn, adapted by Conall Morrison (modern dance and play) * 2004– The Green Fool, adapted by Upstate Theatre Project References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Kavanagh
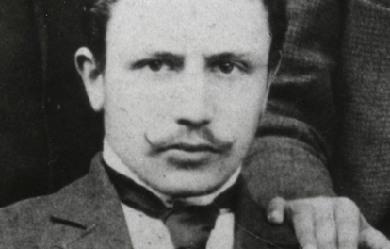
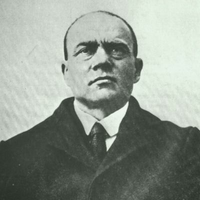
Dino Carlo Giuseppe Campana (Marradi, 20 agosto 1885 – Scandicci, 1º marzo 1932) è stato un poeta italiano. Biografia Dino Campana nacque a Marradi, un piccolo paese tosco-romagnolo sito nella provincia di Firenze, il 20 agosto del 1885, figlio di Giovanni Campana, insegnante di scuola elementare, poi direttore didattico, descritto come un uomo per bene ma di carattere debole e remissivo, e di Francesca Luti, detta Fanny, una donna severa e compulsiva, affetta da mania deambulatoria e fervente credente cattolica. La madre era attaccata in modo morboso al figlio Manlio, più giovane di due anni di Dino. Trascorre l’infanzia in modo apparentemente sereno nel paese natìo, ma intorno all’età dei quindici anni gli vengono diagnosticati i primi disturbi nervosi, che – nonostante tutto – non gli impediranno comunque di frequentare i vari cicli di scuola. Frequenta le elementari a Marradi, poi frequenta la terza, quarta e quinta ginnasio presso il collegio dei Salesiani di Faenza. Intraprende gli studi liceali dapprima presso il Liceo Torricelli della stessa città, ed in seguito a Carmagnola (in provincia di Torino), presso il regio liceo Baldessano, dove consegue la maturità nel luglio del 1903. Quando rientra a Marradi, le crisi nervose si acutizzano, come pure i frequenti sbalzi di umore, sintomi dei difficili rapporti con la famiglia (soprattutto con la madre) ed il paese natío. Per ovviare alla monotonia delle serate marradesi, specie nella stagione invernale, Dino era solito recarsi a Gerbarola, una località poco distante dal borgo, dove con gli abitanti del luogo trascorreva qualche ora mangiando le caldarroste (la castagna è infatti il frutto tipico di Marradi), comunemente appellate con il nome di bruciati. Questo tipo di svago sembrava avere effetti positivi sui suoi disturbi psichici. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, Dino, all’età di diciotto anni, si iscrive, nell’autunno del 1903, presso l’Università di Bologna, al corso di laurea in Chimica pura, e nel gennaio dell’anno successivo entra far parte della scuola per gli ufficiali di complemento di Ravenna. Non riesce, però a superare l’esame per diventare sergente, e viene quindi prosciolto dal servizio ed in seguito congedato. Nel 1905 passa alla Facoltà di Chimica farmaceutica presso l’Università di Firenze, ma dopo pochi mesi il suo trasferimento in Toscana, Campana decide di trasferirsi nuovamente a Bologna. Il poeta espresse il suo “male oscuro” con un irrefrenabile bisogno di fuggire e dedicarsi ad una vita errabonda: la prima reazione della famiglia, del paese e successivamente anche dell’autorità pubblica, fu quella di considerare le stranezze di Campana come segni lampanti della sua pazzia. Ad ogni sua fuga, che si realizzava con viaggi in paesi stranieri, dove si dedicava ai mestieri più disparati per sostentarsi, seguiva, da parte della polizia (in conformità con il sistema psichiatrico del tempo, così come per le incertezze dei familiari) il ricovero in manicomio. Inoltre, veniva visto con sospetto per i tratti somatici che venivano giudicati “germanici” e per l’impeto con cui discuteva di poesia e filosofia. Internato per la prima volta nel manicomio di Imola (in provincia di Bologna), nel settembre del 1905, ne tenta una fuga già tra il maggio ed il luglio del 1906, per raggiungere la Svizzera e da lì la Francia. Verrà arrestato a Bardonecchia (in provincia di Torino) e di nuovo ricoverato ad Imola. Ne uscirà nel 1907, per l’interessamento della famiglia a cui viene affidato. Risale intorno al 1907 un suo viaggio in Argentina, presso una famiglia di lontani parenti emigrati, caldeggiato dagli stessi genitori per liberarlo dal tanto odiato paese natìo, e probabilmente perché il conflitto con la madre si era fatto ormai insanabile. Con molta certezza, Dino Campana accetta di partire per lasciarsi soprattutto alle spalle l’esperienza del manicomio, e perché si sentiva attratto per la nuova meta. Il viaggio in Sudamerica rappresenta comunque un punto particolarmente oscuro della biografia del poeta marradese: se alcuni infatti arrivarono a chiamarlo come “il poeta dei due mondi”, c’è anche chi, come per esempio Ungaretti, sostiene invece che in Argentina Campana non ci andò neppure. Regna una certa confusione anche sulle varie versioni intorno alla datazione e alle modalità del viaggio e sul tragitto del ritorno. Tra le varie ipotesi, quella più accreditata vede la sua partenza nell’autunno del 1907 da Genova, ed abbia vagabondato per l’Argentina fino alla primavera del 1909, quando ricompare a Marradi, dove viene arrestato. Dopo un breve internamento al San Salvi di Firenze, riparte per un viaggio in Belgio, ma viene nuovamente arrestato a Bruxelles, venendo quindi internato presso la maison de santé di Tournay all’inizio del 1910. A questo punto, si rivolge in cerca di aiuto alla famiglia e viene rimandato in Italia, a Marradi: vive un periodo più tranquillo; tra il 1912 ed il 1913, infatti, si immatricola per la seconda volta presso l’ateneo bolognese, ma soltanto dopo due mesi, chiede il trasferimento per Genova. Durante il soggiorno universitario nel capoluogo emiliano ha però modo di frequentare i gruppi di goliardi, con i quali riesce a stringere dei solidi rapporti d’amicizia, e degli appassionati di letteratura della sua età. Proprio sui fogli pubblicati dai goliardi bolognesi, infatti, escono le sue prime prove poetiche, alcune delle quali verranno in seguito incluse nell’opera maggiore di Campana, i Canti Orfici. I Canti Orfici Nel 1913 Campana si reca a Firenze, presentandosi alla redazione della rivista Lacerba di Giovanni Papini e Ardengo Soffici, suo lontano parente, a cui consegna il suo manoscritto dal titolo Il più lungo giorno. Non viene però preso in considerazione ed il manoscritto va ben presto perduto (sarà ritrovato solamente sessant’anni dopo, nel 1971, dopo la morte di Soffici, tra le sue carte nella casa di Poggio a Caiano, probabilmente nello stesso posto in cui era stato riposto e subito dimenticato).Dopo qualche mese di attesa irrisposta, Campana scende da Marradi a Firenze per riprendersi il manoscritto. Papini non lo possiede più e lo indirizza da Soffici, che però sostiene di non esserne mai entrato in possesso. Il giovane, la cui mente è già labile, si arrabbia e si dispera, poiché aveva consegnato, ingenuamente, l’unica copia esistente dell’opera. Scrive ed implora insistentemente senza altro risultato che il disprezzo e l’indifferenza di tutto l’ambiente culturale che gravita intorno alle “Giubbe Rosse”. Infine, esasperato, minaccia di venire con il coltello per farsi giustizia dell’"infame" Soffici e dei suoi soci, che definisce “sciacalli”. A proposito del dissidio tra Campana e l’ambiente letterario fiorentino si leggano le parole che Campana scrisse a Papini in una lettera del maggio del 1913: "(...) E se di arte non capite più niente cavatevi da quel focolaio di càncheri che è Firenze e venite qua a Genova: e se siete un uomo d’azione la vita ve lo dirà e se siete artista il mare ve lo dirà. Ma se voi avete un qualsiasi bisogno di creazione non sentite che monta attorno a voi l’energia primordiale di cui inossare i vostri fantasmi? Accademia della Crusca. Accademia dei Lincei. Accademia del mantellaccio: sì, voi siete l’accademia del Mantellaccio; con questo nome ora vi dico in confidenza, io vi chiamo se non rispettate di più l’arte. Mandate via quella redazione che a me sembrano tutti cialtroni. Essi sono ignari del «numero che governa i bei pensieri». La vostra speranza sia fondare l’alta coltura italiana. Fondarla sul violento groviglio delle forze nelle città elettriche sul groviglio delle selvagge anime del popolo, del vero popolo, non di una massa di lecchini, finocchi, camerieri, cantastorie, saltimbanchi, giornalisti e filosofi come siete a Firenze. Sapete, essendo voi filosofo sono in diritto di dire tutto: del resto vi sarete accorto che sono un’intelligenza superiore alla media. Per finire, il vostro giornale è monotono, molto monotono: l’immancabile Palazzeschi, il fatale Soffici: come novità: Le cose che fanno la Primavera. In verità vi dico tutte queste cose non fanno la Primavera ma l’inverno. Ma scrivete un po’ a Marinetti che è un ingegno superiore, scrivetegli che vi mandi qualche cosa di buono: e finitela colla critica” Nell’inverno del 1914, persa ormai ogni speranza di recuperare il manoscritto, Campana decide di riscrivere tutto affidandosi alla memoria e alle sue sparse bozze; in pochi mesi, lavorando anche di notte ed a costo di un enorme sforzo mentale, riesce a riscrivere il libro, con numerose modifiche ed aggiunte. Nella primavera dello stesso anno, Campana riesce finalmente a pubblicare, a proprie spese, la raccolta con il nuovo titolo, appunto, di Canti Orfici, in riferimento alla figura mitologica di Orfeo, il primo dei “poeti-musicisti”. Nel 1915 una recensione ai Canti da parte di Renato Fondi, sul Fanfulla della domenica, gli restituisce "il senso della realtà": trascorre quindi l’anno viaggiando senza una meta fissa tra Torino, Domodossola, ancora Firenze. Scoppia la Grande Guerra: Campana viene esonerato dal servizio militare, ufficialmente per problemi di salute fisica, in realtà perché segnalato ormai come malato psichiatrico grave. Nel 1916 ricerca inutilmente un impiego. Scrive a Emilio Cecchi (che sarà, insieme a Giovanni Boine —che comprese da subito l’importanza di Campana, recensendo i Canti Orfici nel 1914 su Plausi e Botte– e a Giuseppe De Robertis, uno dei suoi pochi estimatori) ed inizia con lo scrittore una breve corrispondenza. A Livorno si scontra con il giornalista Athos Gastone Banti, che scrive su di lui un articolo denigratorio sul quotidiano Il Telegrafo: si arriva quasi al duello.Nello stesso anno conosce la scrittrice Sibilla Aleramo, autrice del romanzo Una donna, con la quale instaura un’intensa quanto tumultuosa relazione, che si interromperà all’inizio del 1917, a seguito di un breve incontro nel Natale del 1916, a Marradi. Esistono testimonianze della relazione avvenuta tra Dino e Sibilla nel carteggio pubblicato da Feltrinelli nel 2000: Un viaggio chiamato amore– Lettere 1916-1918. Il carteggio ha inizio con una lettera della Aleramo, datata 10 giugno 1916, nella quale l’autrice esprime la sua ammirazione per i Canti Orfici, dichiarando di esserne stata “incantata e abbagliata insieme”. Sibilla era allora in vacanza nella Villa La Topaia a Borgo San Lorenzo, mentre Campana era in una stazione climatica presso Firenzuola per rimettersi in salute dopo essere stato colpito da una leggera paresi al lato destro del corpo. Ultimi anni e morte Nel 1918, Campana viene internato presso l’ospedale psichiatrico di Villa di Castelpulci, nei pressi di Scandicci (in provincia di Firenze). Lo psichiatra Carlo Pariani lo va a trovare per intervistarlo e conferma l’inappellabile diagnosi: ebefrenia, una forma estremamente grave ed incurabile di psicosi schizofrenica; tuttavia il poeta sembra essere a suo agio nel manicomio, vivendo una vita tranquilla e, finalmente, sedentaria.Dino Campana muore in ospedale, sembra per una forma di setticemia, causata dal ferimento con un filo spinato nella zona dello scroto, durante un tentativo di fuga, il 1º marzo del 1932. Il 2 marzo, la salma di Campana viene inumata nel cimitero di San Colombano, a Badia a Settimo, nel territorio di Scandicci, ma nel 1942, su diretto interessamento di Piero Bargellini, viene data alle spoglie del poeta una sepoltura più dignitosa e la salma trova riposo nella cappella sottostante il campanile della chiesa di San Salvatore. Durante la seconda guerra mondiale, il 4 agosto del 1944, i tedeschi, in ritirata, fanno saltare con una carica esplosiva il campanile, distruggendo nel contempo anche la cappella. Nel 1946 le ossa del poeta, in seguito ad una cerimonia alla quale partecipano numerosi intellettuali dell’epoca, tra i quali Eugenio Montale, Alfonso Gatto, Carlo Bo, Ottone Rosai, Pratolini ed altri, vengono collocate all’interno della chiesa di San Salvatore a Badia a Settimo, raggiungendo così la loro dimora attuale. La poetica La poesia di Campana è una poesia nuova nella quale si amalgamano i suoni, i colori e la musica in potenti bagliori. Il verso è indefinito, l’articolazione espressiva in un certo senso monotona ma nel contempo ricca di immagini molto forti di annientamento e purezza. Il titolo allude agli inni orfici, genere letterario attestato nell’antica Grecia tra il II e il III secolo d.C. e caratterizzato da una diversa teogonia rispetto a quella classica. Inoltre le preghiere agli dei (in particolare al dio Protogono) sono caratterizzate dagli scongiuri dal male e dalle sciagure. I temi fondamentali Uno dei temi maggiori di Campana, che si trova già all’inizio dei “Canti Orfici” nelle prime parti in prosa– La notte e Il viaggio e il ritorno– è quello dell’oscurità tra il sogno e la veglia. Gli aggettivi e gli avverbi ritornano con una ripetitiva insistenza come di chi detta durante un sogno, sogno però interrotto da forti trasalimenti (si veda la poesia “l’invetriata”, mirabile spleen baudelairiano). Nella seconda parte– nel notturno di “Genova”, ritornano tutti i miti fondamentali che saranno del Campana successivo: le città portuali, la matrona barbarica, le enormi prostitute, le pianure ventose, la schiava adolescente. Già nella prosa si nota l’uso dell’iterazione, l’uso drammatico dei superlativi, l’effetto d’eco nelle preposizioni, il ricorrere alle parole chiave che creano una forte scenografia. Del Serra ha esaminato le figure ricorrenti in Campana: anastrofi, adnominationes, tmesi anacolutiche e chiasmiche, catacresi, anastrofe con aprosdoketon. L’interpretazione della poesia Nel quindicennio che va dalla sua morte alla fine della seconda guerra mondiale (1932-1945) ed anche in seguito, nel periodo dell’espressionismo e del futurismo, l’interpretazione della poesia di Campana si focalizza sullo spessore della parola apparentemente incontrollata, nascosta in una zona psichica di allucinazione e di rovina. Nei suoi versi, dove vi sono elementi deboli di controllo e di approssimativa scrittura, si avverte – a parere di molti critici – il vitalismo delle avanguardie del primo decennio del XX secolo; dai suoi versi, per la verità, hanno attinto poeti molto differenti tra di loro, come Mario Luzi, Pier Paolo Pasolini, Andrea Zanzotto. Campana e Rimbaud Il destino di Campana è stato avvicinato a quello di Rimbaud. Ma, secondo alcuni, tra Campana e il poeta maledetto il punto di contatto (il bisogno di fuggire, l’idea del viaggio, l’abbandono di un mondo civile estraneo) è affrontato in modo molto diverso. Dove Rimbaud abbandona la letteratura per fuggire in Africa e prestarsi a mestieri avventurosi ed alternativi, come il trafficante d’armi, Campana alla fine dei suoi viaggi, senza una vera meta, trova solamente la follia. E se Rimbaud aveva fatto una scelta, Campana non scelse ma fu sopraffatto dagli eventi che attraversarono la sua vita diventandone una vittima: senza però mai disertare la poesia, come, differentemente, aveva fatto il poeta francese. Campana, fino al suo internamento a Castel Pulci, lotterà per la sua poesia e per una vita che non era mai riuscita a donargli nulla in termini di serenità e pace; e anche la strada dell’amore, il suo incontro con Sibilla Aleramo, si trasformerà in una sconfitta. Come scrive Carlo Bo nel saggio “La nuova poesia: Storia della letteratura italiana– il Novecento” (Garzanti, 2001): Eugenio Montale fu tra i primi estimatori ufficiali, il più autorevole ad oggi, delle composizioni di Dino Campana, tanto da dedicargli una poesia o meglio un omaggio a chi meglio di lui aveva saputo piegare le parole fino a renderle ancora più oscure. Sebbene i canti di Dino Campana affondino ben oltre il simbolismo francese, direttamente nelle radici della nostra terra toscana, Campana guarda al Trecento dantesco, al Cavalcanti al Dante della commedia fino ad arrivare ai canti del Foscolo (Giacomo Leopardi ancora non era stato molto diffuso), ed è toccante l’allusione dantesca con cui Eugenio Montale chiude questa struggente lirica di stampo prettamente biografico (di Dino Campana si evitava di citare per motivi piccoli borghesi la sua vita e i suoi amori travagliati nonché il suo pacifismo antinterventista) e proprio per questo ancor più provocatoria: “fino a quando riverso a terra cadde!”. Dino Campana e l’arte La critica ha spesso indagato e continua ad interrogarsi su quanto vi è di figurativo nell’opera del poeta di Marradi, conosciuto dall’immaginario come il poeta folle e visionario. Nel 1937 Gianfranco Contini scriveva «Campana non è un veggente o un visionario: è un visivo, che è quasi la cosa inversa». Nei Canti Orfici sussistono infatti elementi sia visivi che visionari con numerosi riferimenti alla pittura. Analizzando la funzione che questi aspetti hanno all’interno dell’opera si nota con evidenza come al lato visionario, con riferimento a Leonardo, a De Chirico e all’arte toscana, sia affiancato in perfetta coesione quello visivo che trova le sue allusioni nel futurismo. Pasolini, che aveva riletto con molta attenzione l’opera di Campana, aveva scritto «Particolarmente precisa era la sua cultura pittorica: gli apporti nella sua lingua del gusto cubista e di quello del futurismo figurativo sono impeccabili. Alcune sue brevi poesie-nature morte sono tra le più riuscite e se sono alla "manière de" lo sono con un gusto critico di alta qualità». A proposito poi delle conoscenze leonardesche dell’autore si può leggere, in una lettera del 12 maggio 1914 scritta da Campana a Soffici da Ginevra «Ho trovato alcuni studi, purtroppo tedeschi, di psicoanalisi sessuale di Segantini, Leonardo e altri (in particolare “Sesso e carattere” di Otto Weininger) che contengono cose in Italia inaudite: potrei fargliene un riassunto per Lacerba». La critica Dopo la pubblicazione dei “Canti Orfici” inizia subito la critica con tre articoli che, se pur differenti, danno origine al mito Campana: sulla rivista “La Voce” appare, verso la fine del 1914, l’articolo di Giuseppe De Robertis, sulla “Tribuna” quello di Emilio Cecchi e sulla “Riviera Ligure” quello di Giovanni Boine entrambi del 1915. Il ritrovamento del manoscritto de Il più lungo giorno tra le carte di Soffici fu annunciato sul Corriere della Sera del 17 giugno 1971 da Mario Luzi e ha consentito nuove forme di indagini sul complesso degli scritti campaniani. Citazioni e dediche a Dino Campana CinemaA Dino Campana sono stati dedicati quattro film: Dino Campana, 1974, regia di Marco Moretti Inganni, 1985, regia di Luigi Faccini Il più lungo giorno, 1997, regia di Roberto Riviello Un viaggio chiamato amore, 2002, regia di Michele Placido. La Scomparsa, 2016, regia di Maria Luisa CarrettoRomanziAl viaggio di Dino Campana in Uruguay e in Argentina è dedicato il romanzo di Laura Pariani Questo viaggio chiamavamo amore (Einaudi 2015).PoesiaAlla storia di amore fra Campana a la Aleramo è dedicata la poesia Sibilla del poeta Riccardo Savini, inclusa nella raccolta Nero oro ero (2010). Alla relazione tra Dino Campana e Sibilla Aleramo è dedicata la poesia di Daniele Miglio Dino e Sibilla pubblicata nella raccolta intitolata proprio Dino e Sibilla uscita nel 2011 per Edizioni il Papavero. Nell’opera vi sono più riferimenti alla poetica e al pensiero del Campana.TeatroAlla vicenda di Campana sono stati dedicati la pièce teatrale Quasi un uomo dello scrittore argentino Gabriel Cacho Millet (curatore anche dell’epistolario di Campana dal titolo Le mie lettere sono fatte per essere bruciate), la pièce teatrale “ Dino Campana poeta ” (testo di Andrea Manzi) per la regia di Lorenzo Cicero che debuttò a Marradi in occasione del primo centenario della nascita; il racconto di Antonio Tabucchi Vagabondaggio ne Il gioco del rovescio nell’edizione del 1988 e quattro film: il primo, “Dino Campana”, girato nel 1974 in formato S.8 dal giovane Marco Moretti (vincitore del Premio Nazionale "Dal S.8 al 35mm"), incentrato sulle connessioni tra vita e poesia; l’ultimo è quello di Michele Placido Un viaggio chiamato amore (2002), con Stefano Accorsi nei panni di Campana e Laura Morante in quelli di Sibilla Aleramo. A Dino Campana è stato dedicato lo spettacolo “Nottecampana” con Carlo Monni, Arlo Bigazzi, Orio Odori e Giampiero Bigazzi, da cui sono stati tratti il cd omonimo (2009, Materiali Sonori) e il libro “Nottecampana– Storie di Dino Campana o dell’urgenza della poesia” (2010, Editrice Zona). La vicenda biografica e poetica di Dino Campana viene narrata nella pièce teatrale "La più lunga ora, ricordi di Dino Campana, Poeta, Pazzo" scritta e diretta da Vinicio Marchioni, (2008) con Vinicio Marchioni, Milena Mancini, Ruben Rigillo.MusicaAlla vita di Campana è dedicata la canzone di Massimo Bubola dal titolo “Dino Campana” uscita nel 1997 all’interno del disco Mon trésor. Campana è citato nella Canzone per Alda Merini (1999) di Roberto Vecchioni. Il compositore italiano Lorenzo Signorini ha scritto due brani per voce recitante, arpa e percussioni ispirate ai Canti Orfici di Campana: Le Stelle le Pallide Notturne (2003) e La sera di fiera (2004). Il cantautore fiorentino Massimiliano Larocca ha musicato la poesia di Campana “La petite promenade du poete”, pubblicata nel suo album La breve estate del 2008. Nel 2016 Massimiliano Larocca pubblica il disco “Un mistero di sogni avverati”, nel quale compaiono 13 poesie di Dino Campana musicate integralmente dal cantautore fiorentino. All’album partecipano Riccardo Tesi, Nada, Sacri Cuori, Hugo Race e Cesare Basile “Da lontano un ubriaco canta amore alle persiane” è citato nel brano del 1998 “Ubriaco canta amore” della BandabardòCinemaI versi Fabbricare fabbricare fabbricare / preferisco il rumore del mare / che dice fabbricare fare e disfare hanno ispirato il titolo del film Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti. Nel 2016 è stato realizzato il cortometraggio “L’alluvione ha sommerso”. Il film breve racconta in modo originale la genesi dei Canti Orfici e si lega alla poesia “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili” di Eugenio Montale, in cui l’autore ricorda la tragica alluvione di Firenze del 1966 durante la quale, tra le tante cose, l’acqua del fiume Arno gli portò via anche una copia del volume campaniano. La regia del film, prodotto da Esecutivi per lo Spettacolo con il supporto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, di Luca Dal Canto, già autore di un cortometraggio tratto da una poesia di Giorgio Caproni ("Il cappotto di lana", 2012, 53 selezioni e 16 premi) e di un altro film breve ispirato alla figura di Amedeo Modigliani ("Due giorni d’estate", 2014, 29 selezioni e 5 premi). “L’alluvione ha sommerso” è stato scritto da Dino Castrovilli e Giuseppe Giachi. Dino Campana è interpretato dall’attore e performer turco Murat Onol. Opere di Campana Opera Canti Orfici, Tip. Ravagli, Marradi, 1914 Canti Orfici ed altre liriche. Opera completa, prefazione di B. Binazzi, Vallecchi, Firenze, 1928, pp. 166 Canti Orfici, a cura di Enrico Falqui, terza ed., Vallecchi, Firenze, 1941, pp. 210 Canti Orfici e altri scritti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1952, 1960, 1962 Canti Orfici e altri scritti, nota biografica a cura di E. Falqui, nota critica e commento di Silvio Ramat, Vallecchi, Firenze, 1966, pp. 362 Canti Orfici e altri scritti, a cura di Arrigo Bongiorno, introduzione di Carlo Bo, Mondadori, Milano, 1972, pp. 168 Opere e contributi, a cura di E. Falqui, prefazione di Mario Luzi, note di Domenico De Robertis e S. Ramat, 1972 Carteggio con Sibilla Aleramo, a cura di N. Gallo, Vallecchi, Firenze, 1973 Canti Orfici, introduzione e commento e Fiorenza Ceragioli, Vallecchi, Firenze, 1985, pp. 350 Canti Orfici e altre poesie, introduzione e note di N. Bonifazi, Garzanti, Milano, 1989 Canti Orfici, a cura di M. Lunetta, Newton Compton, Roma, 1989 Opere. Canti Orfici. Versi e scritti sparsi pubblicati in vita. Inediti, a cura di S. Vassalli e C. Fini, TEA, Milano, 1989 Canti Orfici, edizione critica a cura di G. Grillo, Vallecchi, Firenze, 1990 Canti Orfici, commento di M. Caronna, Rubbettino, Messina, 1993 Canti Orfici, a cura di R. Ridolfi, introduzione di P. L. Ladron de Guevara, Libreria Chiari, Firenze, 1994 (ristampa anastatica dell’edizione di Marradi, 1914) Canti Orfici, a cura di C. Bene, Bompiani, Milano, 1999 (con Compact disc) ISBN 88-452-4072-X Canti Orfici e altre poesie, a cura di Renato Martinoni, Einaudi, Torino, 2003 Canti Orfici, edizione anastatica a cura di Fabio Barricalla e Andrea Lanzola, con un apocrifo di Marco Ercolani, una nota di Veronica Pesce e un 'plauso’ di Giovanni Boine, Matisklo edizioni, Savona, 2016 Altro Inediti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1942 Taccuino, a cura di Matacotta, Edizioni Amici della Poesia, Fermo, 1949 (poi in Taccuini, edizione critica e commento di F.Ceragioli, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1990) Taccuinetto faentino, a cura di D. De Robertis, Vallecchi, Firenze, 1960 Fascicolo marradese inedito del poeta dei “Canti Orfici”, a cura di F. Ravagli, Giunti-Bemporad Marzocco, Firenze, 1972 Il più lungo giorno. I. Riproduzione anastatica del manoscritto ritrovato dei Canti Orfici, II: Il testo critico, a cura di D. De Robertis, prefazione di E. Falqui, Archivi di Arte e Cultura Dell’Età Moderna– Vallecchi, Roma-Firenze, 1973 (Poi su CD-ROM: Vallecchi, Firenze, 2002 Epistolari D. Campana, Le mie lettere sono fatte per essere bruciate, G. S. All’insegna del pesce d’oro, Milano, 1978 Souvenir d’un pendu. Carteggio 1910-1931, a cura di G. Cacho Millet, Napoli, 1985 D. Campana– Sibilla Aleramo, Un viaggio chiamato amore, Feltrinelli, Milano, 2003 Dino Campana-Sibilla Aleramo, a cura di Bruna Conti, Feltrinelli, 2000. Da questo carteggio è stato tratto il film Un viaggio chiamato amore (di Michele Placido, 2002) con Stefano Accorsi nel ruolo di Campana e Laura Morante nel ruolo di Sibilla Aleramo. D. Campana, Un po’ del mio sangue– Canti Orfici, Poesie sparse, Canto proletario italo-francese, lettere (1910- 1931), a cura di S. Vassalli, BUR, Milano, 2005 D. Campana, Lettere di un povero diavolo, Carteggio (1903-1931) Con altre testimonianze epistolari su Dino Campana (1903-1998) a cura di Gabriel Cacho Millet. In copertina una foto inedita di Dino, Polistampa, 2011. Traduzioni Dino Campana. Cantos órficos/Canti orfici. Tradução de Gleiton Lentz. Desterro: Edições Nephelibata, 2004. Dino Campana. Chants orphiques. Traduction: Christophe Mileschi. Editeur: Éditions L’Âge d’Homme.février 1997. ISBN 2-8251-0849-9 Fumetti Dino Campana. A jornada de um neurastênico/La giornata di un nevrastenico. Fumetti di Aline Daka e traduzione di Gleiton Lentz. (n.t.) Revista Literária em Tradução, n. 7, set. 2013, pp. 337–348. ISSN 2177-5141 Simone Lucciola, Rocco Lombardi, Campana, contributi di G. Cacho Millet, P. Pianigiani, G. Neri, Guida, 2014, ISBN 978-88-97980-17-9 Pablo Echaurren, Vita disegnata di Dino Campana, Editori del Grifo, Montepulciano 1994. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Campana


Francis Edward Ledwidge (19 August 1887– 31 July 1917) was an Irish war poet from County Meath. Sometimes known as the “poet of the blackbirds”, he was killed in action at the Battle of Passchendaele during World War I. Early life Ledwidge was born at Janeville, Slane, in Ireland, the eighth of nine children in a poverty-stricken family. His parents, Patrick Ledwidge (the Ledwidge family, from Shropshire, was granted land in Meath after the Norman invasion) and wife Anne Lynch (1853–1926), believed in giving their children the best education they could afford. But when Francis was only five his father Patrick died prematurely, which forced his wife and the children out to work at an early age. Francis left the local national school aged thirteen, and while he continued to educate himself, he worked at what work he could find, as farm hand, road mender and supervisor of roads, as copper miner (sacked for organising a strike for better mining conditions, three years before the general 1913 strike, and was a trade union activist since 1906) and shop assistant. Appointed secretary of the Slane branch of the Meath Labour Union (1913–14) he had aspirations of permanent white-collar work. He was known for his connections with Sinn Féin. Young poet Strongly built, with striking brown eyes and a sensuous face, Ledwidge was a keen poet, writing where ever he could– sometimes even on gates or fence posts. From the age of fourteen his works were published in his local newspaper, the Drogheda Independent reflecting his passion for the Boyne Valley. While working as a road labourer he won the patronage of the writer Lord Dunsany after writing to him in 1912, enclosing copybooks of his early work. Dunsany, a man of letters already well known in Dublin and London literary and dramatic circles, and whose own start in publishing had been with a few poems, promoted him in Dublin and introduced him to W.B. Yeats with whom he became acquainted. Dunsany supported Ledwidge with money and literary advice for some years, providing him with access to and a workspace in Dunsany Castle’s Library where he met the Irish writer Katharine Tynan, corresponding with her regularly. Dunsany later prepared his first collection of poetry Songs of the Fields, which successfully appealed to the expectations of the Irish Literary Revival and its social taste for rural poetry. Home Rule and World War I Ledwidge was a keen patriot and nationalist. His efforts to found a branch of the Gaelic League in Slane were thwarted by members of the local council. The area organiser encouraged him to continue his struggle, but Francis gave up. He did manage to act as a founding member with his brother Joseph of the Slane Branch of the Irish Volunteers (1914), a nationalist force created in response to the arming of the Ulster Volunteers who swore to resist the introduction of Home Rule for Ireland by force, if need be. The Irish Volunteers were set up to prevent their belligerence and to ensure democracy would prevail. On the outbreak of World War I in August 1914, and on account of Ireland’s involvement in the war, the Irish Volunteers split into two factions, the National Volunteers who supported John Redmond’s appeal to join Irish regiments in support of the Allied war cause and those who did not. Francis was originally of the latter party. Nevertheless, having defended this position strongly at a local council meeting, he enlisted (24 October 1914) in Lord Dunsany’s regiment, joining 5th battalion Royal Inniskilling Fusiliers, part of the 10th (Irish) Division. This was against the urgings of Dunsany who opposed his enlistment and had offered him a stipend to support him if he stayed away from the war. Some have speculated that he went to war because his sweetheart Ellie Vaughey had found a new lover, John O’Neill, whom she later married, but Ledwidge himself wrote, and forcefully, that he could not stand aside while others sought to defend Ireland’s freedom. Poetry and war Ledwidge seems to have fitted into Army life well, and rapidly achieved promotion to lance corporal. In 1915, he saw action at Suvla Bay in the Dardanelles, where he suffered severe rheumatism. Having survived huge losses sustained by his company in the Battle of Gallipoli, he became ill after a back injury on a tough mountain journey in Serbia (December 1915), a locale which inspired a number of poems. Ledwidge was dismayed by the news of the Easter Rising, and was court-martialled and demoted for overstaying his home leave and being drunk in uniform (May 1916). He gained and lost stripes over a period in Derry (he was a corporal when the introduction to his first book was written), and then, returned to the front, received back his lance corporal’s stripe one last time in January 1917 when posted to the Western Front, joining 1st Battalion, Royal Inniskilling Fusiliers, part of 29th Division. Ledwidge continued to write when feasible throughout the war years, though he lost much work, for example, in atrocious weather in Serbia. He sent much of his output to Lord Dunsany, himself moving on war assignments, as well as to readers among family, friends and literary contacts. On 31 July 1917, a group from Ledwidge’s battalion of the Royal Inniskilling Fusiliers were road-laying in preparation for an assault during the Third Battle of Ypres, near the village of Boezinge, northwest of Ieper (Ypres). While Ledwidge was drinking tea in a mud hole with his comrades, a shell exploded alongside, killing the poet and five others. A chaplain who knew him, Father Devas, arrived soon after, and recorded “Ledwidge killed, blown to bits.” The poems Ledwidge wrote on active service revealed his pride at being a soldier, as he believed, in the service of Ireland. He wondered whether he would find a soldier’s death. The dead were buried at Carrefour de Rose, and later re-interred in the nearby Artillery Wood Military Cemetery, Boezinge, (where the Welsh poet Hedd Wyn, killed on the same day, is also buried). A stone tablet commemorates him in the Island of Ireland Peace Park, Messines, Belgium. His work as “peasant poet” and “soldier poet”, once a standard part of the Irish school curriculum, faded from view for many decades of the 20th century. Its intensity, coupled with a revived interest in his period, has restored it to life. Publications and reception Much of Ledwidge’s work was published in newspapers and journals in Ireland and the UK. The only work published in book form during Ledwidge’s lifetime was the original Songs of the Fields (1915), which was very well received. The critic Edward Marsh printed three of the poems in the Georgian Poetry series, and remained a correspondent for the remainder of Ledwidge’s life. A second volume, Songs of Peace was in preparation when Ledwidge died; patron and friend Lord Dunsany wrote the introduction while both were in Derry in September 1916. Following the war, Dunsany arranged for more of Ledwidge’s work to be published, first in a third and final new volume, Last Songs, and then later in an anthology in 1919; he commented on the work with words such as: “[I was] astonished by the brilliance of that eye and that had looked at the fields of Meath and seen there all the simple birds and flowers, with a vividness which made those pages like a magnifying glass, through which one looked at familiar things for the first time.” Some of Ledwidge’s poetry was put to music by the British Composer and song-writer Michael Head, most notably in the very well received song cycle published in 1920, “Over the rim of the moon”. This includes the well-known song, “The Ships of Arcady”. Later collections: Alice Curtayne: ‘’The complete poems of Francis Ledwidge’’ (1974) who also wrote a comprehensive biography of the poet, including some previously unpublished work Liam O’Meara: ‘’The poems of Francis Ledwidge’’ (1997), (ISBN 1 870 49147 5), including some previously unpublished work Ulick O’Connor (introduction by): ‘’The best of Francis Ledwidge’’, The Inchicore Ledwidge Society, Risposte Books (2004), ISBN 1-901596-10-9 Hubert Dunn:‘’The Minstrel Boy’’, (2006) some more poems released in a commemorative volume Dermot Bolger: In 1992 long-time Ledwidge admirer, Dublin poet Dermot Bolger, published a Selected Poems of Francis Ledwidge. This was re-issued by New Island Books in 2007 under the title “A Ledwidge Treasury”, with an introduction by Seamus Heaney and an afterword by Dermot Bolger. In 2007 Bolger’s play about the life of Ledwidge, “Walking the Road”, (New Island Books, 2007) was staged in Dublin and in the Town Hall Theatre, Ieper, close where Ledwidge died. It was commissioned to mark the 90th anniversary of his death. In 1998 Bolger and the poet’s nephew, Joseph Ledwidge, were invited by the 'In Flanders Fields Museum’ to unveil a monument on the spot where Ledwidge was killed. Politics His politics are described by the Oxford Dictionary of National Biography as nationalist as well as left-wing. However far from simply being an Irish Nationalist, his poems “O’Connell Street” and "Lament for the Poets of 1916" clearly describe his sense of loss and an expression of holding the same “dreams” as the Easter Rising’s Irish Republicans who fought and died for the Irish Republic in and around O’Connell Street in 1916. Works * Songs of the Fields (1915) Full text at Internet Archive * Songs of Peace (1917) Full text at Internet Archive * Last Songs (1918) Full text at Internet Archive * The complete poems of Francis Ledwidge; with introductions by Lord Dunsany (1919) Full text at Internet Archive Quotes * Oh what a pleasant world 'twould be, * How easy we’d step thro’ it, * If all the fools who meant no harm, * Could manage not to do it! *– From a personal letter. * He shall not hear the bittern cry * in the wild sky, where he is lain, * Nor voices of the sweeter birds * Above the wailing of the rain * * Nor shall he know when the loud March blows * Thro’ slanting snows her fanfare shrill, * Blowing to flame the golden cup * Of many an upset daffodil. * * But when the dark cow leaves the moor * And pastures poor with greedy weeds * Perhaps he’ll hear her low at morn * Lifting her horn in pleasant meads. *– Lament for Thomas MacDonagh Documentary film * Ledwidge was the subject of an RTÉ documentary entitled Behind the Closed Eye, first broadcast on 18 January 1973. It won awards for Best Story and Best Implementation Documentary at the Golden Prague International Television Festival. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Ledwidge


Thomas Osborne Davis (14 October 1814– 16 September 1845) was an Irish writer who was the chief organiser of the Young Ireland movement. He was born in the town of Mallow in County Cork, the son of a Welsh father, a surgeon in the Royal Artillery, and an Irish mother. Through his mother he was descended from the Gaelic noble family of O’Sullivan Beare. His father died one month after his birth and his mother moved to Warrington Place near Mount Street bridge in Dublin. In 1830, they moved to 67 Lower Baggot Street. He attended school in Lower Mount Street before studying in Trinity College, Dublin. He graduated in Law and received an Arts degree in 1836, before being called to the Irish Bar in 1838. To a large extent Davis created the culture of modern Irish nationalism.

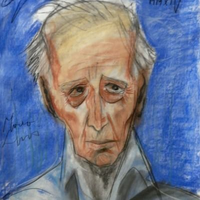
Mario Luzi (Castello di Firenze, 20 ottobre 1914 – Firenze, 28 febbraio 2005) è stato un poeta e scrittore italiano. In occasione del suo novantesimo compleanno fu nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. Biografia Nato a Castello (Firenze), allora frazione di Sesto Fiorentino, da genitori originari di Semproniano nella zona del Monte Amiata in provincia di Grosseto, trascorre l’infanzia a Castello, frequentando qui i primi anni di scuola. Nel 1926, in seguito al trasferimento del padre a Rapalano Terme in provincia di Siena, si trasferisce a casa dello zio Alberto a Milano dove rimane per solo un anno; nel 1927 ritorna a Rapalano Terme dalla famiglia per poi, nel 1929, ritornare nella sua città natale e terminare a Firenze gli studi presso il liceo classico “Galileo”. Sempre a Firenze si laurea in letteratura francese con una tesi su François Mauriac. Sono anni, questi, importanti per l’esordio poetico del giovane Luzi, che a Firenze stringe amicizie con giovani impegnati nella cultura ermetica, come Piero Bigongiari, Alessandro Parronchi, Carlo Bo, Leone Traverso e Cristina Campo, nonché l’importante e instancabile critico Oreste Macrì. Collabora alle riviste d’avanguardia come Il Frontespizio, Campo di Marte, Paragone e Letteratura. Esce nel 1935 la sua prima raccolta poetica La barca. Nel 1938 inizia l’insegnamento alle scuole superiori che lo porterà a Parma, a San Miniato e infine a Roma dove lavorerà alla Sovrintendenza bibliografica. Pubblica nel frattempo (1940) Avvento notturno. Nel 1945 ritorna a Firenze e in questa città insegna al liceo scientifico Leonardo da Vinci. Sono di questo periodo alcune importanti raccolte poetiche: nel 1946 Un brindisi e Quaderno gotico, nel n. 1 di Inventario, nel 1952 Onore del vero, Primizie del deserto e Studio su Mallarmé. Nel 1955 gli viene assegnata la cattedra di letteratura francese alla Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze. Nel 1963 pubblica Nel magma, nel 1965 Dal fondo delle campagne e nel 1971 Su fondamenti invisibili ai quali fa seguito Al fuoco della controversia nel 1978, Semiserie nel 1979, Reportage, un poemetto seguito dal Taccuino di viaggio in Cina nel 1985 e nello stesso anno Per il battesimo dei nostri frammenti. Nel 1978, per l’opera Al fuoco della controversia, gli è stato assegnato il Premio Viareggio. Il 1983 vede la pubblicazione de La cordigliera delle Ande e altri versi tradotti. È inoltre autore di importanti saggi e curatore di numerose antologie (tra cui L’idea simbolista). Fu anche un critico cinematografico nei primi anni '50: curò le recensioni di quasi 80 pellicole (tra le quali citiamo Roma ore 11 di Giuseppe De Santis e Signori, in carrozza! di Luigi Zampa) che nel 1997 furono raccolte in un libro.Conoscitore delle filosofie e religioni orientali e delle tecniche di meditazione. Il 14 ottobre 2004, in occasione del suo novantesimo compleanno è stato nominato senatore a vita dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Muore a Firenze pochi mesi dopo, il 28 febbraio 2005. Ai funerali solenni il 2 marzo, ha partecipato lo stesso Carlo Azeglio Ciampi. Alla memoria di Luzi è stata posta una lapide nella basilica di Santa Croce di Firenze, tra le spoglie dei grandi della storia tra i quali Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Galileo Galilei e il cenotafio di Dante Alighieri. È sepolto nel cimitero di Castello (Firenze). La sua memoria è custodita dal poeta fiorentino Walter Rossi, amico e confidente di Luzi negli ultimi anni della sua vita. Formazione e poetica Mario Luzi occupa un posto particolare nella famiglia dei cosiddetti ermetici e, insieme a Piero Bigongiari e a Alessandro Parronchi, si può dire che costituisca il culmine dell’ermetismo fiorentino. La prima apparizione di Luzi avvenne alla Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze dove scelse l’affiatato circolo di quel momento composto da alunni e professori che si ritrovavano per parlare e discutere senza che si avvertisse la questione degli anni o della educazione. Un clima serio e sereno al quale il giovane e timido Luzi partecipava. Luzi viveva a quei tempi in famiglia ed era arrivato alla letteratura che aveva avuto partita vinta sulla sua prima scelta universitaria, la Facoltà di Legge. Il tema che domina nella poesia di Luzi è quello della celebrazione drammatica dell’autobiografia dove viene messo in risalto il drammatico conflitto tra un “Io” portato per le cose sublimi e le scene terrestri che gli vengono proposte. La prima fase Il primo momento della poesia di Luzi, quella più propriamente ermetica, va dagli esordi con La barca del 1935 fino, in modo approssimativo, a Quaderno gotico con al centro Avvento notturno. In questo periodo l’ideologia del poeta è improntata sul Cristianesimo rinforzata dal recente pensiero cristiano francese, mentre, sul piano letterario, prosegue la linea “orfica” appartenente alla lirica moderna che ha come archetipo Mallarmé e che retrocede fino a Coleridge e al suo visionario romanticismo, senza peraltro dimenticare, anzi recuperandola, la tradizione italiana più vicina, cioè quella di Arturo Onofri e di Dino Campana, e non estraneo alla lezione surrealista d’oltralpe di Paul Éluard. In questi termini Avvento notturno (1940) è un libro che, anche se apparentemente sembra riportarci con il suo tono al nostro decadentismo liberty di inizio secolo, contiene in verità, nella forza dei suoi endecasillabi, un forte strumento che evidenzia l’influenza dei surrealisti. Le immagini dei paesaggi lunari, delle città spettrali, dei marmi e delle pietre preziose, degli angeli lacrimanti e delle chimere che riempiono questi versi, niente o poco hanno realmente a che fare con le immagini liberty o con la mistica di Arturo Onofri, grazie all’uso di un lessico che, se pure impreziosito da suggestioni dannunziane, mantiene il nitore umanistico-toscano esaltandolo. La tensione massima dei versi risulterà nella raccolta Un brindisi (1946), ma già nelle liriche datate 1940-'44 (Quaderno gotico) si sente una più matura esperienza di letture europee, come quelle derivate da Rilke e da George, quest’ultimo, tradotto da Leone Traverso, caro amico di Luzi. La seconda fase Il secondo e centrale momento della poesia di Luzi comprende, grosso modo, le tre raccolte Primizie del deserto (1952), Onore del vero (1957), e Dal fondo delle campagne (1965) fino a Su fondamenti invisibili (1971) nelle quali il poeta raggiunge i suoi più alti risultati. La raccolta “Nel magma” (1963), inoltre, costituisce una tappa importantissima per l’intera poesia italiana, che si evolve verso una fase inclusiva, nella quale la realtà cittadina e del boom economico trovano definitivamente cittadinanza poetica. Oltre ad un rinnovamento di carattere tematico si assiste ad un rinnovamento anche formale e di impostazione strutturale: ad un discorso poetico in chiave monologica si sostituisce il modulo dialogico e conseguentemente si assiste ad un’intrusione sempre maggiore di strategie stilistiche tese alla mimesi del parlato. I dialoghi con l altro, molto spesso figure femminili indistinte e sovrapposte al doppio dell io lirico, costituiscono momenti di svolta, di autoprocesso e difesa dei valori fondativi della poesia, da Luzi strenuamente difesi contro un mondo (quello del dominio della città,del lavoro e della teleologia dell utile) che sembra non prevedere più spazi per la poesia e per il poeta. Quello che prima era soprattutto atteggiamento letterario, in questi componimenti diventa vera esperienza dell’esistenza e il verso, pur non perdendo nulla della sua sensualità, acquista in tristezza e inquietudine diventando un vero verso in movimento. Questa inquietudine si legge nella descrizione del paesaggio (un paesaggio aspro e tetro, perennemente corroso dal vento e visitato raramente da vuote comparse umane) e nella ricerca assillante di un collegamento tra essere e divenire, mutamento e identità, nella speranza incerta che possa essere lenita la penosa insensatezza del vivere. La terza fase L’ultima poesia di Luzi presenta una modifica di stile più prosastico e i contenuti si sono maggiormente aperti ai ricordi dell’adolescenza, alla descrizione di ambienti quotidiani vicino a quella di paesaggi esotici. Ed è proprio alla lettura di questa sua ultima poesia, dal Fuoco della controversia che ricevette il Premio Viareggio nel 1978 a Per il battesimo dei nostri frammenti (1985), che si comprende che la storia del poeta ha attraversato una profonda opera di identificazione che, partita dai momenti iniziali di assoluta partecipazione alle forme dell’individualismo spirituale, è riuscita a creare un aggancio reale a quelli della prima e seconda maturità. Contemporaneamente alla 'produzione’ lirica si affianca anche la drammaturgia. Mario Luzi è anche autore di testi teatrali. Dal primo che è “Pietra Oscura” (1946) all’ultimo “Il fiore del dolore” (2003) corrono quasi sessant’anni di teatro. Tra questi estremi ci sono i drammi “Il libro di Ipazia”, “Rosales”, “Hystrio”, “Il Purgatorio la notte lava la mente”, tutti compresi nell’edizione Garzanti. A questi testi seguono “Ceneri e ardori” e "Felicità turbate" del 1995 e 1997, del 1999 sono “Opus Florentinum” e “La passione. Via Crucis al Colosseo” (1999). Mario Luzi ha sempre dimostrato una umiltà d’animo come pochi dando apertamente la sua disponibilità per interviste e dibattiti durante i quali ha sotteso ossequiosità al dialogo nonché apertura e confronto dialettico. Sono stati numerosi gli studenti ai quali ha concesso interviste durante gli ultimi anni della sua vita. Molti di questi studenti provenivano dalle più disparate zone d’Italia. Opere Poesia * La barca, Modena, Guanda, 1935. * Avvento notturno, Firenze, Vallecchi, 1940. * Biografia a Ebe, Firenze, Vallecchi, 1942. Prosa poetica * Un brindisi, Firenze, Sansoni, 1944. * Quaderno gotico, Firenze, Vallecchi, 1947. * Primizie del deserto, Milano, Schwarz, 1952. * Onore del vero, Venezia, Pozza, 1957. * Il giusto della vita, Milano, Garzanti, 1960. Tutte le poesie fino al 1960. * Nel magma, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1963; Milano, Garzanti, 1966. * Dal fondo delle campagne, Torino, Einaudi, 1965. * Su fondamenti invisibili, Milano, Rizzoli, 1971. * Al fuoco della controversia, Milano, Garzanti, 1978. * Semiserie, Salerno, Il Catalogo, 1979. * Reportage. Un poemetto; seguito dal Taccuino di viaggio in Cina. 1980, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1980. * La cordigliera delle Ande e altri versi tradotti, Torino, Einaudi, 1983. * Per il battesimo dei nostri frammenti, Milano, Garzanti, 1985. * Frasi e incisi di un canto salutare, Milano, Garzanti, 1990. ISBN 88-11-63473-3. * Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, Milano, Garzanti, 1994. ISBN 88-11-63471-7 * Sotto specie umana, Milano, Garzanti, 1999. * Parlate, Novara, Interlinea, 2003. ISBN 88-8212-452-5. * Tempi, con immagini di Samuele Gabai, Como, Edizioni Lythos, 2003. * Dottrina dell’estremo principiante, Milano, Garzanti, 2004. ISBN 88-11-63044-4. * Lasciami, non trattenermi. Poesie ultime, Milano, Garzanti, 2009. ISBN 978-88-11-63212-2. * Poesie ultime e ritrovate, Milano, Garzanti, 2014. ISBN 978-88-11-81072-8. Teatro * Pietra Oscura, Porretta Terme, I quaderni del battello ebbro, 1994, seconda ed. 2004, scritto nel 1947. * Ipazia. Poemetto drammatico, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1972. * Libro di Ipazia, Milano, Rizzoli, 1978. * Rosales, Genova, Edizioni del Teatro di Genova, 1983. * Hystrio, Milano, Rizzoli, 1987. ISBN 88-17-79012-5. * Il purgatorio. La notte lava la mente. Drammaturgia di un’ascensione, Genova, Costa & Nolan, 1990. ISBN 88-7648-103-6. * Io, Paola, la commediante, Milano, Garzanti, 1992. ISBN 88-11-64016-4. * Teatro, Milano, Garzanti, 1993. ISBN 88-11-66986-3. * Felicità turbate, Milano, Garzanti, 1995. * Ceneri e ardori, Milano, Garzanti, 1997. ISBN 88-11-64032-6. * Opus Florentinum, Passigli, Firenze, 2000. * Il fiore del dolore, Edizioni della Meridiana, 2003. Saggi * L’Opium chrétien, Modena, Guanda, 1938. (su Mauriac) * Un’illusione platonica e altri saggi, Firenze, Edizioni di rivoluzione, 1941; Bologna, Boni, 1972. * L’inferno e il limbo, Firenze, Marzocco, 1949; Milano, Il saggiatore, 1964. * L’idea simbolista, Milano, Garzanti, 1959; 1976. * Lo stile di Constant, Milano, Il Saggiatore, 1962. * Tutto in questione, Firenze, Vallecchi, 1965. * Vicissitudine e forma, Milano, Rizzoli, 1974. * Discorso naturale, Siena, Messapo, 1980; Milano, Garzanti, 1984. * Dante e Leopardi, o Della modernità, Roma, Editori riuniti, 1992. ISBN 88-359-3637-3. * Naturalezza del Poeta. Saggi critici, Milano, Garzanti, 1995. ISBN 88-11-59850-8. * Prima semina. Articoli, saggi e studi, 1933-1946, Milano, Mursia, 1999. ISBN 88-425-2495-6. * Vero e verso. Scritti sui poeti e sulla letteratura, Milano, Garzanti, 2002. ISBN 88-11-59729-3. Altri testi * Spazio stelle voce. Il colore della poesia, Milano, Leonardo, 1992. ISBN 88-355-0190-3. * Sperdute nel buio. 77 critiche cinematografiche, testi raccolti e radunati da Annamaria Murdocca, Blu cobalto, 1995; Milano, Archinto, 1997. ISBN 88-7768-181-0. * Giustizia e politica tra prima e seconda Repubblica, con Rocco Buttiglione, interviste di Giorgio Tabanelli, Formello, SEAM, 1998. ISBN 88-8179-076-9. * Tra poesia e vita. Antologia poetica, a cura di Marco Zulberti, Trento, U.C.T., 2006. ISBN 88-86246-81-1. * Le nuove paure. Conversazione con Renzo Cassigoli, Antella, Passigli, 2003. ISBN 88-368-0804-2. * Il testimone discreto. Per Mario Luzi in occasione dei novant’anni, a cura di Riccardo Donati, con un intervento di Mario Luzi, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2004. ISBN 88-87048-69-X. * Mario Luzi: una voce dal bosco, a cura di Renzo Cassigoli, Roma, Nuova Iniziativa editoriale, 2005. * Mario Luzi. Seminario sul teatro, incontro con il poeta, a cura di Emiliano Ventura, Roma, Fondazione Mario Luzi, 2012. ISBN 978-88-6748-001-2. Traduzioni * William Shakespeare, Riccardo II, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1966 [Teatro Stabile di Torino, 1965]. * Samuel Taylor Coleridge, Poesie e Prose, Milano, Mondadori, 1973. * Ostad Elahi, Pensieri di luce, Milano, Mondadori, 2000. Memoria * Le associazioni che preservano e diffondono le opere e la memoria del poeta fiorentino sono: Fondazione Mario LuziEnte che raccoglie le testimonianze e le donazioni di privati (carteggi, ecc.), che vanno a costituire un unico Fondo. Organizza dal 2011 il «Premio Internazionale Mario Luzi» (fondato nel 2005). L’ente provvede alla pubblicazione di testi luziani inediti e alla riedizione di lavori critici. * Nel 2015 il Fondo Luzi, dichiarato di interesse culturale nel 2011, è stato acquistato dalla Giunta della Regione Toscana e depositato all’Archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux. Centro Studi Mario Luzi “La Barca”[1]Il suo scopo raccogliere, custodire e divulgare oltre diecimila volumi di notevole valore, donati dal poeta al comune di Pienza, di cui era cittadino onorario. Fondato nel luglio 1999, prende il nome dall’opera d’esordio di Luzi. Il Centro studi “La Barca” raccoglie anche importanti manoscritti, lettere e carte private del Maestro, e rappresenta un insostituibile punto di riferimento per chiunque voglia accedere ad una parte del mondo finora sconosciuto del poeta nonché di molti altri scrittori e personalità della cultura novecentesca, non solo italiana, legati a Luzi da rapporti epistolari. * Il Centro studi è curato da un comitato scientifico, di cui fanno parte noti studiosi dell’opera luziana e da un comitato operativo. * Associazione Mendrisio Mario Luzi poesia del mondoIl sodalizio svizzero ha digitalizzato numerose opere del poeta, che sono fruibili gratuitamente online. AltroNel 2014 sono state tante le commemorazioni per celebrare il centenario della nascita del poeta. Tra queste, anche il Comune di Siena ha voluto ricordarlo dedicandogli il Palio del 16 agosto, dipinto dall’artista Ivan Dimitrov. Nel medesimo anno va ricordato il convegno, dedicato al poeta, che si è tenuto a Buonconvento, Mario Luzi 1914-2014 cui ha fatto da cornice la mostra fotografica di Daniele Sasson e Caterina Trombetti e le testimonianze di Carlo Fini, Luigi Oliveto, Marco Brogi e la stessa Caterina Trombetti. Va inoltre ricordato il documentario In Toscana. Un viaggio in versi con Mario Luzi di Marco Marchi con la regia di Bartoli e Silvia Folchi, promosso dalla Regione Toscana Nello stesso anno del Centenario (2014) si sono tenuti in varie parti d’Italia convegni e seminari dedicati alla figura e alla poesia di Mario Luzi.La rivista Poesia, mensile internazionale di cultura poetica, edita da Crocetti ha dedicato al poeta il numero 159 del marzo 2002 e il numero 187 dell’ottobre 2004. * La rivista Mosaico gli ha dedicato un numero monografico nel maggio del 2010, dal titolo “Mario Luzi e la voce della poesia”. Dal 2017, viene inoltre pubblicata “Luziana”, Rivista internazionale di studi su Mario Luzi e il suo tempo a cura di C. Carena, P. Baioni e S. Verdino, in collaborazione e con la partecipazione dell’Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del Mondo. * Strade intitolate a Mario Luzi sono a Firenze, Siena, Pisa. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Luzi


Alicia Ros El 17 -12-2011 Publique mi primer libro como autora -editora “Arco Iris de mi Sueños” Literatura infantil .Escribo para niños y adultos. Soltare mi escritura al vuelo, para que crezca Difundiré la lectura para que enriquezca Agradeceré al lector el cual me lea Aunque no le guste, o gustoso sea Desde mi corazón muchas gracias Alicia Ros ( Argentina )


Isabella Valancy Crawford (25 December 1846– 12 February 1887) was an Irish-born Canadian writer and poet. She was one of the first Canadians to make a living as a freelance writer. “Crawford is increasingly being viewed as Canada’s first major poet.” She is the author of “Malcolm’s Katie,” a poem that has achieved “a central place in the canon of nineteenth-century Canadian poetry.” Life Isabella Valancy Crawford was the last surviving daughter of Dr. Stephen Crawford. She was born in Dublin, Ireland on Christmas Day, 1846. The family emigrated to Canada when she was ten years of age. Much of Isabella Crawford’s early life is unknown. By her own account she was born in Dublin, Ireland, the sixth daughter of Dr. Stephen Dennis Crawford and Sydney Scott; but “No record has been found of that marriage or of the birthdates and birthplaces of at least six children, of whom Isabella wrote that she was the sixth.” The family was in Canada by 1857; in that year, Dr. Crawford applied for a license to practice medicine in Paisley, Canada West. “In a few years, disease had taken nine of the twelve children, and a small medical practice had reduced the family to semi-poverty.” Dr. Crawford served as Treasurer of Paisley Township, but "a scandal of a missing $500 in misappropriated Township funds and the subsequent suicide of one of his bondsmen" caused the family to leave Paisley in 1861. By chance Dr. Crawford met Richard Strickland of Lakefield. Strickland invited the Crawfords to live at his home, out of charity, and because Lakefield did not have a doctor. There the family became acquainted with Strickland’s sisters, writers Susanna Moodie and Catherine Parr Traill. Isabella Crawford reportedly began writing at that time. She was also thought to be a close companion of Mrs. Traill’s daughter, Katharine (Katie). In 1869 the family moved to Peterborough, and Crawford began to write and publish poems and stories. Her first published poem, “A Vesper Star”, appeared in The Toronto Mail on Christmas Eve, 1873. "When Dr. Crawford died, on 3 July 1875, the three women"– Isabella, her mother, and her sister Emma, all who were left in the household– “became dependent on Isabella’s literary earnings.” After Emma died of tuberculosis, "Isabella and her mother moved in 1876 to Toronto, which was the centre of the publishing world in Canada.” “Although Isabella had been writing while still living in Lakefield... and had published poems in Toronto newspapers and stories in American magazines while living in Peterborough, when she moved to Toronto she turned her attention in earnest to the business of writing.” “During this productive period she contributed numerous serialized novels and novellas to New York and Toronto publications,” “including the Mail, the Globe, the National, and the Evening Telegram. She also contributed ”a quantity of 'occasional’ verse to the Toronto papers... and articles for the Fireside Monthly. In 1886 she became the first local writer to have a novel, A little Bacchante, serialized in the Evening Globe. In her lifetime Crawford published only one book, Old Spookses’ Pass, Malcolm’s Katie and Other Poems in 1884. It was privately printed and sold poorly. Crawford paid for the printing of 1,000 copies, and presumably sent out many review copies; “there were notices in such London journals as the Spectator, the Graphic, the Leisure Hour, and the Saturday Review. These articles pointed to ‘versatility of talent,’ and to such qualities as ‘humour, vivacity, and range of power,’ which were impressive and promising despite her extravagance of incident and ‘untrained magniloquence.’” However, only 50 books sold. “Crawford was understandably disappointed and felt she had been neglected by 'the High Priests of Canadian Periodical Literature’” (Arcturus 84).” Crawford died on 12 February 1887 in Toronto. She was buried in Peterborough’s Little Lake Cemetery near the Otonabee River. She had died in poverty and for years her body lay in an unmarked grave. A fundraising campaign was begun in 1899, and on 2 November 1900, a six-foot Celtic Cross was raised above her grave, inscribed: "Isabella Valancy Crawford / Poet / By the Gift of God.” Writing Crawford was a prolific writer. “For the most part Crawford’s prose followed the fashion of the feuilleton of the day.” Her magazine writing “displays a skilful and energetic use of literary conventions made popular by Dickens, such as twins and doubles, mysterious childhood disappearances, stony-hearted fathers, sacrificial daughters, wills and lost inheritances, recognition scenes, and, to quote one of her titles, 'A kingly restitution’.” As a whole, though, it “was romantic-Gothic ‘formula fiction.’” It is her poetry that has endured. Just two years after her death, W.D. Lighthall included generous selections from her book in his groundbreaking 1889 anthology, Songs of the Great Dominion, bringing it to a wider audience. “In the 20th century critics have given the work increasing respect and appreciation." "Crawford’s Collected Poems were edited (Toronto 1905) by J.W. Garvin, with an introduction by Ethelwyn Wetherald," a popular Canadian poet. Wetherald called Crawford “purely a genius, not a craftswoman, and a genius who has patience enough to be an artist.” In his 1916 anthology, Canadian Poets, Garvin stated that Crawford was “one of the greatest of women poets.” Poet Katherine Hale, Garvin’s wife, published a volume on Isabella Valancy Crawford in the 1920s Makers of Canada series. All of this helped Crawford’s poetry become more widely known. . A "serious critical assessment began in the mid-1940s with A.J.M. Smith, Northrop Frye, and E.K. Brown, who called her ‘the only Canadian woman poet of real importance in the last century.’" "Recognition of Isabella Valancy Crawford’s extraordinary mythopoeic power, and her structural use of images, came... in James Reaney’s lecture 'Isabella Valancy Crawford’ in Our living tradition (series 3, 1959)." Then a “renewed interest in Crawford resulted in the publication of forgotten manuscripts and critical articles” in the 1970s. "A reprint of the collected poems in 1972, with an introduction by poet James Reaney, made Crawford’s work generally available; six of her short stories, edited by Penny Petrone, appeared in 1975; and in 1977 the Borealis Press published a book of fairy stories and a long unfinished poem, ‘Hugh and Ion.’.” Crawford wrote a wide variety of poems, ranging from the Walter Scott-like doggerel (pun intended) of “Love Me, Love My Dog”, to the eerie mysticism of “The Camp of Souls” to the eroticism of The Lily Bed. But it is mainly Crawford’s "long narrative poems [that] have received particular attention." “Old Spookses’ Pass” is a dialect poem, set in the Rocky Mountains, concerning a dream vision of a midnight cattle stampede towards a black abyss that is stilled by a whirling lariat; “The helot” makes use of the Spartans’ practice of intoxicating their helots to teach their own children not to drink, as the starting-point for a highly incantatory and hypnotic poem that ends in Bacchic possession and death; and “Gisli the Chieftain” fuses mythic elements, such as the Russian spring goddess Lada and the Icelandic Brynhild, into a narrative of love, betrayal, murder, and reconciliation. These poems follow a pattern of depicting the world as a battleground of opposites– light and dark, good and evil– reconciled by sacrificial love.” Malcolm’s Katie The bulk of critical attention has gone to “Malcolm’s Katie.” That poem is a long narrative in blank verse, dealing mainly with the love and trials of young Max and Katie in the 19th-century Canadian bush, but containing a second running narrative recounting the war between the North and South Winds (Winter and Summer personified as First Nations warriors), and also a collection of love songs in different stanza forms. Many of those lauding the poem have seen their own interests reflected in it. For instance, socialist Livesay gave a reading that made the poem sound like a manifesto of Utopian socialism: Crawford presents a new myth of great significance to Canadian literature: the Canadian frontier as creating ‘the conditions for a new Eden,’ not a golden age or a millennium, but ‘a harmonious community, here and now.’ Crawford’s social consciousness and concern for humanity’s future committed her, far ahead of her time and milieu, to write passionate pleas for brotherhood, pacifism, and the preservation of a green world. Her deeply felt belief in a just society wherein men and women would have equal status in a world free from war, class hatred, and racial prejudice dominates all her finest poetry.” Others have similarly seen their concerns reflected in the poem. “Malcolm’s Katie has been given a nationalistic reading by Robin Mathews, a feminist reading by Clara Thomas, a biographical reading by Dorothy Farmiloe and a Marxian reading by Kenneth Hughes, as well as various literary-historical readings by Dorothy Livesay, Elizabeth Waterston, John Ower, Robert Alan Burns and others.” Not just interpretations on the poem’s meaning, but evaluations of its worth, have varied widely. Its detractors have included poet Louis Dudek, who called Crawford “'a failed poet’ of 'hollow convention... counterfeit feeling... and fake idealism’”; and Roy Daniells, who in The Literary History of Canada (1965) called “Malcolm’s Katie” “a preposterously romantic love story on a Tennysonian model in which a wildly creaking plot finally delivers true love safe and triumphant.” Some of the poem’s supporters concede the Tennyson influence but point out that there is much more to it: “While appearing on the surface melodramatic and stereotyped, Crawford’s love story is compelling and powerful; what seems at first a conventional conflict between rival suitors for the hand of the heroine becomes a serious, even profound, account of philosophical, social and ideological confrontations.” “In ‘Malcolm’s Katie’ Crawford adapted to the setting of pioneer Canada the domestic idyll as she learned it from Tennyson. Striking and new, however, is Crawford’s location of Max and Katie’s conventional love story within a context of Native legends—Indian Summer and the battle of the North and South Winds.” This myth telling (however accurate it was as a portrayal of First Nations beliefs) is what many of its supporters see as giving the poem its power. For instance, writing about “Malcolm’s Katie, critic Northrop Frye pronounced Crawford ”the most remarkable mythopoeic imagination in Canadian poetry": the “framework’ of Isabella Crawford is that of an intelligent and industrious female songbird of the kind who filled so many anthologies in the last century. Yet the ”South Wind" passage from Malcolm’s Katie is only the most famous example of the most remarkable mythopoeic imagination in Canadian poetry. She puts her myth in an Indian form, which reminds us of the resemblance between white and Indian legendary heroes in the New World, between Paul Bunyan and Davy Crockett on the one hand and Glooscap on the other. The white myths are not necessarily imitated from the Indian ones, but they may have sprung from an unconscious feeling that the primitive myth expressed the imaginative impact of the country as more artificial literature could never do.” Frye believed, and thought Crawford’s “poetic sense” told her, “that the most obvious development in the romantic landscape is toward the mythological”; and he saw Crawford’s attempt at an indigenous Canadian myth as the intellectual equivalent of the simultaneous pioneer exploration and settlement: “In the long mythopoeic passage from Isabella Crawford’s Malcolm’s Katie, beginning ‘The South Wind laid his moccasins aside,’ we see how the poet is, first, taming the landscape imaginatively, as settlement tames it physically, by animating the lifeless scene with humanized figures, and, second, integrating the literary tradition of the country by deliberately re-establishing the broken cultural link with Indian civilization.” Hugh and Ion Dorothy Livesay, researching Crawford’s life for the Dictionary of Canadian Biography in 1977, discovered the manuscript of an uncompleted narrative poem in the Crawford fonds at Kingston, Ontario’s Queen’s University. Called Hugh and Ion, it deals with "Hugh and Ion, two friends who have fled the noxious city—probably contemporary Toronto—for purification in the primal wilderness [and] carry on a sustained dialogue, Hugh arguing for hope, light, and redemption and Ion pointing out despair, darkness, and intractable human perversity." Perhaps due to Crawford’s Toronto experiences, this last poem marked a significant change in her views, showing the city as “a demonic, urban world of isolation and blindness which has wilfully cut itself off from the regenerative power of the wildernese. The confident innocence and romantic idealism, which account for much of the inner fire of Malcolm’s Katie, have simply ceased to be operative.... Nowhere else in nineteenth-century Canadian literature, with the exception of Lampman’s ”the End of Things", is there another example of the creative imagination being brought to bear, in so Blakean a manner, on the nascent social evils of the ‘infant city.’” Recognition Isabella Valancy Crawford was designated a Person of National Historic Significance in 1947. A small garden park in downtown Toronto, at Front and John Streets (near the CN Tower), has been named Isabella Valancy Crawford Park.

Ludovico Ariosto (Reggio nell’Emilia, 8 settembre 1474 – Ferrara, 6 luglio 1533) è stato un poeta, commediografo, funzionario e diplomatico italiano, autore dell’Orlando furioso (1516-1521-1532). È considerato uno degli autori più celebri ed influenti del suo tempo. Le sue opere, il Furioso in particolare, simboleggiano una potente rottura degli standard e dei canoni dell’epoca. La sua ottava, definita “ottava d’oro”, rappresenta uno dei massimi della letteratura pre-illuminista. Biografia Ludovico Ariosto nacque a Reggio Emilia l’8 settembre del 1474, primo di dieci fratelli. Suo padre Niccolò, proveniente dalla nobile famiglia degli Ariosti, faceva parte della corte del duca Ercole I d’Este ed era comandante del presidio militare degli Estensi a Reggio Emilia. La madre, Daria Malaguzzi Valeri, era una nobildonna di Reggio.Ludovico dapprima intraprese, per volontà del padre, studi di legge a Ferrara, ma li abbandonò dopo poco tempo per concentrarsi pienamente negli studi umanistici sotto la guida del monaco agostiniano Gregorio da Spoleto. Ariosto seguì nel frattempo studi di filosofia presso l’Università di Ferrara, appassionandosi così anche alla poesia in volgare. Il fatto che il padre fosse funzionario della corte degli Estensi gli permise, fin dalla giovane età, di avere contatti con il mondo della corte, luogo della sua formazione letteraria e umanistica. Divenuto amico di Pietro Bembo, condivise con lui l’entusiasmo e la passione per le opere di Petrarca. Alla morte del padre, nel 1500, Ludovico si ritrovò a dover badare alla famiglia; nel 1502 si vide “costretto” ad accettare l’incarico di capitano della rocca presso Canossa ed è proprio qui che, da Maria, domestica che già aveva servito il padre, gli nasce Giambattista, il primogenito che Ludovico non sarà mai completamente convinto di dover riconoscere come proprio, contestando l’affidabilità di Maria. Successivamente, rientrato a Ferrara, non ancora trentenne diviene funzionario e viene assunto dal cardinale Ippolito d’Este (figlio di Ercole), per ottenere alcuni benefici ecclesiastici, facendosi poi chierico. Nel 1506 fu investito del beneficio della ricca parrocchia di Montericco (ora frazione di Albinea, in provincia di Reggio Emilia). Questa condizione gli spiacque molto: Ippolito era uomo avaro, ignorante e gretto; Ariosto stesso era divenuto un umile cortigiano, un ambasciatore, un “cavallaro”. Potrebbe meravigliare che l’Ariosto fosse addirittura “ cameriere “ alle dipendenze del Cardinale: in realtà questo termine deve essere inteso come cameriere segreto o come cameriere d’onore. In questo periodo, quindi, a causa delle faccende diplomatiche e politiche di cui doveva occuparsi, non ebbe tempo di dedicarsi alla letteratura. Nel 1509, a Ferrara, da un’altra domestica di casa Ariosto, Orsolina di Sassomarino, gli nasce un altro figlio, Virginio, che verrà poi legittimato e che seguirà le orme del padre. Il legame con Orsolina durò vari anni e fu importante per il poeta, che comprò alla madre del suo secondogenito una casa nella strada di San Michele, poi via del Turco. Nel 1513, dopo la morte del papa Giulio II della Rovere, venne eletto papa Leone X (Giovanni dei Medici), che aveva spesso manifestato stima e amicizia nei confronti dell’Ariosto. Il poeta considerava Roma il centro culturale italiano per eccellenza e decise così di recarsi alla curia papale con la speranza di trasferirvisi dopo aver ottenuto un incarico, ma invano. Intanto a Firenze Ariosto si innamorò di una donna, Alessandra Benucci, moglie del mercante Tito Strozzi, che frequentava la corte estense per affari. Successivamente, dopo essere rimasta vedova nel 1515, la donna si trasferì a Ferrara, iniziando una relazione con lo scrittore. L’Ariosto era stato sempre restio al matrimonio; pertanto si sposò solo dopo anni, in gran segreto per la paura di perdere i benefici ecclesiastici che gli erano stati concessi e con lo scopo di evitare che alla donna venisse revocata l’eredità del marito.Nel 1516 pubblicò la prima edizione dell’Orlando furioso, poema diviso in 40 canti, la cui stesura era iniziata 11 anni prima della pubblicazione. Lo dedicò al suo signore, il quale non lo apprezzò affatto. Quando nel 1517 Ippolito d’Este divenne vescovo di Agria (nome italiano per Eger, nell’Ungheria orientale), Ludovico si rifiutò di seguirlo, adducendo motivi di salute. In realtà le cause sono da ricercare nell’astio verso il cardinale, nell’amore per la sua Ferrara e in quello per la sua donna. Passò quindi al servizio di Alfonso. Anche questa si trattava di «servitù», ma «di minor disagio e probabilmente era più dignitosa». Nel 1522 Alfonso gli affidò l’arduo compito di governatore della Garfagnana, da poco annessa al Ducato, regione turbolenta, abitata da una popolazione fiera ed indomita poco avvezza al comando ed infestata da banditi, in cui l’ordine doveva essere mantenuto con la forza; in quest’occasione Ariosto dimostrò abilità politiche e pratiche. Pure queste attività gli erano invise perché gli impedivano di dedicarsi agli studi ed alla poesia. Dal 1525 tornò a Ferrara e passò i suoi ultimi anni tranquillamente, dedicandosi alla scrittura e alla messa in scena di alcune commedie e all’ampliamento dell’Orlando furioso. Rifiutò l’incarico di ambasciatore papale, spiegando che desiderava occuparsi delle sue opere e della famiglia.Nel 1532 Ariosto accompagnò Alfonso all’incontro a Mantova con l’imperatore Carlo V; al rientro a Ferrara, si ammalò di enterite e morì, dopo alcuni mesi di malattia, il 6 luglio 1533. Ludovico fu sepolto dapprima nella chiesa di San Benedetto a Ferrara e successivamente venne tumulato con grandi onori a Palazzo Paradiso. Il suo monumento funebre è opera dello scultore mantovano Alessandro Nani su disegno dell’architetto Giovan Battista Aleotti. Personalità Ariosto nelle sue opere lascia di sé l’immagine di uomo amante della vita sedentaria, tranquilla, scevra di atteggiamenti eroici.In realtà si tratta di un’immagine letteraria, di «una scelta matura e meditata». Per dovere o per scelta, egli viaggiò molto e dimostrò anche notevoli doti pratiche. Si è di fronte all’ultimo grande umanista e alla crisi dell’Umanesimo: Ariosto rappresenta ancora l’uomo nuovo che si pone al centro del mondo, il demiurgo che con l’arte plasma la realtà fantastica, ma non lo è nella sua vita sociale di umile cortigiano subordinato alla volontà di un signore. Opere Poesia lirica La produzione lirica di Ariosto viene suddivisa in due filoni: latino e volgare. Il primo degli anni della giovinezza comprende sessantasette opere ed ha importanza documentaria. Il secondo è formato da dieci opere originali ed importanti.Complessivamente la produzione lirica ariostesca comprende ottantasette componimenti (sonetti, madrigali, canzoni, egloghe e capitoli in terza rima). Le opere, non raccolte in un canzoniere organico, vennero pubblicate solo postume nel 1546. Ariosto viene influenzato dal modello petrarchesco riproposto dall’amico Pietro Bembo. Da questa scelta deriva la ricerca meticolosa del lessico e della metrica e la rilevanza del tema dell’amore.Risulta interessante la sua reinterpretazione umanistica. Mentre Bembo si discosta poco dai dettami petrarcheschi Ariosto li adatta ai canoni dell’Umanesimo, riferendosi costantemente ai classici latini come Tibullo, Properzio, Catullo e Orazio. Orlando furioso L’Orlando furioso è un poema cavalleresco in ottave, a schema ABABABCC, strutturato su 46 canti, per un totale di 38.736 versi nell’edizione definitiva del 1532. Vi sono state infatti due edizioni precedenti, scritte con una lingua più popolare e rozza. In particolare, una prima redazione dell’Orlando furioso, in 40 canti, era stata redatta nel 1515 e venne pubblicata nel 1516. La seconda edizione uscì nel 1521, caratterizzata da una lieve revisione linguistica.L’opera ha una trama molto stratificata che si sviluppa sostanzialmente su tre narrazioni principali: quella militare, costituita dalla guerra tra i paladini, difensori della religione cristiana, e i Saraceni infedeli; quella amorosa, incentrata sulla fuga di Angelica e sulla pazzia di Orlando, e infine quella encomiastica, con cui si lodava la grandezza dei duchi d’Este, dedicata invece alle vicende amorose tra la cristiana Bradamante e il saraceno Ruggiero.L’Orlando furioso si propone come il naturale prosieguo dell’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo; Ariosto continuò la narrazione proprio dove Boiardo la interruppe, facendo evolvere la vicenda amorosa tra Angelica e Orlando che, a causa del rifiuto dell’amata, diviene furioso, pazzo per amore.La lingua definitiva dell’Orlando furioso è ben diversa da quella delle edizioni precedenti. In principio il registro linguistico, ricco di termini toscani, padani e latineggianti, teneva conto delle espressività popolari, essendo più orientato a un pubblico ferrarese o padano. Fu solo dopo che Ariosto si rese conto della portata di capolavoro dell’opera si mirò a creare un modello linguistico italiano nazionale, secondo i canoni teorizzati da Pietro Bembo nelle sue Prose della volgar lingua. La revisione tuttavia non riguarda soltanto l’aspetto linguistico e stilistico, ma anche i contenuti: vi è l’aggiunta di diversi episodi significativi come quello di Olimpia (canti IX-XI) e soprattutto di Marganorre (XXXVII) fino a raggiungere l’attuale struttura di 46 canti. L’inserimento di questi episodi provocò anche una variazione degli equilibri strutturali. Infatti, l’episodio di Marganorre, feroce tiranno persecutore delle donne, funge da contrappeso a quello delle femmine omicide. Uno degli obiettivi di Ariosto è quello di invitare il lettore ad una riflessione sul reale. Uno dei procedimenti volti a questo è quello dello straniamento, che consiste in un cambiamento della prospettiva in modo da guardare l’argomento trattato con imparzialità, impedendo al lettore l’immedesimazione emotiva e invogliandolo ad un atteggiamento critico. Un simile effetto avviene soprattutto grazie all’intervento della voce narrante nel corso della narrazione. Ad esempio, nel I canto, quando Angelica afferma avanti a Sacripante di essere ancora vergine, la voce narrante commenta: «Forse era ver, ma non però credibile / a chi del senso suo fosse signore; / ma parve facilmente a lui possibile, / ch’era perduto in via più grave errore» Un commento del genere, inevitabilmente, costringe a riflettere sull’ambiguità dei personaggi e su ciò a cui si sta assistendo. Sempre volto alla riflessione sul reale, è il procedimento dell’abbassamento, consistente nell’abbassare appunto la dignità eroica dei suoi personaggi, riportandoli ad un livello comune e quotidiano. Evento maggiormente significativo è quando Orlando si rende conto dell’amore di Angelica con Medoro e il suo letto gli pare «più duro ch’un sasso, e più pungente / che se fosse d’urtica»: l’ortica ovviamente non rende grazie al personaggio di Orlando, tanto acclamato nella precedente generazione, ora viene, volutamente e non per semplice gioco parodico, svilito per riflettere sul comportamento degli uomini. Satire Le Satire sono l’opera ariostesca più apprezzata dalla storia dopo il Furioso. Si tratta di sette componimenti in terzine, scritti in forma di lettere indirizzate da Ariosto a parenti e amici realmente esistiti, plasmate secondo i canoni delle satire latine e in particolar modo secondo i canoni oraziani.I temi principali delle Satire riguardano la condizione dell’intellettuale cortigiano, il contrasto fra questa condizione e il desiderio di libertà personale, l’aspirazione ad una vita dedita allo studio lontana dall’avidità della corte e dalla corruzione della politica. L’atteggiamento di Ariosto è sì ironico, ma sempre pacato e tollerante, senza mai dar vita a situazioni polemiche. Questo non va confuso con un disinteresse nei confronti della realtà; al contrario, testimonia la sua capacità di osservazione, ottenuta dopo importanti esperienze personali in campo politico, seppur compiute controvoglia .Le Satire rappresentano in tutto e per tutto una pietra miliare della letteratura ariostesca e rinascimentale in genere, in quanto è apprezzabile quell’atteggiamento riflessivo, tanto caro ai letterati post 1494, che è sì presente anche nell’Orlando furioso, ma che appare in maniera più evidente grazie all’assenza della componente fiabesca e fantastica. Commedie * Di seguito vengono riportate le commedie prodotte da Ariosto: * La tragedia di Tisbe, perduta, 1493 (trattandosi di una tragedia di ispirazione ovidiana, sarebbe piuttosto da inserire in una più generica categoria dei testi drammatici); * La Cassaria, in prosa, 1508; * I Suppositi, in prosa, 1509; * Il Negromante, in versi, 1520; * La Lena, in versi, 1528; * Gli studenti, incompiuta, in versi, 1518-19. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Ariosto
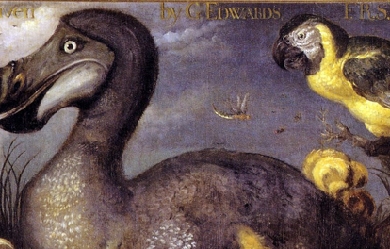
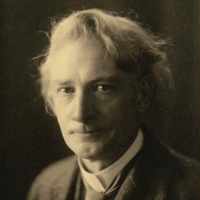
David McKee Wright (6 August 1869– 5 February 1928) was an Irish-born poet and journalist, active in New Zealand and Australia. Early life Wright was born at Ballynaskeagh, County Down, Ireland, the second son of Rev. William Wright, D.D. (1837-1899), a Congregational missionary working in Damascus, scholar and author, and his wife Ann (d.1877), née McKee, daughter of the Rev. David McKee, an educationist and author. David Wright was born while his parents were home on furlough and was left with a grandmother (Rebecca McKee) until he was seven years old. Wright was educated at the local Glascar School and then from 1876 in England at Mr Pope’s School and the Crystal Palace School of Engineering, London. New Zealand Wright migrated to New Zealand in 1887 and spent several years as a rabbiter on stations in Central Otago. During this time he wrote in both prose and verse for major provincial newspapers about station life. He studied for the Congregational ministry and Wright studied divinity from 1896 at the University of Otago. Wright had done a lot of private reading, but found that apart from English his education was generally below that of the other students. In 1897 Wright was awarded a Stuart prize for poetry. Wright published four volumes of ballads, Aorangi and other Verses (1896), Station Ballads and other Verses (1897), Wisps of Tussock (1900), and New Zealand Chimes (1900). As a clergyman Wright was liked, but he found the work uncongenial and gave it up for journalism in which he had considerable experience in New Zealand. Wright married Elizabeth Couper at Dunedin on 3 August 1899; a son David was born in 1900, but the marriage failed. Wright joined the New Zealand Mail as parliamentary reporter in 1907. Australia Wright moved to Sydney in 1910 and did a large amount of successful freelance work for the Sun, The Bulletin, and other papers. Wright was editor of the Red Page of The Bulletin 1916–1926 and encouraged many of the rising writers of the time, and continued to do a large amount of writing himself in both prose and verse. Much of this appeared over pen-names such as “Pat O’Maori” and “Mary McCommonwealth” and much was signed with his initials. As Wright grew older his mind turned more and more to the country of his birth, he published his most important volume, An Irish Heart (1918). In 1920 he was awarded the prize for the best poem in commemoration of the visit of the Prince of Wales, and in the same year the Rupert Brooke memorial prize for a long poem, “Gallipoli”. Neither of these poems has been published in book form. From 1912-18 Wright lived with the writer 'Margaret Fane’ (Beatrice Florence Osborne, 1887-1962) in Sydney; they had four sons. From 1918 Wright lived with Zora Cross in Greeanawn, Glenbrook, Blue Mountains. He died there on 5 February 1928. The couple had two daughters, Davidina Wright and April McKee Wright (also known as April Hersey), who went on to write at least one wartime thriller. Legacy Wright was a friend of Christopher Brennan, Randolph Bedford, Frank Morton and Henry Lawson. Though much of a Bohemian, something of the clergyman still clung to him. Zora Cross, in An Introduction to the Study of Australian Literature, gave him a high position among Australian poets. Charming though An Irish Heart may be, it is too derivative to be work of the highest kind. It is not a question of individual words or phrases, but rather of a man steeping himself in the modern Irish school of poetry, and with all the skill of his practised craftsmanship reproducing its spirit in another land. A large amount of his work, including some short plays, has never been collected. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/David_McKee_Wright
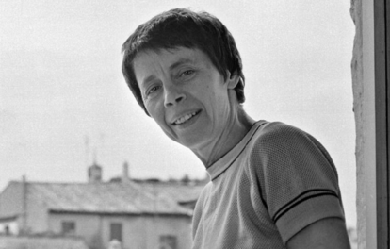

Amelia Rosselli (Parigi, 28 marzo 1930 – Roma, 11 febbraio 1996) è stata una poetessa, organista ed etnomusicologa italiana che ha fatto parte della “generazione degli anni trenta”, insieme ad alcuni dei più conosciuti nomi della letteratura italiana. Biografia Amelia Rosselli nacque a Parigi, figlia dell’esule antifascista Carlo Rosselli, teorico del Socialismo Liberale, e di Marion Cave, nata in Inghilterra e attivista del partito laburista britannico. Nel 1940, dopo l’assassinio del padre e dello zio, ordinato da Mussolini e Ciano, ad opera delle milizie fasciste (cagoulards) in Francia (1937), esulò con la famiglia, esperienza che determinò il carattere apolide e insieme personalissimo della sua opera. Amelia Rosselli si trasferì dapprima in Svizzera e quindi negli Stati Uniti. Compì all’estero (senza regolarità) studi letterari, filosofici e musicali, ultimandoli in Inghilterra, poiché in Italia, dove era tornata nel 1946, non le poterono essere riconosciuti. Negli anni quaranta e cinquanta si occupò di teoria musicale, etnomusicologia e composizione, trasponendo le sue ricerche in alcuni saggi. Nel 1948 cominciò a lavorare come traduttrice dall’inglese per alcune case editrici di Firenze e Roma e per la Rai; nel frattempo continuò a dedicarsi a studi letterari e filosofici. In questi anni cominciò a frequentare gli ambienti letterari romani (tramite gli amici Carlo Levi e Rocco Scotellaro, conosciuto nel 1950) e gli artisti che avrebbero successivamente dato vita all’avanguardia del Gruppo 63. Negli anni sessanta si iscrisse al PCI e cominciò a pubblicare i suoi testi principalmente su riviste, attirando l’attenzione di Zanzotto, Raboni e Pasolini. Nel 1963 pubblicò su Il Menabò ventiquattro poesie. L’anno successivo uscì la sua prima raccolta di poesie, Variazioni belliche, edita da Garzanti, e nel 1969 la raccolta Serie ospedaliera, comprensiva del poemetto di difficile gestazione e inedito La Libellula. Nel 1966 iniziò a pubblicare numerose recensioni letterarie su giornali come Paese Sera e L’Unità. Nel 1981 uscì Impromptu, un lungo poema diviso in tredici sezioni, e nel 1983 Appunti sparsi e persi, scritti tra il 1966 e il 1977. Notevole anche la sua ricerca plurilinguistica in poesia (poesie e prose giovanili in francese e in inglese, la successiva raccolta in inglese Sleep). Alcune prose italiane, autobiografiche, di vari periodi, furono raccolte e pubblicate nel 1990, con il titolo Diario ottuso. La morte della madre (avvenuta nel 1949) e altre drammatiche vicende biografiche le causarono ricorrenti esaurimenti nervosi. Non accettò mai la diagnosi di schizofrenia paranoide che le venne fornita da cliniche svizzere e inglesi, ma parlò per lo più di lesioni al sistema extrapiramidale, connesse alla malattia di Parkinson, che le si manifestarono già a 39 anni. È rimasta una figura di scrittrice unica per il suo plurilinguismo e per il tentativo di fondere l’uso della lingua con l’universalismo della musica. Ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Roma, nella sua casa a via del Corallo, dove è morta suicida l’11 febbraio 1996 per cause connesse ad una grave depressione. La data del suicidio segna forse volontariamente un nesso indelebile con quella di Sylvia Plath, autrice che la Rosselli tradusse e amò, dedicandole anche diverse pagine critiche. Su Amelia Rosselli e la sua poesia Elogio del fuoco davanti alla bara di Amelia Rosselli, Roma, Casa della cultura, 16 febbraio 1996Il fuoco riscalda. A leggere la poesia di Amelia, la temperatura del nostro corpo si altera un po’. Talvolta si abbassa, più spesso si innalza. E non diversi effetti scaturivano dall’ascolto, dalla sua viva voce di straordinaria lettrice. […] La sua voce era un basso profondo, una musica che faceva lievitare la fondamentale tra le parole rese singole e compenetrate le une nelle altre. […] Mai un grido nella sua recitazione, eppure quanti soprassalti nelle sue poesie! Per lei hanno nominato Campana, Rimbaud. Ma nulla le era più estraneo dello sregolamento dei sensi, dello sfrenato abbandonarsi all’altra voce che urge quando la ragione tace. In lei parlano entrambe, la ragione della mente e quella che piove dall’Altrove, ma in una educata, civilissima convivenza che non dimenticheremo mai. Il fuoco illumina. La poesia di Amelia Rosselli è oscura eppure chiarissima. Certo, bisogna abituarvisi, come quando si entra da fuori in una stanza buia. All’inizio avanziamo cautamente, abbiamo paura di farci male, urtiamo negli spigoli, imprechiamo. Ma poi diventiamo come i gatti che vedono anche nelle tenebre. Come loro impariamo a sviluppare sensi normalmente inerti, latenti. La sua forma di conoscenza è la Pietà, un grande canzoniere d’amore, senza tracce di narcisismo. […] Il fuoco scotta. Con la Storia che le ha marchiato i suoi segni sul corpo, prima ancora che nella mente. Dietro la sua poesia-amore avanzano la persecuzione politica, l’assassinio, la tragedia del conflitto più violento di un secolo ormai alla fine. La sua lingua, dissennatamente poliglotta, ne è stata disarticolata, ma quanto dilatata! Con Amelia se ne va l’ultima vittima di un secolo divoratore dei suoi poeti. Un’epoca che ostenta indifferenza verso la poesia e che continua a nutrirsene avidamente, cannibalisticamente. Marina Cvetaeva diceva che con la poesia bisogna comportarsi come con le creature amate. Si sta con loro finché non sono loro a lasciarci. E chi resta da solo con il dolore e il lutto non dimenticherà la gioia della dedizione fino al sacrificio finale.(Biancamaria Frabotta, Elogio del fuoco, in Quartetto per masse e voce sola, Roma, Donzelli, 2009, pp. 65-67)
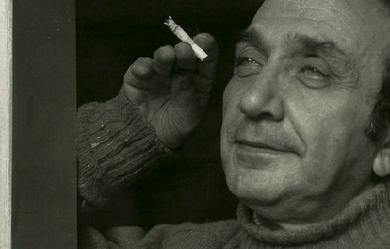
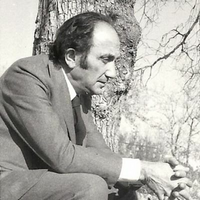
Alfonso Gatto (Salerno, 17 luglio 1909 – Orbetello, 8 marzo 1976) è stato un poeta e scrittore italiano. Biografia Nacque a Salerno il 17 luglio del 1909. La sua infanzia e la sua adolescenza furono piuttosto travagliate. Fratello del pittore Alessandro Gatto, compì i primi studi al liceo classico Torquato Tasso della sua città natale, mostrandosi portato per le materie letterarie, in particolare l’italiano, e poco incline alla matematica. Al liceo scoprì la propria passione per la poesia e la letteratura. Nel 1926 si iscrisse all’Università di Napoli che dovette tuttavia abbandonare qualche anno dopo a causa di difficoltà economiche. Sposò la figlia del suo professore di matematica, Agnese Jole Turco, con la quale, all’età di 21 anni, fuggì a Milano. Ebbero due figlie, Marina e Paola. Nel capoluogo lombardo, dove risiedette dal maggio del 1934, tra i suoi amici più assidui vi furono Cesare Zavattini, Alessandro Tofanelli, Leonardo Sinisgalli, Orazio Napoli e Domenico Cantatore, coi quali frequentava i caffè cittadini. La sua vita fu piuttosto irrequieta e movimentata, anche dal punto di vista lavorativo: dapprima commesso di libreria, poi istitutore di collegio, correttore di bozze, giornalista, insegnante. Nonostante nel 1935 avesse partecipato ai Littoriali della cultura e dell’arte dei Gruppi universitari fascisti, già nel 1936 fu arrestato per antifascismo e trascorse sei mesi nel carcere di San Vittore a Milano. Durante quegli anni Gatto collaborò ai più innovatori periodici e riviste di cultura letteraria (Italia letteraria, Rivista Letteratura, Circoli, Primato, Ruota). Nel 1938, con la collaborazione di Vasco Pratolini, fondò la rivista Campo di Marte per commissione dell’editore Vallecchi, ma il periodico durò un solo anno. Fu comunque questa una esperienza significativa per il poeta, che ebbe modo di cimentarsi nella letteratura militante di maggior impegno. Campo di Marte (il cui primo numero uscì il 1º agosto 1938) era nato come quindicinale di azione letteraria e artistica, con l’intento di educare il pubblico a comprendere la produzione artistica in tutti i suoi generi. La rivista si ricollegava al cosiddetto ermetismo fiorentino. Nel 1941 Gatto ricevette la nomina a ordinario di Letteratura italiana, per “chiara fama”, presso il Liceo Artistico di Bologna e iniziò pure una collaborazione con la rivista Primato di Giuseppe Bottai, sulla quale pubblicò con continuità poesie e recensioni letterarie. Nel 1944, iscrittosi al PCI, iniziò a collaborare a Rinascita e, dopo la liberazione di Milano, nell’aprile 1945, all’Unità.Fu poi inviato speciale de L’Unità assumendo una posizione di primo piano nella letteratura di ispirazione comunista. Nel 1951 si dimise dal partito e diventò un comunista “dissidente”. Il poeta, nel 1946, incontrerà la donna più importante della sua vita, la pittrice triestina Graziana Pentich per la quale abbandonò la moglie e le figlie e da cui ebbe due figli, Teodoro e Leone. La vita del poeta sarà segnata, nel 1963, dal dolore per la scomparsa di Teodoro, mentre Leone morirà soltanto tre mesi dopo la morte del poeta. L’8 marzo del 1976 Gatto si trovava a Grosseto e si mise in viaggio lungo l’Aurelia diretto a Roma, a bordo di una Mini Minor alla cui guida si trovava Paola Maria Minucci. L’auto finì fuori strada nei pressi della Torba di Capalbio e il poeta fu trasportato d’urgenza a Orbetello dove, per via delle condizioni ormai critiche, si decise di caricarlo sull’ambulanza in direzione dell’Ospedale di Grosseto. Alfonso Gatto spirò alle ore 16:10 mentre si trovava ancora a Orbetello. È sepolto nel cimitero di Salerno. Sulla sua tomba, che ha un macigno per lastrone, è inciso il commiato funebre dell’amico Eugenio Montale: Formazione e poetica L’ermetismo riconosce in Alfonso Gatto uno dei più accesi tra i suoi protagonisti. Non si sa molto dei suoi primi anni a Salerno, che tanta importanza hanno senza dubbio avuto nella sua formazione, come pure si ignorano le sue prime letture, i suoi primi incontri (tra gli altri, con il critico letterario Francesco Bruno, che lesse per primo e ordinò le sue poesie), le sue amicizie. Le notizie biografiche sono scarse e sono le solite: gli studi, l’arrivo all’Università non terminata, la vita irrequieta, i vari lavori intrapresi. Fa eccezione la notizia dell’uscita del suo primo volumetto nel 1932, Isola, nel quale i maggiori lettori del tempo riconobbero subito il segno di una voce nuova e vera. Quando nel 1932 Giuseppe Ungaretti pubblica Sentimento del tempo, Gatto, appena nato alla poesia, viene subito inserito nel capitolo di quel momento. Con Isola, Gatto inizia la sua esistenza di poeta e un discorso che si concluderà solamente con la sua tragica morte quarantaquattro anni dopo. Isola è il testo decisivo per il costituirsi di una “grammatica ermetica” che verrà definita dal poeta stesso come ricerca di «assolutezza naturale». Il linguaggio è rarefatto e senza tempo, allusivo, tipico di una poetica dell’"assenza" e dello spazio vuoto, ricco di motivi melodici. E saranno proprio il senso dello spazio e l’abbandono alla melodia gli elementi costanti di Isola, così come più tardi delle altre raccolte di poesie. Ad Isola segue Morto ai paesi, una quarantina di componimenti in versi. Non si evincono grandi differenze tematiche e stilistiche rispetto ad Isola, anzi vi è una comune evocazione di immagini plastiche, idilliache ed oniriche, e risalta il topos letterario della memoria. Alcune atmosfere e scelte lessicali suggeriscono stilemi petrarcheschi. Non è un caso che Giovanni Pozzi, ne La poesia italiana del Novecento, abbia incluso Alfonso Gatto tra i cosiddetti petrarchisti dell’ermetismo, data l’influenza del poeta proto-umanista sui filoni poetici della prima metà del XX secolo. Anche in Arie e ricordi, che rappresenta la prima stagione del poeta salernitano (1929-1941), le sue figurazioni ruotano intorno alla memoria, riaffiorano dalle inquietudini e dai sogni adolescenziali. La successiva produzione lirica risentirà dell’esperienza bellica. La morte, topos trasfigurato nei componimenti del passato, si disvela nelle sue connotazioni più drammatiche. Gatto si avvicina al dolore degli uomini e nella successiva raccolta, Il capo sulla neve, il poeta registra le esperienze degli anni 1943-1947. Nel 1950 Mondadori pubblica lo Specchio, volume che raccoglie le poesie scritte durante trentacinque anni di attività. La storia delle vittime in cui Gatto trasferì Amore della vita e Il capo sulla neve, arriva dopo il volume Poesie che raccoglie le liriche composte dal 1929 al 1941. Nello Specchio vengono incluse le Nuove poesie del 1950 in cui erano state inserite le liriche composte dal 1941 al 1949. Esse comprendevano sia i componimenti della Resistenza di matrice civile e politica, sia quelli concernenti la vita privata e l’esperienza amorosa di Gatto. In Poesie d’amore risulta marcata l’ispirazione al poeta Rimbaud, tanto amato dal Nostro. Ma la raccolta di poesie che ha attratto maggiormente l’attenzione della critica e dei lettori, è La forza degli occhi (1950-1953). In essa si fondono ermetismo e surrealismo. Questo volume segna la raggiunta maturità poetica di Gatto. La visionarietà diviene il mezzo espressivo capace di rivelare il talento del poeta. Alla raccolta Osteria flegrea, poesie composte dal 1954 al 1961, segue la raccolta più corposa della sua intera produzione, Rime di viaggio per la terra dipinta (1968-1969), rime scritte e raffigurate pittoricamente in acquarelli. In esse si coglie un “senso di insistito giuoco metrico-stilistico e dell’immaginazione (o piuttosto dell’intelletto) mentre un ruolo quasi secondario viene affidato al sentimento” Il motivo dell’amore Il motivo dell’amore è cantato in tutti i modi e percorso in ogni direzione e, anche se a tratti ha intonazioni classicheggianti, non perde mai il valore fonico della parola che diventa un momento a sé di suggestione. Nel periodo che va dal 1940 al 1941 vi è un rifacimento delle poesie precedenti che faranno parte di una raccolta edita da Vallecchi nel 1941 sotto il nome di Poesie che rimarranno immutate fino alla stesura del 1961 quando, dando un ordine maggiore allo stesso volume esse toccheranno il punto di maggiore "cantabilità" nella poesia di Gatto. Una delle immagini tra le più vive della poesia contemporanea possiamo trovarla nella poesia Oblio dove il poeta esprime la gioia della vita fatta memoria e festa alle quali egli sente di appartenere: Tutto si calma di memoria e resta il confine più dolce della terra, una lontana cupola di festaIn questi versi si assiste al dileguarsi dell’analogia stretta dei primi libri e in Amore della vita, il libro del 1944, il poeta riuscirà a esprimere una freschezza insolita in un momento di retorica dedicata alla Resistenza. Gatto, infatti, aderisce alla poesia della Resistenza, commosso dallo spirito civile e politico degli italiani e nella raccolta successiva, Il capo sulla neve, egli avrà parole di forte commozione per i “Martiri della Resistenza” ed esprimerà nelle poesie una assorta meditazione che ha il raro dono dell’immediatezza. Gatto è dunque un poeta di natura e d’istinto che ha conosciuto durante la guerra e nel dopoguerra un serio rinnovamento sia nei contenuti che nella forma aprendosi a strutture narrative più complesse che fondono autobiografismo lirico e partecipazione storica. Nello scorrere l’ultima produzione di Gatto, Rime di viaggio per una terra dipinta, e Desinenze, opera postuma uscita un anno dopo la sua morte, resta l’immagine di un poeta coinvolto dal tumulto della vita, ma sempre lieto di fissare nella memoria ogni emozione in una lingua ricca di motivi e di sorprese nuove. L’esperienza milanese Alfonso Gatto appartiene a quel folto gruppo di intellettuali provenienti dal Sud Italia, tra i quali il celebre critico d’arte Edoardo Persico ed Elio Vittorini, che negli anni trenta, giunsero a Milano, una Milano centripeta, punto di confluenza delle intelligenze più fervide dell’epoca. Dal 1936 al 1938 Gatto collaborò al periodico Casabella con una serie di articoli nella rubrica Cronaca dell’architettura; egli partiva dai temi concernenti l’architettura per poi trattare di argomenti di cultura generale, mentre gli articoli di fondo erano tenuti da Giuseppe Pagano. Edoardo Persico fu una figura importantissima nella vita del poeta salernitano, e, quando morì, nel 1945, lasciò un patrimonio di idee nuove e illuminanti di cui faranno tesoro Raffaello Giolli e Alfonso Gatto. Infatti, entrambi tentarono di sviluppare e fissare, quella relazione artistica che Persico aveva instaurato tra Frank Lloyd Wright e Paul Cézanne, vale a dire, una palese identificazione tra architettura organica e impressionismo. La ricerca intellettuale di Gatto lo condurrà a scrivere Prefazione a Frank Lloyd Wright, Architettura organica in cui Gatto intesse una immagine di Wright come architetto-poeta o, per usare un’espressione con cui lo stesso architetto statunitense aveva intitolato una sua opera, come “Disconosciuto legislatore del mondo”. "Wright è più di un architetto", scrive Gatto, “gli si deve riconoscere una statura di creatore– l’unica di architetto che oggi ci sia nel mondo– congiunta ad un’effettiva forza di tecnico e ad una ispirata passione umanitaria”. Alfonso Gatto pittore e critico d’arte La profonda sete di conoscenza condusse il poeta a soddisfare la propria attitudine alla pittura, con la realizzazione di vari acquerelli e disegni, nonché alla elaborazione di numerosissimi Cataloghi per pittori di grande caratura, come Ottone Rosai, Renato Guttuso, Filippo de Pisis, Giuseppe Zigaina, Mino Maccari, Corrado Cagli. La compagna Graziana Pentich, ha raccolto negli anni Novanta, in un volume intitolato “I colori di una storia”, disegni, dipinti poesie di Gatto, unitamente alle sue opere di pittura e ai teneri disegni e acquerelli del figlioletto Leone. In esso è scandita la storia di una vita in cui l’arte risulta essere il linguaggio quotidiano più congeniale ad esprimere e raccontare le esperienze dei tre protagonisti, dalla nascita alle prime parole di Leone, ai continui spostamenti fisici del poeta, il quale incorpora l’una dentro l’altra le città conosciute lungo il cammino in un’unica grande città che ha l’anima del Sud. Nel racconto sono molti gli autoritratti del poeta, realizzati tra il 1946 e il 1958, da lui stesso definiti “autoritratti-maschera”: l’autoritratto sul giornale Avanti!, quello al Craja (il caffè milanese, ritrovo di artisti e intellettuali negli anni Trenta e Quaranta, situato in Piazzetta Filodrammatici vicino al Teatro alla Scala) e i tre autoritratti detti “auto istantanee”, dove Gatto si raffigurò come un clown. La Pentich parla a tal proposito di una “coincidenza di sentimenti con i temi circensi sublimati da Picasso nelle figure del suo periodo blu e rosa”. L’eclettismo di Gatto è anche il risultato della sua personale concezione delle Arte, concezione per certi versi rinascimentale, in contrasto con quella a lui contemporanea che voleva la separazione tra i vari ambiti artistici. Opere principali Poesia Isola, Napoli 1932 Morto ai paesi, Modena 1937 Poesie, Milano 1939 (nuova edizione, Firenze 1943) L’allodola, Milano 1943 La spiaggia dei poveri, Milano 1944 Amore della vita, Milano 1944 La spiaggia dei poveri, Milano 1944 (nuova edizione Salerno 1996) Il sigaro di fuoco. Poesie per bambini, Milano 1945 Il capo sulla neve, Milano 1947 Nuove poesie 1941-49, Milano 1949 La forza degli occhi, Milano 1954 La madre e la morte, Galatina 1959 Poesie 1929-41, Milano 1961 Osteria flegrea, Milano 1962 Il vaporetto. Poesie, fiabe, rime, ballate per i bambini di ogni età, Milano 1963 (nuove edizioni Salerno 1994 e Milano 2001) La storia delle vittime, Milano 1966 Rime di viaggio per la terra dipinta, Milano 1969 Poesie 1929-69, Milano 1972 Poesie d’amore (1941-49; 1960-72), Collezione Specchio, Milano, Mondadori, 1973, ISBN 978-88-04-10585-5. Lapide 1975 ed altre cose, Genova, San Marco dei Giustiniani, 1976. Desinenze, Milano 1977 Poesie, a cura di F. Napoli, Milano, Jaca Book, 1998, ISBN 978-88-16-52009-7. Tutte le poesie, a cura di Silvio Ramat, Collana Oscar grandi classici n.103, Milano, Mondadori, 2005, ISBN 978-88-04-53347-4. Tutte le poesie (nuova edizione ampliata), a cura di Silvio Ramat, Collana Oscar moderni n.103, Milano, Mondadori, 2017, ISBN 978-88-04-65960-0. Prosa La sposa bambina, Firenze, 1943; nuova ed., Firenze 1963; Salerno, Roma, 1994 La coda di paglia, Milano, 1948; nuova edizione, Salerno, Roma, 1995 Carlomagno nella grotta. Questioni meridionali, Milano, 1962; nuov ed., Firenze 1974 (come Napoli N.N.); Salerno, 1993 Le ore piccole (note e noterelle), Salerno, 1975 Parole a un pubblico immaginario e altre prose, Pistoia, 1996 Il signor Mezzogiorno, Napoli, 1996 Il pallone rosso di Golia. Prose disperse e rare e l’inedito «Bagaglio presso», Milano, 1997 L’aria e altre prose, Pistoia, 2000 Diario d’un poeta, Napoli, 2001 La pecora nera, Napoli, 2001 La palla al balzo– un poeta allo stadio, Limina, 2006 Pensieri, a cura di F. Sanguineti, Torino, Nino Aragno, 2016 Teatro Il duello, Milano 1944; nuova ed., Salerno, 1995 Filmografia Alfonso Gatto ha anche avuto diverse parti in alcuni film. In Il sole sorge ancora (1946) di Aldo Vergano aveva la parte di un conduttore di treni. Altre parti ha avuto in due film di Pier Paolo Pasolini: in Il Vangelo secondo Matteo (1964) recitava la parte dell’apostolo Andrea, in Teorema (1968) la parte di un dottore. Altre parti ha avuto in Cadaveri eccellenti (1976) di Francesco Rosi dove era Nocio e in Caro Michele (1976), di Mario Monicelli, tratto dall’omonimo romanzo di Natalia Ginzburg, dove interpretava il padre di Michele. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Gatto
.jpg?locale=fr)
Rafael María Baralt (Maracaibo, Venezuela, 3 de julio de 1810 – Madrid, España, 4 de enero de 1860), fue un escritor, periodista, Ingeniero (el primero egresado de la Academia Militar de Matemáticas en 1836) historiador, filólogo, crítico y poeta venezolano, autor del primer diccionario de galicismos del español, y primer latinoamericano en ocupar un sillón en la Real Academia Española. Su nacimiento ocurrió en medio del movimiento de independencia de Venezuela. Debido a las vicisitudes políticas de aquel tiempo de guerras, la familia Baralt Pérez se trasladó a Santo Domingo, donde transcurrió la mayor parte de su infancia.

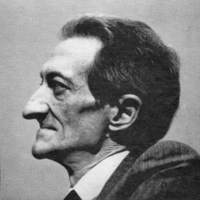
Edoardo Sanguineti (Genova, 9 dicembre 1930 – Genova, 18 maggio 2010) è stato un poeta, scrittore e politico italiano, che fece parte del Gruppo 63. Biografia Figlio unico di Giovanni, impiegato di banca nato a Chiavari, e di Giuseppina Cocchi, torinese, si trasferì all’età di quattro anni a Torino, città nella quale il padre aveva trovato un nuovo impiego come amministratore cassiere presso la tipografia Doyen & Marchisio. Era ancora bambino quando, durante una normale visita di controllo, gli venne diagnosticata una grave malattia cardiaca. La diagnosi si rivelò in seguito errata ma questo episodio ha condizionato per lungo tempo lo stile di vita del poeta.A Torino abitava uno zio di Edoardo, Luigi Cocchi, musicista e musicologo, che aveva conosciuto Gobetti e Gramsci e aveva collaborato alla rivista L’Ordine Nuovo e che sarebbe stato il primo punto di riferimento per la formazione del giovane. A Bordighera, dove il giovane trascorreva le vacanze estive, Edoardo frequentava il cugino Angelo Cervetto, appassionato di musica che gli trasmette la passione per il jazz, e Guido Seborga, che lo inizia alla lettura di Artaud. Nel frattempo, in seguito alla pertosse che aveva contratto, il giovanissimo Edoardo venne visitato da uno specialista che individuò l’errore diagnostico del quale era stato vittima. Edoardo era sanissimo ma da quel momento dovette fare intensi esercizi fisici per recuperare il tono muscolare. Ginnastica, ciclismo, tennis furono da quel momento gli sport che avrebbe dovuto intensamente affiancare allo studio, anche se dovette rinunciare alla sua primaria ispirazione: quella di dedicarsi alla danza. 1946-1955: studi, elaborazione di Laborintus, primi contatti culturali Nel 1946 Edoardo s’iscrisse al Liceo classico Massimo d’Azeglio ed ebbe come insegnante d’italiano Luigi Vigliani. A lui avrebbe dedicato il saggio su Gozzano e gli avrebbe fatto leggere alcune poesie che saranno in seguito parte di Laborintus. In terza liceo, Sanguineti ebbe come docente di storia e filosofia Albino Galvano, pittore, critico, storico d’arte, filosofo amante della psicanalisi e interessato alle avanguardie. Successivamente s’iscrisse alla facoltà di Lettere dell’Università di Torino. In questi anni il giovane frequentò il mondo culturale torinese, recandosi a mostre ed ascoltando concerti. Conobbe la pittrice dell’avanguardia Carol Rama, il filologo classico Vincenzo Ciaffi, lo studioso di lingue e culture germaniche Vittorio Amoretti e il romanziere Seborga che frequentava anch’egli a Bordighera e che l’avrebbe indirizzato alle letture di Artaud. Nel 1951 Sanguineti iniziò a scrivere l’opera che si chiamerà “Laborintus” e, come egli stesso dice nei Santi Anarchici, scriveva per una piccola comunità di lettori: “Eravamo in cinque. E i miei quattro lettori erano una ragazza, un aspirante filologo classico e due altri studenti, uno di farmacia e l’altro di medicina”. Conobbe intanto Enrico Baj che avrebbe creato il manifesto della pittura nucleare e dà vita al Nuclearismo. Il 1953 è l’anno della morte della madre ma anche quello dell’incontro con Luciana che avrebbe sposata il 30 settembre del 1954. Sempre nel 1954, in occasione della recensione di Sanguineti sulla rivista torinese “Galleria” dell’Antologia critica del Novecento, conobbe Luciano Anceschi che, dopo aver letto Laborintus, decise di darlo alle stampe. Alcune poesie di Laborintus erano intanto apparse su “Numero”, una rivista fiorentina diretta da Fiamma Vigo, alla quale era stato invitato a collaborare da Gianni Bertini, un pittore pisano incontrato da Sanguineti nello studio di Albino Galvano. Nel 1955 nacque il primo figlio dello scrittore: Federico. 1956-1960: pubblicazione di Laborintus, laurea e carriera universitaria Il 1956 fu l’anno della pubblicazione, a cura di Luciano Anceschi, di Laborintus e anche l’anno della laurea. Sanguineti il 30 ottobre discusse una tesi su Dante col professor Giovanni Getto, la quale venne pubblicata nel 1961 col titolo Interpretazione di Malebolge. Nasceva in quel periodo «Il Verri» redatto da Pagliarani e da Porta al quale Sanguineti collaborò intensamente. Il 1º novembre 1957 Sanguineti si offrì come assistente volontario presso la cattedra di Getto, insegnando contemporaneamente italiano nel triennio del liceo classico di un istituto privato diretto da suore domenicane. Nel 1958 nasceva il suo secondo figlio: Alessandro. 1961-1965: i Novissimi e la libera docenza Risale al 1961 la conoscenza da parte del poeta di Luciano Berio che gli chiese di collaborare per la Piccola Scala con un’anti-opera. Nascerà da questa collaborazione Passaggio che verrà rappresentato nel 1963. Sempre nel 1961 uscì l’antologia dei Novissimi con prefazione di Giuliani che comprende le opere di Giuliani stesso, di Sanguineti, di Pagliarani, di Balestrini e di Porta. Nasceva nel 1962 il terzo figlio, Michele e nel 1963 si istituì il Gruppo 63 a Palermo che sarà “il risultato dei legami e dei contatti culturali maturati nei precedenti anni”.Nel frattempo Sanguineti, che era diventato assistente incaricato e in seguito assistente ordinario del professor Giovanni Getto, nel 1963 consegue la libera docenza e ha come presidente di commissione Mario Fubini. In questo periodo frequenterà, in tre occasioni, anche le Décades di Cerisy: la prima volta invitato da Ungaretti, al quale era dedicato il convegno, la seconda volta invitato dal gruppo di Tel Quel, per il romanzo sperimentale e, alla fine degli anni sessanta, per il cinema. Nel 1965 otterrà una cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso la facoltà di lettere dell’università di Torino. 1968-1974: cambiamenti Nel 1968 si sciolse il Gruppo 63 (e nel '69 termineranno anche le pubblicazioni della rivista “Quindici”). Nello stesso anno Sanguineti si candidò alle elezioni per la Camera nelle liste del PCI ma deve trasferirsi a Salerno con la famiglia come incaricato all’università. A Salerno Sanguineti terrà due corsi, quello di Letteratura italiana generale e quello di Letteratura italiana contemporanea e nel 1970 diventerà professore straordinario. Nel 1971 il poeta visse durante sei mesi a Berlino con la famiglia, nel 1972 morì il padre, nel 1973 nasceva la figlia Giulia e Sanguineti diventò, sempre a Salerno, professore ordinario. Nello stesso anno iniziò la collaborazione a “Paese Sera”. Nel 1974 ottenne una cattedra di Letteratura italiana presso l’Università di Genova, per stare accanto ai compagni proletari si trasferisce al CIGE del Begato con la famiglia e nel 1975 inizia a collaborare con il “Giorno”. 1976-1980: gli anni dell’impegno politico Nel 1976 Sanguineti iniziò a collaborare con l’Unità, e nel 1980 con Il Lavoro di Genova. Furono questi anni di grande impegno politico: venne infatti eletto consigliere comunale a Genova (1976– 1981) e deputato della Camera (1979– 1983), come indipendente nelle liste del PCI. 1981-2005: i viaggi, gli onori Dal 1981 al 1983 diresse la prestigiosa rivista Cervo Volante assieme ad Achille Bonito Oliva. In redazioni ebbe giovanissimi poeti di talento come Valerio Magrelli, Nel 1990 fondò, con Nadia Cavalera, la rivista internazionale “Bollettario. Quadrimestrale di scrittura e critica”. La diresse durante vent’anni, fino alla sua morte (nel 2010). In redazione ebbe Filippo Bettini, Francesco Muzzioli, Marcello Frixione, e Tommaso Ottonieri. Collaboratori i maggiori autori del tempo. Numerosi furono i viaggi fatti in questo periodo sia in Europa che fuori dell’Europa (Unione Sovietica, Georgia e Uzbekistan, Tunisia, Cina, Stati Uniti, Canada, Messico, Colombia, Argentina, Perù, Giappone, India). Nel 1996 venne nominato dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di gran merito della Repubblica Italiana. Sanguineti, che aveva lasciato nel 2000 l’Università e aveva ricevuto numerosi premi letterari tra i quali la Corona d’oro di Struga, il Premio Capri dell’Enigma (1998), fu membro e fondatore della “Accadémie Européenne de poésie” (Lussemburgo) e membro consulente del “Poetry International” (Rotterdam). Precedentemente Faraone poetico dell’Istituto Patafisico di Milano, dal 2001 è Satrapo Trascendentale, Gran Maestro O.G.G. (Parigi) e presidente dell’OpLePo. 2006-2010: Gli ultimi anni Nel 2006, nel corso di un suo intervento al Festival dei Saperi di Pavia ebbe a dire che "quaranta ragazzetti innamorati del mito occidentale e assetati di Coca-Cola hanno fatto più rumore di migliaia di operai massacrati in Cile" e che "non si sa esattamente quanta gente sia stata uccisa dalle forze del governo e dei militari durante i 17 anni durante i quali Pinochet rimase al potere, ma la Commissione Rettig elencò 2.095 morti e 1.102 “scomparsi”. Sanguineti– a cui il 5 giugno 2006 venne assegnato il Premio Librex Montale– diventò presidente onorario dell’associazione politica Unione a Sinistra e fu candidato alle primarie dell’Unione per l’elezione del sindaco di Genova, tenutesi il 4 febbraio 2007, sostenuto da: Partito dei Comunisti Italiani, Partito della Rifondazione Comunista e Unione a Sinistra, ottenne il 14% dei voti. Le primarie furono vinte da Marta Vincenzi, candidata de L’Ulivo (60%). Secondo arrivò Stefano Zara. Il 18 maggio 2010 fu ricoverato d’urgenza a causa di un aneurisma che provocava da diversi giorni fitte all’addome. Alle 13:30 Sanguineti morì, all’età di 79 anni, ancora in sala operatoria. La procura aprì un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Il 22 maggio venne sepolto nel pantheon del cimitero monumentale di Staglieno, accanto alla tomba in cui riposa il capo-partigiano Aldo Gastaldi “Bisagno”. Edoardo Sanguineti era ateo. Il poeta Laborintus: sperimentalismo e disgregazione del linguaggio La prima pubblicazione di Laborintus, nel 1956, nella collezione “Oggetto e simbolo” diretta da Luciano Anceschi per la casa editrice Magenta, passa quasi inosservata. Le sue poesie, ritenute così difficili da interpretare, sarebbero divenute, solo un decennio dopo, norma per le sperimentazioni linguistiche-poetiche degli anni sessanta. Il titolo, nato dall’utilizzo di uno schema labirintico, deriva secondo Risso anche dalla "complessità della realtà atomica di quegli anni, i cui esiti potevano davvero essere benjaminianamente catastrofici"Pasolini in un articolo su “Il Punto” definisce la raccolta Laborintus “un tipico prodotto del neo-realismo post-ermetico” al quale Sanguineti replica sul n. 11 di “Officina” nel novembre del 1957 con un articolo intitolato Una polemica in prosa ironizzando sulle giuste distanze che Pasolini metteva tra il proprio “sperimentalismo” e quello “non puro sperimentalismo sanguinetiano”. La questione verrà ripresa da Luciano Anceschi sulla rivista Il Verri nel 1960 con questa affermazione:"Accade in questi anni– e vogliamo mettere come data di inizio del movimento il 1956?– nel nostro paese qualche cosa di naturale, di prevedibile, di necessario: nasce probabilmente una nuova generazione letteraria"'. Laborintus è infatti un testo di riferimento centrale per lo sperimentalismo degli anni sessanta soprattutto se confrontato con la poesia del suo tempo. Esso infatti si presenta come qualcosa di nuovo che apre soluzioni linguistiche e formali sconosciute a quella poesia che, nella seconda metà degli anni cinquanta, dopo lo spegnersi del neorealismo si stava orientando verso l’antinovecentismo introdotto all’interno della rivista “Officina”. Sanguineti, nel programma della neoavanguardia, è figura centrale per il suo poundismo, per i richiami psicoanalitici dei suoi testi, per il suo plurilinguismo e per quel verso pronto a dilatarsi in "un recitativo drammatico dove la soluzione metrica è rigorosamente atonale e, si potrebbe dire, gestuale", come scriveva Alfredo Giuliani. La poesia di Laborintus sembra, con la sua accentuata disgregazione dei linguaggi, rifarsi alle esperienze musicali di Luciano Berio o di John Cage e, nell’ambito pittorico, all’informale Jackson Pollock, Jean Fautrier o Mark Rothko. La tecnica dell’assemblage La tecnica dell’assemblage, utilizzata nella poesia di Sanguineti, è presa dall’ambito pittorico e gli oggetti– segni, tolti dallo spazio in cui erano collocati, acquistano improvvisamente la loro piena autonomia, ingrandendosi a dismisura. Dall’intellettualismo alla concretezza della quotidianità Sanguineti prosegue, dopo Laborintus, con lo stesso stile ipercolto e scrive, tra il 1956 e il 1959 le poesie di tema erotico che vanno sotto il nome Erotopaegnia, poi, tra il 1960 e il 1963, Purgatorio de l’Inferno e nel 1964 raccoglie, sotto il titolo di Triperuno, le precedenti sequenze precedute da Laborintus. Ma in queste poesie già si possono notare dei movimenti verso una scrittura che si sposta dall’intellettualismo dei primi esordi alla concretezza delle cose quotidiane e che, in alcuni punti, si aprono al diarismo dei successivi libri. Nuove raccolte Nella seconda raccolta del 1972, Wirrwarr (confusione) che si compone di due parti, “Testo di appercezione tematica” (1966– 1968) e “Reisebilder” (immagini di viaggio) (1971), il poeta pur continuando l’opera di destrutturazione del linguaggio che aveva iniziato con Triperuno, cerca di recuperare le cose autentiche del reale e del vissuto. Lo stile si fa più discorsivo e comunicativo, carattere questo che si ritrova nelle sue seguenti raccolte Postkarten (cartoline postali) del 1978, Stracciafoglio del 1980 e Scartabello del 1981 dove si impone un linguaggio più articolato che gioca su un registro parodico-ironico e si applica alle piccole cose della vita quotidiana. In queste raccolte l’avanguardia di Sanguineti, pur senza contraddirsi o negarsi, non appare, paradossalmente, lontana da situazioni come quelle di Giudici o Montale in opere come La vita in versi e Satura. La periodicità delle raccolte Periodicamente Sanguineti raccoglie i suoi versi in volumi riassuntivi, come Catamerone del 1974, ripreso nel 1982 in Segnalibro dove la sperimentazione si riappropria dell’uso della forma tradizionale per approdare, nel 1986, a Novissimum Testamentum, poi incluso in Senzatitolo nel 1992. In queste opere il poeta si impegna, confermando così la sua attenta ricerca metrica, sull’ottava, sulla canzonetta, sul sonetto intervallandoli con componimenti dal tipico verso extra-lungo che sembra scivolare via e “frantumarsi”. Nel 1987 esce la raccolta Bisbidis che costituisce un capitolo aggiuntivo nella linea iniziata con Wirrwarr. Il titolo, che è ripreso da una frottola del poeta Immanuel Romano (contemporaneo di Dante), è una voce onomatopeica che indica il chiacchierio di gente e appare come poesia di carattere colloquiale quasi crepuscolare che conferma quella linea poetica iniziata negli anni Settanta. Del 2002 è la raccolta Gatto Lupesco che contiene Bisbidis, Senzatitolo, Corollario, la versione definitiva di Cose, e una sezione di poesie intitolate Poesie fuggitive. Cinquant’anni di poesia Del 2004 è la raccolta antologica Mikrokosmos Poesie 1951-2004 che si presenta divisa in due parti. La prima parte comprende una scelta di Laborintus, di Erotopaegnia, di Purgatorio de l’Inferno, di T.A.T., di Reisebilder, di Postkarten, di Stracciafoglio, di Scartabello, di Cataletto, di Codicillo, di Rebus, di Glosse, di Corollario e di Cose. La seconda parte comprende una selezione da Fuori Catalogo, da L’ultima passeggiata, omaggio a Pascoli, da Alfabeto apocalittico, da Novissimum Testamentum, da Ecfrasi, da Mauritshuis, da Ballate, da Fanerografie, da Omaggio a Catullo, da Stravaganze, da Poesie fuggitive, da Varie ed eventuali. Il narratore Anche nel romanzo Sanguineti dedica molta attenzione al trattamento del linguaggio, tanto sul piano lessicale quanto su quello sintattico e sia nel romanzo Capriccio italiano, pubblicato nel 1963, e Il gioco dell’Oca del 1967 si avverte il piacere ludico della parola. La sua produzione narrativa è stata raccolta in “Smorfie”, contenente i due romanzi oltre ad altri testi in prosa. Ed è con Capriccio italiano che lo scrittore si fa portavoce del romanzo sperimentale mostrando la crisi del romanzo tradizionale giocando sui motivi dell’inconscio, dell’onirico e del biologico– sessuale.Il tema centrale del romanzo si basa sulla gravidanza della moglie del narratore e l’attesa del figlio ed è trattato non in modo naturalistico ma come una prova che, attraverso brevi episodi simili ad un sogno, smuovono gli strati dell’inconscio. Il critico L’attività critica di Sanguineti si è svolta inizialmente all’interno dell’ambito accademico: a lui si devono brillanti lavori su Dante ("Dante reazionario") e un’articolata analisi sui nessi tra poesia crepuscolare e liberty, in cui si rintraccia l’origine della poesia italiana del Novecento nella reazione ironica operata dai poeti crepuscolari ai danni dell’estetizzazione liberty, a partire dalla necessità, poi riconosciuta da Eugenio Montale, di “attraversare D’Annunzio”. Esemplificazione e concretizzazione di tale linea critica è l’antologia Poesia italiana del Novecento, la cui agile premessa mostra la rispondenza tra connotazione stilistico-linguistica e connotazione ideologico-psicologica degli autori. (Ideologia e linguaggio sono interfacce di solito coerentemente operanti, come Sanguineti chiarisce più in dettaglio nello studio Ideologia e linguaggio). L’antologia è, dunque, già per sé stessa, saggio critico, per la scelta degli autori e soprattutto dei singoli testi, con attenzione a quelli significativi di posizioni ideologiche e di sperimentalismo linguistico. Opere Poesie * Laborintus, Varese, Magenta, 1956. * Opus metricum, Milano, Rusconi e Paolazzi, 1960. (contiene Laborintus ed Erotopaegnia) * Triperuno, Milano, Feltrinelli, 1964. (contiene Opus metricum e Purgatorio de l’Inferno) * T.A.T., Verona, Sommaruga, 1968. (con litografie e acqueforti di Gianfranco Baruchello) * Renga (scrittura poetica collettiva in collaborazione con O. Paz, J. Roubaud e C. Tomlison), Parigi, Gallimard, 1971. * Wirrwarr, Milano, Feltrinelli, 1972. (contiene T.A.T. e Reisebilder) * Catamerone, Milano, Feltrinelli, 1974. (contiene Triperuno e Wirrwarr) * Omaggio a Emilio Vedova, Milano, Galleria Rizzardi, 1974. (con fogli grafici di Emilio Vedova) * Postkarten, Milano, Feltrinelli, 1978. * Stracciafoglio, Milano, Feltrinelli, 1980. (in appendice Fuori Catalogo, che raccoglie poesie d’occasione scritte tra il 1957 e il 1979) * Fame di tonno. Pastelli e poesie, s.l., Calcografica Studio, 1981. (con pastelli di Luca Alinari) * Scartabello, Macerata, Cristoforo Colombo libraio, 1981. (con dieci disegni di Valeriano Trubbiani) * Re-spira, Milano, Zarathustra, 1982. (con sette acqueforti a colori di Antonio Papasso) * Segnalibro, Milano, Feltrinelli, 1982. (contiene Camerone, Postkarten, Stracciafoglio, Scartabello e Cataletto) * Codicillo 1982, Cernusco sul Naviglio, Severgnini stamperia d’arte, 1983. * Due Ballate, Genova, Pirella Editore, 1984. * Alfabeto apocalittico. 21 ottave con un’acquaforte e 21 capilettera, Milano, Galleria Rizzardi, 1984. (con un’acquaforte e ventun capilettera di Enrico Baj) * Rebus, Modena, Telai del Bernini, 1984. (con una tavola di Carlo Cremaschi) * Omaggio a Pascoli. L’ultima passeggiata, Roma, Il Ventaglio, 1985. * Quintine, Roma, Carte segrete-Rossi & Spera, 1985. (in collaborazione con Salvatore Paladino) * Novissimum Testamentum, Lecce, Manni, 1986. * Promemoria-Pro/memoria, 1992. (tre acqueforti a colori di Antonio Papasso) * Bisbidis, Milano, Feltrinelli, 1987. ISBN 88-07-05050-1. (contiene Codicillo, Rebus, L’ultima passeggiata e Alfabeto apocalittico) * Senzatitolo, Milano, Feltrinelli, 1992. ISBN 88-07-05084-6. (contiene Glosse, Novissimum Testamentum e una serie di poesie “extravaganti” composte tra il 1982 e il 1991) * Malebolge 1994/1995, o Del malgoverno. Da Berluskaiser a Berluscaos, con Enrico Baj, Castel Maggiore, Book editore, 1995. ISBN 88-7232-208-1. * Libretto. 17 poesie 1992-1995, Genova, Pirella, 1995. ISBN 88-85514-44-8. (pubblicazione in occasione dell’incontro sul Manifesto dell’antilibro, Acquasanta, novembre 1995, con disegni di Mario Persico) * Quattro Haiku, Agromonte-Napoli, Ogopogo-ETRA/ARTE, 1995. (con disegni di Cosimo Budetta e una nota introduttiva di Stefano Bartezzaghi) Corollario 1996, Lecce, Manni, 1996. (pubblicazione in occasione della manifestazione “L’olio della poesia. Incontro con Edoardo Sanguineti” promossa dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Carpignano Salentino, 25 luglio 1996, contiene cinque poesie) * Rebus, Como, Lythos, 1996. (cinque poesie con litografie di Ico Parisi) * Corollario, Milano, Feltrinelli, 1997. ISBN 88-07-42078-3. * Taccuinetto, Milano, Giorgio Upiglio, 1998. (tre poesie, con tre incisioni di Cristiana Isoleri e una nota di Roberto Sanesi) * Corto, Prato, Canopo, 1998. (dieci poesie, con dodici collage di Marco Nereo Rotelli) * Wunderkammer, Roma, Il Bulino, 1998. (sette poesie, con una puntasecca a colori di Tommaso Cascella) * Sulphitarie, Napoli, Terra del Fuoco, 1999. (con Carmine Lubrano, fotografie di Peppe Del Rossi) * Cose, Napoli, Pironti, 1999. ISBN 88-7937-217-3. (con introduzione di Fausto Curi e postfazione di Ciro Vitiello) * Pensierini per Papasso, 1999. (lettura poetica dei Papiers Froissés di Antonio Papasso, Sala Consigliare Comune di Bracciano Il gatto lupesco. Poesie (1982-2001), Milano, Feltrinelli, 2002. ISBN 88-07-53005-8. (contiene Bisbidis, Senzatitolo, Corollario, la versione completa di Cose e una sezione di poesie extravaganti intitolate Poesie Fuggitive, un nuovo Fuori Catalogo) * Omaggio a Goethe, Bellinzona, Edizioni Sottoscala, 2003. (con disegni di Mario Persico) * Omaggio a Shakespeare. Nove sonetti, Lecce, Manni, 2004. ISBN 88-8176-503-9. (con disegni di Mario Persico e con un saggio di Niva Lorenzini) * Mikrokosmos. Poesie 1951-2004, Milano, Feltrinelli, 2004. ISBN 88-07-81823-X. * Il sonetto del foglio volante, 2006. (poesia dedicata all’opera di Antonio Papasso e contenuta nel film Elogio del leggero di Riccardo Barletta) * Capriccio oplepiano. Pretesti, in “Biblioteca Opleopiana”, n. 30, Edizioni Oplepo, 2010. * Varie ed eventuali. Poesie 1995-2010, Milano, Feltrinelli, 2010. ISBN 978-88-07-42129-7. Romanzi e racconti * Capriccio italiano, Milano, Feltrinelli, 1963. * Il giuoco dell’oca, Milano, Feltrinelli, 1967. * Il giuoco del Satyricon. Un’imitazione da Petronio, Torino, Einaudi, 1970. * Smorfie, Roma, Etrusculudens, 1986. * L’orologio astronomico, Illkirch, Le Verger, 2002. ISBN 2845740174. * Smorfie. Romanzi e racconti, Milano, Feltrinelli, 2007. ISBN 978-88-07-01725-4. Teatro, testi per musica, travestimenti * K., in “Il Verri”, anno IV, n. 2, 1960, pp. 69–82 * K e altre cose, Scheiwiller, Milano, 1962 (contiene K., alcune poesie e interventi critici). * Passaggio, per la musica di Luciano Berio, Universal, London-Milano, 1963 (e in “Sipario”, n. 224, pp. 62–70 * Traumdeutung, in "Menabò", n. 8, 1965, pp. 37–49 * Teatro, Feltrinelli, Milano, 1969 * Laborintus II, per la musica di Luciano Berio, in “Manteia”, XIV-XV, 1972, pp. 14–28 * Marinettiana, in Giuseppe Bartolucci, Il gesto futurista, Bulzoni, Roma, 1969, pp. 73–77 * Orlando Furioso (travestimento dell’Ariosto in collaborazione con Luca Ronconi), Bulzoni, Roma, 1970 * Storie naturali, Feltrinelli, Milano, 1971 * Interviste impossibili: Francesca da Rimini, in AA.VV., Le nuove interviste impossibili, Bompiani, Milano, 1976 * C’ero anch’io: la prima dell’Edipo Re, inedito, 1978 * Carrousel, per la musica di Vinko Globokar, parziale in "Musica e realtà", n. 4, 1981, pp. 21–41 * Faust. Un travestimento, Costa & Nolan, Genova, 1985 (da Goethe, trasformato poi da Luca Lombardi in opera musicale) * Commedia dell’Inferno (da Dante), Costa & Nolan, Genova, 1989 Per Musica, Ricordi Mucchi, Modena, 1993 (contiene con Passaggio e Laborintus II, le opere Carrousel, L’armonia drammatica per la musica di Vinko Globokar, l’Antigone, adattamento per le musiche di scena di Mendelssohn, 1986, correlato dalla nota introduttiva, con il titolo Il complesso di Antigone e tutti i testi con destinazione musicale) * Tracce, Grin, Roma, 1995 (contiene Tracce, Storie naturali, Satyricon, in collaborazione musicale) * Rap, LibriARENA fuoriTHEMA, Bologna, 1996 * Il mio amore è come una febbre e mi rovescio, Bompiani, Milano, 1998 contiene Rap e Sonetto, (entrambi per la musica di Andrea Liberovici) * Dialogo, in “Allegoria”, anno II, n. 5, 1990, e poi in “Passaggi”, anno II, n. 3, giugno 1998, pp. 71–76 * Sei personaggi.com, un travestimento pirandelliano (con musiche di scena di Andrea Liberovici), il Melangolo, Genova, 2001 * L’amore delle tre melarance, un travestimento fiabesco dal canovaccio di Carlo Gozzi, il Melangolo, Genova, 2001 Saggi e studi * Interpretazione di Malebolge, Olschki, Firenze, 1961 * Tre studi danteschi, Le Monnier, Firenze, 1961 * Tra liberty e crepuscolarismo, Mursia, Milano, 1961 * Alberto Moravia, Mursia, Milano, 1962 * Ideologia e linguaggio, Feltrinelli, Milano, 1965 * Guido Gozzano. Indagini e letture, Einaudi, Torino, 1966 * Il realismo di Dante, Sansoni, Firenze, 1966 * Antonio Bueno, Feltrinelli, Milano, 1975 * La missione del critico, Marinetti, Genova, 1987 * Lettura del Decameron, a cura di Emma Grimaldi, Edizioni 10/17, Salerno, 1989 * Dante reazionario, Editori Riuniti, Roma, 1992 * Per una critica dell’avanguardia poetica in Italia e in Francia, Bollati Boringhieri, Torino, 1995 (con un saggio di Jean Burgos e due testimonianze di Pierre Dhainaut e Jacqueline Risset) * Il chierico organico, a cura di Erminio Risso, Feltrinelli, Milano, 2000 * Ideologia e linguaggio, nuova edizione accresciuta, Feltrinelli, Milano, 2001 * Verdi in technicolor, il melangolo, Genova, 2001 * Atlante del Novecento italiano, a cura di Erminio Risso, con fotografie di Giovanni Giovannetti, Manni, Lecce, 2001 * Carol Rama, Masoero Edizioni, Torino 2002 * La letteratura italiana di Edoardo Sanguineti, Rai Educational, 2000 * Cultura e realtà, a cura di Erminio Risso, Milano, Feltrinelli, 2010 Raccolte di articoli * Giornalino, Einaudi, Torino, 1976 * Giornalino secondo, Einaudi, Torino, 1979 * Scribilli, Feltrinelli, Milano, 1985 * Ghirigori, Marietti, Genova, 1988 * Gazzettini, Editori Riuniti, Roma, 1993 * Taccuini (12 prose comparse originariamente su “Rinascita” tra il 1984 e il 1987), in “Poetiche”, n. 3/ 2007, Modena, Mucchi editore, a cura e con introduzione di L. Weber, pp. 413–475 l’altruista Gli ultimi articoli del poeta su Gli Altri, Roma, I edizione Gli Altri, maggio 2011. ISSN 2037-2221. Venduto esclusivamente in abbinamento al settimanale Gli Altri in edicola. Postfazione di Fausto Bertinotti. Traduzioni * J. Joyce, Poesie, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1961 * Salmi: preghiera e canto della Chiesa, a cura di J. Gelineau, U. Wernst, E. Sanguineti, D. Stefani, L. Borello, Elle Di Ci, Torino, 1966 * Euripide. Le Baccanti, Feltrinelli, Milano, 1968 * Seneca, Fedra, Einaudi, Torino, 1969 * Petronio, Il Satyricon, Aldo Palazzi Editore, Roma, 1969 * Euripide, Le Troiane, Einaudi, Torino, 1974 * Eschilo, Le Coefore, il Saggiatore, Milano, 1978 * Sofocle. Edipo tiranno, Cappelli, Bologna, 1980 * Sofocle, Antigone, adattamento per le musiche di scena di Felix Mendelssohn, 1986 * Eschilo. I sette contro Tebe, Sipario, Milano, 1992 * W. Shakespeare, Macbeth Remix (con musiche di scena di Andrea Liberovici), Spoleto, 1998 * Molière, Don Giovanni, il Melangolo, Genova, 2000 * Aristofane, La festa delle Donne, il melangolo, Genova, 2001 * B. Brecht, Il cerchio di gesso del Caucaso, il melangolo, Genova, 2003 * Omaggio a Shakespeare. Nove sonetti, illustrati da Mario Persico, con un saggio di Niva Lorenzini, Manni, Lecce, 2004 * Pierre Corneille. L’illusione comica, il Melangolo, Genova, 2005 * Teatro antico. Traduzioni e ricordi, a cura di Federico Condello e Claudio Longhi, BUR, Milano, 2006 * Quaderno di traduzioni. Lucrezio Shakespeare Goethe, Einaudi, Torino, 2006 * W. Shakespeare La tragedia di Re Lear, il Melangolo, Genova, 2008 * Fedra (Ippolito portatore di corona) di Euripide, per l’Istituto nazionale del dramma antico INDA 2009 Antologie * Il sonetto, Mursia, Milano, 1957 (in collaborazione con Giovanni Getto) * Decameron. 49 novelle commentate da Momigliano, Petrini, Torino 1959 * Poesia italiana del Novecento, Einaudi, Torino, 1969 * L’Opera di Pechino, Feltrinelli, Milano, 1971 Interviste * Fabio Gambaro, Colloquio con Edoardo Sanguineti, Anabasi, Milano 1993 Erminio Risso (a cura di), Atlante del Novecento italiano. La cultura letteraria, con fotografie di Giovanni Giovannetti, Manni, Lecce 2001 (le schede di 74 scrittori, con un’intervista di Erminio Risso a Edoardo Sanguineti) * Giuliano Galletta, Sanguineti/Novecento. Conversazioni sulla cultura del ventesimo secolo, il melangolo, Genova 2005 * Antonio Gnoli, Sanguineti’s Song. Conversazioni immorali, Feltrinelli, Milano 2006 * (a cura di Roberto Iovino), Conversazioni musicali, il melangolo, Genova 2011 Epistolari * Fausto Curi, La poesia italiana d’avanguardia. Modi e tecniche. Con un’appendice di documenti e di testi editi e inediti, Liguori, Napoli 2001 * Ciro Vitiello, Due lettere, un dialogo critico, in Album Sanguineti, a cura di Niva Lorenzini ed Erminio Risso, Manni, Lecce 2002 * Tommaso Lisa (a cura di), Pretesti ecfrastici. Edoardo Sanguineti e alcuni artisti italiani con un’intervista inedita, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2004 (contiene il carteggio Sanguineti-Bueno) * Niva Lorenzini (a cura di), Lettere dagli anni Cinquanta, De Ferrari editore, Genova 2009 (contiene le lettere di Sanguineti a Luciano Anceschi) Opere di lessicografia * Schede gramsciane, Utet, Torino 2004 * direzione del volume di supplemento 2004 (integrazioni e aggiornamenti) del Grande dizionario della lingua italiana, Utet, Torino 2004 consulenza e collaborazione per il GRADIT – Grande dizionario italiano dell’uso ideato e diretto da Tullio De Mauro, sei volumi e un CD-rom, Utet, Torino 1999, a cui seguono un volume VII (Nuove parole italiane dell’uso, con un CD-rom), Utet, Torino 2003, e un volume VIII (Nuove parole italiane dell’uso, con una chiave USB), Utet, Torino 2007 Filmografia Ansano Giannarelli: Non ho tempo, 1973, bianco e nero, 104 min. (la versione televisiva è in 3 puntate di un’ora ciascuna). Con Mario Garriba (Evariste Galois), Franco Agostini, Lucio Lombardo Radice, Marisa Fabbri, Fernando Birri. Sanguineti ne scrive la sceneggiatura insieme a Giannarelli e con la consulenza scientifica di Lucio Lombardo Radice. Il film è girato nel 1971-72 ma presentato alle “Settimane della critica” del Festival di Cannes del 1973. Il film presentato a Cannes durava 150 minuti. Luca Ronconi:Orlando Furioso, 1974. Sceneggiato televisivo di 293 minuti in cinque puntate, mandato in onda ogni domenica alle 20, 45 dal 16 febbraio 1975 in bianco e nero. Proiettato nelle sale cinematografiche in un’edizione di 113 minuti (2º e 5º episodio, dal dicembre 1974). Derivato dallo spettacolo messo in scena da Ronconi nel 1969 su testo di Sanguineti. Scene e costumi: Pierluigi Pizzi, fotografia: Vittorio Storaro e Arturo Zavattini, musiche: Giancarlo Chiaramello. Con Mariangela Melato (Olimpia), Ottavia Piccolo (Angelica), Massimo Foschi (Orlando), Guido Mannari (Bireno), Cesare Gelli (Cimosco), Michele Placido (Agramante), Paolo Bonetti (Dardinello), Yorgo Voyagis (Cloridano), Alessio Orano (Medoro), Marzio Margine (Zerbino), Luigi Diberti (Ruggiero), Paolo Turco (il pastore), Giacomo Piperno (Sacripante), Germano Longo (Oberto), Vittorio Sanipoli (Sobrino), Hiram Keller (Brandimarte), Erika Dario (la figlia di Cimosco), Rodolfo Bandini (Guidon Selvaggio), Carla Tatò (la vedova parigina), Ettore Manni (Carlo Magno), Carlo Valli (Ferraù), Edmonda Aldini (Bradamante) * Ennio De Dominicis: Niente stasera, 1993, colore, 72 min. Interpretazione * Michael Muschner: Truck Stop, mediometraggio, 1996. Scrittura di una poesia per il film e sua interpretazione * Felipe Guerriero: Medellìn, 1999. Interpretazione * Ugo Nespolo: Film-a-To, 2001, Betacam colore, 12 min. Lettura di alcune poesie sul cinema scritte appositamente per il film Andrea Liberovici Work in regress– la fabbrica nel cinema, 2006, video-installazione, 30 min. Lettura delle didascalie scritte per il film (esistono due versioni del titolo: Work in regress/ la fabbrica del cinema e Work in regress/ una catena di montaggi) * Mimmo Paladino: Quijote, 2006, HD colore, 75 min. Lettura di un testo poetico, Invenzione di Don Chisciotte, del 1949 Ugo Nespolo: Superglance, 2007, colore, 35 mm., 7 min. Scrittura e dizione dei testiInoltre Sanguineti avrebbe dovuto interpretare una parte in un film di Evgenij Aleksandrovič Evtušenko ma infine decise di non partecipare: una sua testimonianza è nell’intervista concessa a Piero Chiambretti nel programma televisivo Il laureato bis, puntata del 5 febbraio 1996. Probabilmente si trattava del mai realizzato * Konec Musketery (La fine dei tre moschettieri)Su Film-a-to si può vedere * Ugo Nespolo, Film-a-to, Allemandi, Torino 2002 (30 ill. a colori e 50 bn)Sul film di Paladino si può vedere * Mimmo Paladino, Quijote. Una mostra, un film, un libro, edizioni Electa, Milano 2005 Video e televisione * Match, serie di incontri moderati da Alberto Arbasino, puntata con Sanguineti e Moravia, 1978 La letteratura italiana di Edoardo Sanguineti, 14 puntate video della durata di circa 59 minuti ciascuna per Rai Educational, 2000. Regia di Lorenzo Gigliotti. Direttore della fotografia Alessandro Macci. A cura di Marco Sabatini. Oggi in 14 DVD della durata di circa 59 minuti ciascuno: Dalla latinità al volgare / Il Duecento / Dante / Petrarca / Boccaccio / L’Umanesimo / Ariosto e Tasso (oggi compresi nel cofanetto Storia della letteratura italiana di Edoardo Sanguineti. Dalle origini al Cinquecento, Rai, La Rai per la cultura, codice UDOC); Il Cinquecento / Il Seicento / Il Settecento / L’Ottocento. Foscolo e Leopardi / L’Ottocento: Manzoni / Il Novecento: prosa / Il Novecento: poesia (oggi compresi nel cofanetto Storia della letteratura italiana di Edoardo Sanguineti. Età moderna e contemporanea, Rai, La Rai per la cultura, codice UEMC) * abecedario di edoado sanguineti, a cura di Rossana Campo, video-intervista in 2 DVD, regia Uliano Paolozzi Balestrino, DeriveApprodi, Roma maggio 2006 * Sanguineti e Inge Feltrinelli sugli anni '60, intervista registrata alla libreria Feltrinelli di Mantova nel settembre 2006 Alfabeto Apocalittico, di e con Edoardo Sanguineti e Stefano Scodanibbio, immagini di Enrico Baj. Ripresa televisiva dello spettacolo con regia di Massimo Puliani, in occasione della consegna a Sanguineti del titolo accademico Honoris Causa all’Accademia di Belle Arti, Macerata, 4 maggio 2006 Eventi, mostre, installazioni * Magazzino Sanguineti, mostra (spezzoni di film, frammenti sonori, riproduzioni fotografiche, diapositive che proiettano versi), a cura di Erminio Risso, Palazzo Ducale, Loggia degli Abati, 23 maggio-27 giugno 2004 * Ritratto del Novecento alla Sala Borse di Bologna, regia di Giuseppe Bertolucci, 12-16 dicembre 2005 (ora le schede sono pubblicate in Ritratto del Novecento, a cura di Niva Lorenzini, Manni, Lecce 2009) Marcel Duchamp e il cinema, giornata sul cinema duchampiano, installazione Rotorilievi (telecamera e stampante, in una stanza, con al centro un divano), 8 giugno 2006. A cura di Valter Scelsi, Marta Oddone, Francesco Frassinelli, Davide Perfetti, Erminio Risso (nel corso della mostra “Marcel Duchamp: una collezione italiana”, allestimento a cura di Massimiliano Fuksas, 11 maggio-16 luglio, Genova, Museo di Villa Croce) * C’era una volta il pc – un quarto di secolo di personal computer, ologramma per la mostra “Hi Tech! Festival dell’innovazione”, Roma, complesso mussale dell’Ara Pacis, dal 7 al 10 giugno 2007 Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Sanguineti

I am a believing and practicing Christian. I study God's word daily. I write Christian poetry but I also write on other topics. My poems are very simple. I don't use fancy or big words so this may be disappointing to some. I love the old Classic Poets like Sara Teasdale, Robert Louis Stevenson, and a whole host of others. I love all kinds of music from hard rock to classical. I'd like to share a few quotes, sorry I do not have all the names of the authors; Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option” “A woman often thinks she regrets the lover, when she only regrets the love” By Francois de la Rochefoucauld “One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else.” “The one that seems to love the least, has the most control, in a relationship” “I love walking in the rain, 'cause then no-one knows I'm crying.” “Until this moment, I never understood how hard it was to lose something you never had.” “Being hurt by someone you truly care about leaves a hole in you heart that only love can fill.” “The love that lasts the longest is the love that is never returned.” "I dropped a tear in the ocean, and when you find it, that is when I will stop loving you. A few Quotes from Me, Debra A man should always, say what he means, and mean what he says, because, this is his signature. The more people you have in your life, the more problems, there will be to endure. Smart is a woman who guards her heart. Foolish is a woman, who lets a man, tare her heart apart. © Debra


I don't write to please Only to put this need at ease I can't force my poems, spontanious as fire They flow in when they desire Like emotions, they never seem to dim It's my job to scramble; keeping up with them So they are not a loss of time To view my work I won't charge one dime All my hardships are not my demise This life I live is such a prize


Alessandro Manzoni, nome completo Alessandro France (sco Tommaso Antonio Manzoni (Milano, 7 marzo 1785 – Milano, 22 maggio 1873), è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo italiano. Considerato uno dei maggiori romanzieri italiani di tutti i tempi per il suo celebre romanzo I promessi sposi, caposaldo della letteratura italiana, Manzoni ebbe il merito principale di aver gettato le basi per il romanzo moderno e di aver così patrocinato l’unità linguistica italiana, sulla scia di quella letteratura moralmente e civilmente impegnata propria dell’Illuminismo italiano. Passato dalla temperie neoclassica a quella romantica, il Manzoni, divenuto fervente cattolico dalle tendenze liberali, lasciò un segno indelebile anche nella storia del teatro italiano (per aver rotto le tre unità aristoteliche) e in quella poetica (nascita del pluralismo vocale con gli Inni Sacri e della poesia civile). Il successo e i numerosi riconoscimenti pubblici e accademici (fu senatore del Regno d’Italia) si affiancarono a una serie di problemi di salute (nevrosi, agorafobia) e famigliari (i numerosi lutti che afflissero la vita domestica dello scrittore) che lo ridussero in un progressivo isolamento esistenziale. Nonostante quest’isolamento, Manzoni fu in contatto epistolare con la migliore cultura intellettuale francese, con Goethe, con intellettuali di primo ordine come Antonio Rosmini e, seppur indirettamente, con le novità estetiche romantiche britanniche (influsso di Walter Scott per il genere del romanzo). Biografia Origini familiari Famiglia Alessandro Manzoni proveniva, dal lato materno, da una famiglia illustre, i Beccaria. Il nonno materno di Manzoni, infatti, era quel Cesare Beccaria, autore del trattato Dei delitti e delle pene, che fu uno dei principali animatori dell’illuminismo lombardo. A detta del Manzoni stesso, lui e il nonno si conobbero soltanto una volta, in occasione della visita della madre presso il celebre padre. La parentela coi Beccaria lo rendeva inoltre lontano cugino dello scrittore scapigliato Carlo Dossi. Più modesta era invece la famiglia paterna: don Pietro Manzoni, il padre di Alessandro, discendeva da una nobile famiglia di Barzio, in Valsassina, e stabilitasi a Lecco (nella località del Caleotto) nel 1612 in seguito al matrimonio di Giacomo Maria Manzoni con Ludovica Airoldi nel 1611. Per quanto don Pietro Antonio Pasino Manzoni (1657-1736) avesse poi ricevuto il feudo di Moncucco nel novarese nel 1691, e per quanto in virtù di ciò fossero conti, il titolo a Milano non era valido perché “straniero”. Inizialmente don Pietro presentò al governo austriaco una richiesta ufficiale perché fosse riconosciuto, ma poi preferì non insistere. In ogni caso, quando Roma attribuirà molto più tardi la cittadinanza al Manzoni, il titolo comitale apparirà sull’atto ufficiale e verrà mantenuto dalla sua discendenza. Manzoni e Giovanni Verri Nonostante il padre legittimo fosse Pietro Manzoni, è molto probabile che il padre naturale di Alessandro fosse un amante di Giulia, Giovanni Verri (fratello minore di Alessandro e Pietro Verri). Con Giovanni, uomo attraente e libertino, di diciassette anni maggiore di lei, ella aveva avviato una relazione già nel 1780, proseguendola anche dopo il matrimonio. Dalle parole del Tommaseo pare evincersi come Verri fosse il vero padre dello scrittore, e come questi ne fosse pienamente a conoscenza: «Anco di Pietro Verri [Manzoni] ragiona con riverenza, tanto più ch’egli sa, e sua madre non glielo dissimulava, d’essere nepote di lui, cioè figliuolo d’un suo fratello». L’infanzia e l’adolescenza Galbiate e la separazione dei genitori Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni nacque a Milano, allora parte dell’impero asburgico, al n. 20 di via San Damiano, il 7 marzo 1785 da Giulia Beccaria e, ufficialmente, da don Pietro Manzoni. Trascorse i primi anni di vita prevalentemente nella cascina Costa di Galbiate, tenuto a balia da Caterina Panzeri, una contadina del luogo. Questo fatto è attestato dalla targa tuttora affissa nella cascina. Sin d’ora passò alcuni periodi alla villa rustica di Caleotto, di proprietà della famiglia paterna, una dimora in cui amerà tornare da adulto e che venderà, non senza rimpianti, nel 1818. In seguito alla separazione dei genitori, Manzoni venne educato in collegi religiosi. L’educazione religiosa a Merate e a Lugano Il 13 ottobre 1791 fu accompagnato dalla madre a Merate al collegio San Bartolomeo dei Somaschi, dove rimase cinque anni: furono anni duri, in quanto il piccolo Alessandro risentiva della mancanza della madre e perché soffriva del difficile rapporto con i suoi compagni di scuola, violenti tanto quanto gli insegnanti che lo punivano di frequente. La letteratura era già una consolazione e una passione: durante la ricreazione, racconterà lo scrittore, «…mi chiudevo […] in una camera, e lì componevo versi». Nell’aprile del 1796 passò al collegio di Sant’Antonio, a Lugano, gestito ancora dai Somaschi, per rimanervi fino al settembre del 1798. Nello stesso 1796, giungeva sul Lago di Lugano il somasco Francesco Soave, celebre erudito e pedagogista. Per quanto sia del tutto improbabile che Manzoni l’abbia avuto come maestro (se non per qualche giorno), la sua figura esercitò sul bambino una notevole influenza. Vecchio e prossimo alla morte, l’autore de I promessi sposi ricordava: «Io volevo bene al padre Soave, e mi pareva di vedergli intorno al capo un’aureola di gloria». Passò, alla fine del '98, al collegio Longone di Milano, gestito dai Barnabiti e quindi si trasferì a Castellazzo de’ Barzi, dove l’istituto aveva stabilito provvisoriamente la propria sede a causa delle manovre belliche per poi tornare, il 7 agosto 1799, a Milano. Non è chiaro quanto l’adolescente rimanesse dai Barnabiti, anche se l’ipotesi più accreditata lo fa supporre allievo della scuola fino al giugno 1801. Alessandro, nonostante l’isolamento cui era costretto per colpa dell’ambiente chiuso e bigotto, riuscì a stringere alcune amicizie che resteranno durature nel corso degli anni a venire: Giulio Visconti e Federico Confalonieri furono suoi compagni di classe. Un giorno imprecisato dell’anno scolastico 1800-1801, poi, gli scolari ricevettero una visita che suscitò nel Nostro una grande emozione: l’arrivo di Vincenzo Monti, che leggeva avidamente e considerava il più grande poeta vivente, «fu per lui come un’apparizione di un Dio». La formazione culturale La formazione culturale di Manzoni è imbevuta di mitologia e letteratura latina, come appare chiaramente dalle poesie adolescenziali. Due, in particolare, sono gli autori classici prediletti, Virgilio e Orazio; notevole è anche l’influsso di Dante e Petrarca, mentre tra i contemporanei, assieme al Monti, svolgono un ruolo importante Parini e Alfieri. Se si escludono gli esercizi di stile precedenti, le sue primissime esperienze poetiche risalgono alla metà del 1801, quando cominciò a stendere Del trionfo della libertà. Tuttavia vi si può riscontrare una vena satirica e polemica che avrà un ruolo non trascurabile nel Manzoni adolescente, pur venendo mitigata già a metà del decennio. Ci restano le traduzioni, in endecasillabi sciolti, di alcune parti del libro quinto dell’Eneide e della Satira terza (libro primo) di Orazio, accanto a un epigramma mutilo in cui attacca un certo fra’ Volpino che, sotto mentite spoglie, raffigura il vicerettore del collegio, padre Gaetano Volpini. Un giovane scapestrato Uscito dall’angusto mondo del Longone, visse dall’estate 1801 al 1805 con l’anziano padre don Pietro, alternando la vita di città con soggiorni alla tenuta di Caleotto, e dedicando buona parte del suo tempo al divertimento e in particolare al gioco d’azzardo, frequentando l’ambiente illuministico dell’aristocrazia e dell’alta borghesia milanese. Giocava nel ridotto del Teatro alla Scala, finché, sembra, un rimprovero del Monti lo convinse a rinunciare al vizio. Fu anche l’epoca del primo amore, quello per Luigina Visconti, sorella di Ermes. Di questa esperienza sappiamo quanto il poeta stesso rivelò nel 1807 in una lettera a Claude Fauriel. A Genova, infatti, l’aveva casualmente rivista, ormai sposata al marchese Gian Carlo Di Negro, e l’episodio aveva risvegliato in lui la nostalgia e il dispiacere di averla perduta. Oltre a questi svaghi, la giovinezza del Manzoni è contrassegnata anche da un soggiorno a Venezia (dall’ottobre 1803 al maggio 1804) presso il cugino Giovanni Manzoni, durante il quale ebbe modo di conoscere la nobildonna Isabella Teotochi Albrizzi, a suo tempo musa di Foscolo, e di scrivere tre dei quattro Sermoni. Non è chiaro il motivo del soggiorno veneziano, del quale Alessandro conservava anche ai tardi anni un bellissimo ricordo, ma non sembrano avere avuto un ruolo ragioni politiche: piuttosto vi entrò il desiderio del padre di allontanarlo da uno stile di vita dissipato. La Milano illuminista Il compiacimento neoclassico del tempo gli ispirò le prime composizioni di un qualche rilievo, modulate sull’opera di Vincenzo Monti, idolo letterario del momento. Ma, oltre questi, Manzoni si volge a Parini, portavoce degli ideali illuministi nonché dell’esigenza di moralizzazione, al poeta Ugo Foscolo, a Francesco Lomonaco, un esule lucano, e a Vincenzo Cuoco, assertore delle teorie vichiane, anche lui esule da Napoli dopo la restaurazione borbonica del 1799 e considerato il «primo vero maestro del Manzoni». La vicinanza all’ambiente neoclassico, e al suo campione Vincenzo Monti in particolare, spinsero il giovane Manzoni a frequentare alcuni corsi di eloquenza tenuti dal poeta romagnolo all’università di Pavia tra il 1802 e il 1803.Nei registri dell’ateneo il nome di Alessandro non risulta, ma è quasi certo che egli seguisse le lezioni montiane. Oltre alla nota ammirazione per il Monti e all’opinione di illustri studiosi, sembra convalidare l’ipotesi il carteggio del periodo. I corrispondenti di Manzoni, infatti, sono quasi tutti studenti (o vecchi studenti) dell’università, da Andrea Mustoxidi a Giovan Battista Pagani, da Ignazio Calderari a Ermes Visconti e a Luigi Arese. Il contesto accademico lo dovette mettere in contatto anche con due professori giansenisti, Giuseppe Zola e Pietro Tamburini, docenti rispettivamente di «storia delle leggi e dei costumi» e di «filosofia morale, diritto naturale e pubblico». Le loro idee in difesa della morale lo influenzarono molto, oltre a introdurlo per la prima volta al pensiero giansenista. Tamburini condannava la Curia romana per le sue deformazioni ma vedeva nel cattolicesimo un imprescindibile modello. Per l’elevatezza delle sue dissertazioni parve a Manzoni un punto di riferimento al pari di Zola, definito «sommo» in una lettera al Pagani del 6 settembre 1804. Dal punto di vista letterario, a questo periodo si devono Del trionfo della libertà, Adda e I quattro sermoni che recano l’impronta di Monti e di Parini, ma anche l’eco di Virgilio e Orazio. Il soggiorno parigino (1805-1810) La morte di Carlo Imbonati e il ricongiungimento con la madre Nel 1805 Manzoni venne invitato dalla madre e da Carlo Imbonati a Parigi, a quanto pare dietro suggerimento del Monti. Alessandro accettò con entusiasmo, ma non fece in tempo a conoscere il conte– alla cui missiva rispose nel marzo, con parole di calore e riconoscimento che Imbonati non lesse mai -, il quale morì il 15 marzo, lasciando la Beccaria ereditiera universale del suo patrimonio ma anche affranta e bisognosa dell’amore filiale. Il giovane, ora ventenne, giunse nella capitale francese il 12 luglio, giorno in cui la polizia locale gli rilasciava il permesso di soggiorno. Uniti entrambi nel dolore, Manzoni, che per lo scomparso scrisse l’ode In morte di Carlo Imbonati, scoprì di avere una madre: le loro strade, divise sino ad allora, si incrociarono per non lasciarsi più. Fino al 1841, anno della morte della Beccaria, i due instaurarono un rapporto strettissimo la cui profondità emerge dalle lettere dello scrittore in numerosissime occasioni. Già il 31 agosto 1805 rivelava a Vincenzo Monti di aver trovato «la mia felicità […] fra le braccia d’una madre», e di non vivere che «per la mia Giulia». Il circolo parigino: gli Idéologues e Claude Fauriel Con la madre soggiornò al numero 3 di Place Vendôme. Molto spesso, però, madre e figlio si recavano ad Auteuil, cittadina ove si riuniva il circolo intellettuale sotto il patronato della vedova del filosofo Helvétius, e alla Maisonnette di Meulan, dove passò due anni, partecipando al circolo letterario dei cosiddetti Idéologues, filosofi di scuola ottocentesca eredi dell’illuminismo settecentesco ma orientato verso tematiche concrete nella società, e anticipatori per questo di tematiche romantiche (quali l’attenzione alle classi povere, alle emozioni). Un ruolo importante nel gruppo degli Idéologues (costituito, tra gli altri, da Volney, Garat, Destutt de Tracy e il danese Baggesen) era ricoperto da Claude Fauriel, col quale Alessandro strinse una duratura amicizia per molti anni, una frequentazione facilitata anche dal legame che c’era tra Giulia e l’amante di Fauriel, Sophie de Condorcet, e dal più anziano Pierre Cabanis, autore della Lettre sur les causes premières, testo orientato in senso spiritualista, impregnato di spirito religioso, per quanto l’Essere supremo di cui si ammette l’esistenza non coincida completamente con il Dio cristiano secondo la concezione della Chiesa. A Parigi, dunque, Alessandro entra in contatto con la cultura francese classicheggiante, assimilando il sensismo, le teorie volterriane e l’evoluzione del razionalismo verso posizioni romantiche. Ci sono rimaste poche lettere relative agli anni 1805-1807, e non è pertanto possibile definire con precisione la rilevanza – per Manzoni – di tutti i testi e gli autori che il poeta lombardo conobbe o approfondì nei primi anni francesi. Fauriel e Cabanis emergono tuttavia come i due principali punti di riferimento, e una certa importanza dovette avere anche Lebrun, riconosciuto, in una lettera al Pagani del 12 marzo 1806, «grand’uomo», «poeta sommo» e «lirico trascendente». Potrebbero essere anche parole di circostanza, dettate da un’amicizia ancor fresca e dalla riconoscenza per le parole di elogio che «Pindare Lebrun» gli aveva rivolto, omaggiandolo di un suo componimento. Lo stile del poeta francese, improntato a un classicismo enfatico e di maniera, non pare in effetti conciliarsi con la poetica manzoniana, ma il poemetto Urania (ideato tra il 1806 e il 1807 e poi stancamente portato a compimento negli anni successivi) ne recherà parzialmente l’impronta. L’intermezzo italiano (1806-1807) e la morte di don Pietro Intanto, madre e figlio lasciarono una prima volta Parigi nel giugno 1806, per sistemare le ultime pratiche legali relative all’eredità dell’Imbonati, nella quale figurava anche la villa di Brusuglio. A settembre, comunque, erano già di ritorno in Francia, come dimostra una lettera di Manzoni a Ignazio Calderari; una missiva di Carlo Botta, scritta il 18 giugno, permette invece di stabilire la data della partenza da Parigi: «Madame Beccaria part demain matin pour le Piémont» (la signora Beccaria parte domattina per il Piemonte). Al febbraio 1807 risale il secondo spostamento: la lettera al Fauriel, scritta il 17, testimonia che quel giorno il Manzoni era a Susa e aveva passato il Moncenisio, e, sempre tramite testimonianze epistolari, sappiamo che il mese successivo era a Genova; sulla permanenza genovese ci informa un certo commissario Cometti, che il 16 marzo scrive di aver assistito a una rappresentazione teatrale in compagnia di Manzoni e della madre. Il 20 marzo, quando era in procinto di partire per Torino venne a sapere che il padre era gravemente malato (ma in realtà era già morto da due giorni), e durante il tragitto che lo conduceva a Milano, il figlio apprese della sua morte. Sembra che Giulia e Alessandro non siano entrati in città, preferendo trascorrere alcuni giorni nella nuova proprietà di Brusuglio, per poi riattraversare le Alpi. Le parole con cui affronta la scomparsa del padre, nelle lettere, paiono piuttosto fredde, per quanto nella missiva al Fauriel dell’8 aprile, venti giorni dopo il funerale, rivolgesse a Pietro un ultimo augurio: «Paix et honneur à sa cendre» (pace e onore alle sue ceneri); nella lettera a Pagani, scritta il 24 marzo, giorno in cui apprese la notizia del decesso, fa riferimento al motivo «ben doloroso» che lo aveva chiamato a Milano (ma pare non entrasse in città e non prendesse parte ai funerali), per poi proseguire con altri argomenti, come la soddisfazione di rivedere l’amico Calderari e l’affetto per la madre, «parlando della quale troverò sempre più ogni espressione debole e monca». Alessandro, nominato dal padre erede universale, a maggio era nuovamente a Parigi. Il matrimonio e la nascita di Giulia Da tempo Giulia Beccaria andava cercando una sposa per il figlio. Il viaggio primaverile del 1807 era stato fatto anche con questo obiettivo, divenuto ora preminente. Dopo che il progetto di fidanzare Alessandro con Augustine, figlia del filosofo Destutt de Tracy, fallì a causa del basso grado di nobiltà dei Manzoni, la Beccaria conobbe a Parigi Charlotte Blondel, imparentata con la famiglia calvinista del banchiere ginevrino François Louis Blondel. Blondel viveva a Milano con la moglie Marie e la figlia sedicenne Enrichetta nel palazzo Imbonati, che il conte gli aveva venduto anni addietro. Tramite Charlotte furono avviati i contatti, e in settembre i Manzoni partirono alla volta della città meneghina per fare la conoscenza di Enrichetta – di cui erano state fornite ottime referenze – e dei genitori. L’incontro, avvenuto a Blevio nel tardo settembre del 1807, non disattese le speranze. Manzoni rimase incantato dalla dolcezza e purezza della fanciulla e il matrimonio, che si rivelerà molto felice e sarà coronato dalla nascita di dieci figli, fu celebrato il 6 febbraio 1808 a Milano, prima con rito civile presso il Municipio e, quarantacinque minuti più tardi, con rito calvinista in via del Marino, dove si trovava la casa dei Blondel. Sistemate infine le ultime questioni legate all’eredità dell’Imbonati, i novelli sposi, accompagnati da Giulia, si stabilirono al numero 22 del Boulevard des Bains Chinois, a Parigi. Nello stesso anno, Il 23 dicembre, nacque la primogenita Giulia Claudia, che fu battezzata il 23 agosto del 1809 nella chiesa giansenista di San Nicola in località Meulan, secondo il rito cattolico e con Fauriel come padrino. La decisione di battezzare la primogenita da parte di un padre indifferente dal punto di vista religioso e da una madre calvinista è l’indice di un cambiamento radicale nella sensibilità spirituale della famiglia Manzoni. La conversione: un dibattito aperto La questione della conversione al cattolicesimo di Manzoni è una tematica su cui non solo i critici, ma anche i conoscenti e i famigliari del Manzoni hanno sempre discusso, ottenendo risposte aleatorie da parte dell’autore de I promessi sposi, riserbo che rende ogni studio critico inevitabilmente opinabile e incompleto. L’importanza della conversione, fondamentale per comprendere l’evoluzione tematica e spirituale del Manzoni del «quindicennio creativo», è dettata soprattutto dalla leggenda agiografica che vorrebbe una sua conversione repentina, dovuta allo smarrimento di Enrichetta nel 1810. In realtà, il percorso che ricondusse il giovane Alessandro e la sua famiglia alla pratica religiosa cattolica fu ben più lungo, dovuto a una serie di fattori combinati fra di loro. Le due lettere al Calderari (1806) Una certa importanza rivestono due lettere che Manzoni inviò a Ignazio Calderari in merito alla malattia che condusse alla morte il loro comune amico Luigi Arese. Nella prima, del 17 settembre 1806, si duole che al posto delle persone care, il morituro debba avere al proprio capezzale «l’orribile figura di un prete», ma il 30 ottobre, dopo la morte dell’Arese, sempre al Calderari esclama: «Oh sì! ci rivedremo! Se questa speranza non raddolcisse il desiderio dei buoni e l’orrore della presenza dei perversi, che sarebbe la vita?». Da un lato, viene confermata la reazione anticlericale ravvisata nelle prime opere, ma al tempo stesso, come emerge ugualmente dalle prime opere, Manzoni dimostra di conformarsi allo spirito cristiano, prefigurando un’esistenza dopo la morte. La supplica a Pio VII Dopo il battesimo cattolico di Giulia nell’agosto del 1809, Manzoni, d’accordo con la moglie, indirizzò una supplica a papa Pio VII affinché, «pentito del fallo commesso», l’autorità pontificia ponesse «un opportuno riparo, capace di rendere tranquilla la di lui coscienza [del supplicante, cioè del Manzoni]», rendendo possibile celebrare nuovamente il matrimonio, questa volta secondo il rito cattolico. Nel mese di novembre giunse l’autorizzazione papale con un rescritto del cardinale Di Pietro datato al 30 ottobre, e il 15 febbraio 1810, nella casa di Ferdinando Marescalchi, il curato della chiesa della Madeleine officiava la funzione. Degola e San Rocco (1809-1810) All’inizio del 1809 i Manzoni avevano fatto conoscenze importanti, forse decisive nell’orientare Alessandro verso la pratica religiosa. Pierre Jean Agier, presidente della Corte d’appello parigina, Giambattista Somis, già consigliere della Corte di appello di Torino, Ferdinando Marescalchi, ministro delle Relazioni estere del Regno d’Italia napoleonico, e Anne Marie Caroline Geymüller, una donna di Basilea rimasta vedova di un ufficiale della guardia svizzera del re Luigi XVI, facevano parte di un ambiente fortemente cattolico e giansenista. Quest’ultima, inoltre, aveva abiurato il calvinismo nel 1805 per opera di un abate genovese giansenista che i Manzoni conosceranno proprio nell’autunno del 1809, Eustachio Degola, il quale rivestì un’enorme importanza per la conversione di Alessandro e della famiglia. La conversione del Manzoni, però, è ben più nota per il cosiddetto “miracolo di San Rocco”. Il 2 aprile 1810, durante i festeggiamenti per le nozze di Napoleone e Maria Luisa d’Austria, improvvisamente scoppiarono dei mortaretti e la folla che riempiva le strade, presa dal panico, separò dalla moglie il Manzoni il quale, sospinto dalla gente in fuga, si ritrovò sui gradini della Chiesa di San Rocco, in rue Saint-Honoré, e si rifugiò in essa. Nel silenzio e nella serenità di quel tempio egli implorò la grazia di ritrovare la consorte e all’uscita, convertito, poté riabbracciarla. Un’altra versione, riportata da Giulio Carcano, racconta invece di un Manzoni frustrato che, assillato da dubbi spirituali, si sarebbe recato in San Rocco gridando: «O Dio! Se tu esisti, rivelati a me!», uscendone poi credente. Degola e i rapporti con i Manzoni Inizialmente il sacerdote ebbe il compito di preparare Enrichetta Blondel all’abiura del calvinismo, chiedendole di scrivere dei riassunti delle lezioni di religione cattolica (chiamati ristretti), affinché fossero poi corretti dallo stesso abate genovese. L’abiura, poi, fu sottoscritta in un atto ufficiale il 3 maggio 1810 e celebrata solennemente il 22 maggio nella Chiesa di Saint-Séverin, alla presenza del circolo giansenista e dell’abate Degola. L’ascendenza del prete giansenista è comunque innegabile: rimane a testimoniarlo il pluriennale carteggio che il sacerdote genovese intrattenne con Manzoni, con la moglie e con Giulia Beccaria. È relativamente facile ricostruire i passaggi attraverso cui la Blondel si convertì al cattolicesimo, ma non è chiaro perché ciò avvenisse. Probabilmente il Manzoni, che era «un animo non veramente ribelle», accettava con fastidio un matrimonio non benedetto e aver dovuto ammettere questa situazione, quando la figlia fu iscritta nel registro dei battesimi, dovette metterlo a disagio. Il ritorno in Italia (1810-1812) Tra via del Morone e Brusuglio. La famiglia Quanto lo spirito del Manzoni fosse cambiato negli ultimi mesi della permanenza parigina, o meglio, quanto fosse in contraddizione con i valori e i modelli precedenti, è difficile dire. Sicuramente la grande città francese, capitale del bel mondo e degli intellettuali del momento, non esercitava più alcun fascino su di lui. Bisognoso di tranquillità, Manzoni lasciò Parigi con la famiglia il 2 giugno, diretto a Brusuglio, dove giunse, nonostante alcuni inconvenienti, qualche settimana più tardi. Li doveva, però, aspettare la collera della famiglia Blondel, adirata per la conversione di Enrichetta al cattolicesimo, un risentimento che non diminuì con il passare degli anni. Al ritorno dalla Francia, i Manzoni alternarono periodi a Brusuglio e in città, dimorando nella villa fuori porta quando veniva la bella stagione, ove Alessandro si dedicava all’agricoltura. A Milano, si stabilirono per quasi due anni al numero 3883 di via S. Vito al Carobbio, per poi trascorrere un anno nel palazzo dei Beccaria, in via Brera, finché il 2 ottobre 1813 il poeta acquistò una casa in via del Morone, al numero 1171 (oggi 1). Manzoni era sempre stato abituato a vivere in mezzo al verde: la nuova dimora, che dava su piazza Belgioioso, aveva «un giardino proprio interno, con certo quale sentore di chiostro, assolutamente quel che ci voleva per l’indole del Manzoni». In via del Morone l’autore avrebbe trascorso il resto della propria vita. Nel corso degli anni seguenti i membri della famiglia Manzoni, che alternavano la loro residenza tra il palazzo cittadino e la villa di Brusuglio, crebbero di numero. Dopo la morte di Luigia, nata e morta nello stesso giorno (5 settembre 1811), il 21 luglio 1813 vide la luce in via Brera il primo figlio maschio, Pietro Luigi. Il 25 luglio 1815, la casa di via del Morone fu allietata dalla nascita di Cristina. Nel giro di pochi anni vennero al mondo anche Sofia (12 novembre 1817), Enrico (7 giugno 1819), Clara, vissuta due anni, nell’agosto 1821; 13 mesi dopo, Vittoria, Filippo nel marzo 1826 e Matilde nel maggio 1830. Da Degola a Luigi Tosi: la nuova guida spirituale Prima di partire, i Manzoni avevano chiesto al sacerdote giansenista di indicar loro una persona degna di fiducia che potesse continuare la sua opera di assistenza spirituale. Il 30 maggio Degola scriveva una lettera di raccomandazione per don Luigi Tosi, canonico di Sant’Ambrogio e anch’egli giansenista. Sia Giulia che Alessandro ebbero del Tosi un’ottima impressione, come può evincersi dalle parole di Alessandro: «Il degnissimo Canonico Tosi fu visitato da mia madre e me […], e fu trovato un vero amico del Degola; e questo basti per suo elogio». Il sacerdote si recava anche a Brusuglio, quando la famiglia vi soggiornava, e mantenne la sua funzione di guida spirituale per molti anni, anche dopo la sua elezione a vescovo di Pavia, avvenuta nel 1823. Ad Alessandro, come alla moglie e alla madre, non era ancora stato amministrata l’eucaristia. Dopo una breve preparazione, Manzoni si confessò il 27 agosto e il 15 settembre, assieme a Giulia ed Enrichetta, si accostò per la prima volta alla Comunione, anche se il percorso di conversione completa fu ancora molto lungo. Infatti, nell’agosto 1811, il neofita inviava a Degola e Tosi delle lettere, in cui chiedeva rispettivamente di pregare «perché piaccia al Signore scuotere la mia lentezza nel suo servizio e togliermi da una tepidezza che mi tormenta, e mi umilia», e affermava che «malgrado la mia profonda indegnità sento quanto possa in me operarne [di bene] la Onnipotenza della Divina Grazia». Il quindicennio creativo (1812-1827) Introduzione Espressione ormai adottata dalla critica letteraria, il quindicennio creativo suole indicare quell’arco temporale in cui Manzoni, ormai convertito al cattolicesimo e alle idee romantiche, si prodigò nella stesura delle sue opere letterarie principali, spaziando dalla poesia sacra a quella civile, dai saggi filosofico-religiosi alle tragedie, per giungere infine alla stesura del primo grande romanzo della storia della letteratura italiana. In tutti questi generi, Manzoni apportò elementi nuovi e rivoluzionari rispetto alla tradizione letteraria: gli Inni Sacri rivelano la coralità della poesia cristiana manzoniana; le tragedie, in nome della verosimiglianza, si slegano dalle unità aristoteliche e rivelano quell’interesse progressivo per i sentimenti umani che troveranno piena espressione nel romanzo. Gli Inni Sacri D’ora in avanti, la sua vita e la sua arte saranno pienamente conformi alla fede e alla necessità di divulgarla con l’esempio e con le opere. Nel 1812 cominciò la stesura degli Inni sacri: l’autore voleva scrivere nell’ordine Il Natale, L’Epifania, La Passione, La Risurrezione, L’Ascensione, La Pentecoste, Il Corpo del Signore, La Cattedra di San Pietro, L’Assunzione, Il Nome di Maria, Ognissanti e I Morti, ma ne portò a termine solo cinque: La Risurrezione, Il nome di Maria, Il Natale, La Passione e La Pentecoste. I primi quattro furono scritti tra l’aprile 1812 e l’ottobre 1815 e pubblicati in un volumetto presso l’editore milanese Pietro Agnelli alla fine del 1815, mentre la stesura de La Pentecoste, iniziata nel 1817, fu completata solo cinque anni più tardi, rallentata da altre opere cui l’autore attese nei medesimi anni, tra cui spiccano le due tragedie e la prima versione del romanzo. L’Ognissanti (1830-1847) restò in stato di frammento, come altre possibili aggiunte agli Inni (Il Natale del 1833 e il brevissimo Dio nella natura). La poesia religiosa del Manzoni è infine completata dalle Strofe per una Prima Comunione. L’intenzione dell’autore è quella di una poesia popolare, da cui lo stile talvolta si allontana perché ancora influenzato dalla formazione neoclassica, per poi ritornare alla comunità dei credenti (l’ecclesia cristiana) che innalza, insieme al poeta, un canto di lode a Dio, unica sicurezza contro il male sempre imperante nella Storia. Questa dimensione corale emerge soprattutto nella Pentecoste, ove i «figli d’Eva» (v. 71), sparsi in tutto il mondo, trovano unità nella fede in Dio. Il 1814 e le Odi civili Mentre Manzoni elaborava gli Inni Sacri, la situazione politica italiana e internazionale si stava velocemente deteriorando: Napoleone, fortemente debilitato dopo la disastrosa campagna di Russia del 1812, crollava nella grande battaglia di Lipsia del 1813. Di conseguenza, anche gli Stati satelliti francesi, tra cui il Regno d’Italia, caddero sotto i colpi della coalizione austro-russa, obbligando Eugenio di Beauharnais a fuggire da Milano e permettendo così agli austriaci di rientrare in Lombardia dopo vent’anni di assenza. Manzoni vive questi momenti drammatici con grande angoscia, assistendo dal suo palazzo di via del Morone, il 20 aprile 1814, al linciaggio del ministro delle finanze Giuseppe Prina, la cui violenza (deplorata vivamente dal Manzoni) viene narrata dal poeta milanese in una lettera indirizzata al Fauriel. A parte l’episodio del Prina, Manzoni partecipò intensamente al tentativo di mantenere indipendente l’Alta Italia con un regno il cui re sarebbe stato proprio il Beauharnais, sottoscrivendo una petizione presso le grandi potenze vittoriose riunitesi a Parigi. Poeticamente, invece, il Manzoni contribuì all’effimero sentimento patriottico con la stesura di due canzoni entrambe rimaste incompiute: Aprile 1814 (sette strofe scritte tra il 22 aprile e il 12 maggio 1814), in cui si rievoca il terremoto politico milanese in chiave patriottica e la denuncia verso la politica napoleonica; e Il proclama di Rimini (aprile 1815), ove Manzoni riflette sull’omonimo discorso tenuto dall’ex re di Napoli Gioacchino Murat per la difesa dell’Italia, e inquadrandolo come un Liberatore inviato da Dio per sottrarre gli italiani alla schiavitù. Manzoni e il dibattito tra classicisti e romantici Gli anni successivi alla conversione furono assai significativi per il panorama letterario e culturale italiano. L’Italia, ancorata a una salda tradizione classicista grazie ai magisteri passati di autori quali Parini e Alfieri, e attuali quali quello del Monti, fu costretta a confrontarsi con la nuova temperie romantica europea. Nel gennaio del 1816, infatti, l’intellettuale francese Madame de Staël pubblicò, sul primo numero del giornale letterario la Biblioteca Italiana, un articolo intitolato Sulla maniera e utilità delle traduzioni, in cui attacca l’ostinato ancoraggio degli italiani a una vacua retorica, ignorando invece le novità letterarie provenienti dalla Germania e dall’Inghilterra. Alla successiva querelle tra classicisti (capeggiati da Pietro Giordani) e romantici (tra i quali spiccano Ludovico di Breme e Giovanni Berchet), Manzoni non partecipò attivamente. Benché fosse apertamente dalla parte dei romantici (l’ode L’ira di Apollo testimonia, in chiave ironica, l’ira del dio della poesia pagano per essere stato escluso dai testi poetici) e partecipasse alla Cameretta letteraria animata da Ermes Visconti, Gaetano Cattaneo, Tommaso Grossi e, soprattutto, dal poeta dialettale Carlo Porta, Manzoni si rifiutò di collaborare apertamente sia alla Biblioteca Italiana che al successore della prima rivista, Il Conciliatore. Oltre all’interesse sempre crescente per la formulazione di una poetica cristiana e l’inizio delle indagini sul genere teatrale, furono determinanti anche la nevrosi depressiva che colpì Manzoni, per la prima volta, nel 1810 (in occasione dello smarrimento di Enrichetta) e, in modo sempre più debilitante, negli anni successivi: questo e la sua difficoltà a parlare in pubblico avevano minato i suoi rapporti interpersonali, costringendolo a una vita tranquilla e ritirata nei suoi possedimenti di Brusuglio o nella quiete del suo palazzo milanese. La produzione teatrale Decisiva fu l’impronta che Manzoni lasciò nella storia del teatro italiano. Dopo la stagione alfieriana, Manzoni intervenne sulla struttura e la finalità stessa del dramma, il quale non deve impegnarsi a descrivere il verosimile (fattore che esclude l’artificiosità delle unità aristoteliche) e i moti dell’anima dei protagonisti, campo d’indagine proprio del poeta e non degli storici di professione, come emerge dalla Lettera a Monsieur Chauvet del 1820. I frutti di tali riflessioni teoriche si possono cogliere nelle tragedie Il Conte di Carmagnola, la cui stesura fu rallentata a causa dei già noti problemi di natura nervosa che affliggevano l’autore e dell’impegno riversato nelle Osservazioni sulla morale cattolica e nella Pentecoste. La seconda tragedia, l’Adelchi, invece, fu edita nel 1822, mentre cominciava a profilarsi, nella mente di Manzoni, la visione narrativa del romanzo. La crisi del 1817 e le Osservazioni sulla morale cattolica (1818-1819) Nella primavera del 1817 Manzoni era andato incontro a una breve crisi spirituale,, determinata da più fattori, in particolare dall’appoggio della Chiesa alla Restaurazione: il liberale Manzoni non concepiva il conflitto tra la religione cristiana, in cui fermamente credeva, e l’orientamento politico della Chiesa Cattolica che non condivideva. La delusione che ne derivò portò all’acuirsi della sua malattia nervosa e a un conseguente raffreddamento nella pratica religiosa, come si evince da una lettera di Tosi al Degola, in cui il padre spirituale dello scrittore comunicava il superamento della crisi (14 giugno 1817). Anche con il futuro vescovo di Pavia c’era stato un piccolo scontro, presto dimenticato, quando Manzoni gli aveva manifestato il desiderio di tornare per un periodo a Parigi, incontrando un’opposizione che gli parve esagerata. Il sacerdote ravvisava infatti nel trasferimento un pericolo per la fede del discepolo, desideroso, al contrario, di rivedere Fauriel, e speranzoso di trarre beneficio per i propri disturbi nervosi. Manzoni chiese ugualmente di poter partire, ma in maggio la polizia gli negò i passaporti. Accantonata provvisoriamente l’ipotesi parigina, Manzoni interruppe il Conte di Carmagnola ritirandosi in campagna, dove si immerse nella lettura di testi filosofici che saranno alla base delle Osservazioni sulla morale cattolica. Le postille manzoniane agli autori studiati sono utili per determinare quali libri affrontasse in quei mesi e per scoprire come lo scrittore li giudicasse. Le postille a Locke, a Condillac e a Destutt de Tracy provano la distanza di Manzoni dal loro pensiero, ma la sua attenzione, nel preparare le Osservazioni, andò soprattutto all’Histoire des Républiques Italiennes di Sismondi, il cui sedicesimo e ultimo volume uscì a Parigi nel 1818. L’opera, che era stata la fonte principale della tragedia, recava nell’ultimo tomo delle violente accuse contro il cattolicesimo, suscitando nel canonico Tosi una reazione indignata, chiedendo così a Manzoni di controbattere: quest’opera apologetica vide le stampe nel 1819, pubblicata col titolo Sulla Morale Cattolica, osservazioni di Alessandro Manzoni, Parte prima. Il secondo soggiorno parigino (1819-1820) Già dal 1817, Manzoni pensava di ritornare a Parigi, luogo felice della giovinezza ove sperava di poter guarire dalle crisi di nervi di cui soffriva sempre più in modo accentuato. I preparativi per la partenza, però, furono sempre rimandati a causa della difficoltà di ottenere i passaporti da parte delle autorità austriache. Solamente nel 1819 Manzoni li ottenne, e con l’intera famiglia partì per la Francia il 14 settembre. Nella capitale francese, Manzoni frequentò lo storico Augustin Thierry e il filosofo Victor Cousin. La conoscenza di Thierry ebbe un’influenza importante sulla concezione manzoniana della storia, e una certa rilevanza ebbe anche lo spiritualismo di Cousin. Benché le idee di quest’ultimo non fossero del tutto eterodosse in materia di religione, affermazioni quali «Sans Dieu, l’homme et la nature restent un mystère» (senza Dio, l’uomo e la natura restano un mistero), oppure «La loi suprème, c’est […] la sainteté, le dévouement, la charité, l’amour du prochain; c’est surtout l’amour de Dieu» («La legge suprema consiste […] soprattutto nella santità, nella devozione, nella carità, nell’amore per il prossimo; si manifesta soprattutto nell’amore di Dio»). Manzoni, però, non trovò giovamento dal soggiorno parigino: le crisi di nervi non erano infatti passate, e cominciava a provare nostalgia di casa. Pertanto, dopo appena un anno, il 25 luglio partì da Parigi con tutta la famiglia per rientrare a Milano l’8 agosto. Passata l’estate, Alessandro iniziò gli anni più frenetici del quindicennio creativo, in cui elaborò quei concetti religiosi/provvidenzialistici che troveranno il culmine nell’Adelchi e nel Cinque maggio, basi fondamentali per l’economia de I promessi sposi, insieme all’inizio della riflessione linguistica, strutturale e artistica del genere del romanzo stesso. Il biennio 1820-1822: le basi del romanzo A partire dal novembre del 1820, infatti, Manzoni cominciò a stendere la tragedia dell’Adelchi. Concluso un primo abbozzo entro la primavera del 1821, improvvisamente Manzoni se ne distolse per riprendere in mano la poesia civile con la stesura di Marzo 1821, celebrante la presunta invasione del Lombardo-Veneto da parte delle truppe sardo-piemontesi dopo l’abdicazione di Vittorio Emanuele I. L’opera lirica (stesa tra il 15 e il 17 marzo), rispetto alle odi di sette anni prima, rivela una maggior compattezza strutturale e sicurezza sia nel tono del linguaggio, sia nel trattare gli stati d’animo dei patrioti italiani. Scemata l’euforia generale dopo il fallimento dei moti del 1820-1821, Manzoni rimise mano all’Adelchi, cominciando a leggere, come per il Conte di Carmagnola, varie fonti storiche (rielaborate nel coevo saggio storico intitolato Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia) perché ci fosse un’aderenza tra il vero storico (cioè gli eventi storici realmente accaduti) e il vero poetico (cioè l’inventio narrativa dello scrittore), concezione della storia appresa alla scuola di Thierry e degli idéologues. L’anno 1821, però, fu pregno di eventi significativi per la storia italiana ed europea: oltre ai moti sopracitati, infatti, il 5 maggio moriva sull’Isola di Sant’Elena l’esiliato Napoleone Bonaparte, notizia che però giunse in Europa soltanto nel mese di luglio. Manzoni aveva letto della scomparsa dell’ex imperatore dei francesi, infatti, su di un articolo della Gazzetta di Milano del 17 luglio 1821, e ne rimase profondamente turbato: il nobile meneghino era affascinato dal titanismo, dal carisma e dal genio militare di Napoleone, e immediatamente si accinse a stendere un’ode che ne ripercorresse la vita. Fu così che, tra il 18 e il 20 luglio, Manzoni compose Il cinque maggio, in cui la grandezza di Napoleone non risiede nelle sue imprese terrene, quanto nell’aver compreso, attraverso le sofferenze dell’esilio, la vanità delle glorie passate e l’importanza assoluta della salvezza. Il parallelo con le vicende di Adelchi e di Ermengarda, dimostra l’intreccio elaborativo di questi mesi, e della formulazione di quella provvida sventura che sarà alla base del romanzo. Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi (1822-1827) Manzoni iniziò a dedicarsi alla scrittura di un romanzo a partire dall’autunno del 1821, ma la stesura vera e propria del Fermo e Lucia era iniziata il 24 aprile 1821, dopo aver letto l’Ivanhoe tradotto in francese. Nella quiete della sua villa di Brusuglio, Manzoni iniziò a scrivere il suo romanzo dopo aver quindi iniziato la lettura dei romanzi europei, specialmente inglesi, in quanto la letteratura italiana si era concentrata su altre tipologie di generi prosaici. Oltre a Walter Scott Manzoni, seguendo la metodologia già adottata per le tragedie, cominciò un vero e proprio lavoro di documentazione storica, basato sulla lettura della Historia patria di Giuseppe Ripamonti e dell’Economia e statistica di Melchiorre Gioia. In base alle postille lasciate dal Manzoni, la prima minuta del Fermo e Lucia (titolo suggerito dall’amico Ermes Visconti, come testimoniato in una lettera del 3 aprile 1822), consisteva in un foglio protocollo diviso in due colonne: a sinistra Manzoni scriveva il testo, mentre sulla destra riportava le correzioni. La seconda fase di stesura del romanzo, dovuta all’ultimazione dell’Adelchi e alla stesura del Cinque maggio, terminò il 17 novembre 1823 e il manoscritto fu edito nel 1825. Il passaggio dal Fermo e Lucia, la cui struttura narrativa risultava poco armonica a causa della divisione in tomi e di ampie parti narrative dedicate a suor Gertrude, a I promessi sposi fu alquanto travagliato per la ridefinizione dell’architettura dell’opera. Oltre al problema espositivo, Manzoni si accorse del linguaggio artificioso e letterario da lui usato, elemento non rispondente alle esigenze realistiche cui tendeva la sua poesia. Scegliendo il toscano come lingua colloquiale per i suoi personaggi, pubblicò la cosiddetta ventisettana (nome dato alla prima edizione de I promessi sposi) ma, consapevole della necessità di ascoltare direttamente l’eloquio di quella regione, decise di partire per Firenze. Il viaggio in Toscana (1827) Il Gabinetto Vieusseux e le basi della Quarantana Nel 1827 Manzoni si trasferì a Firenze per dare vita alla stesura finale del romanzo a livello formale e stilistico, in modo da entrare in contatto e “vivere” la lingua fiorentina delle persone colte, che rappresentava per l’autore l’unica lingua dell’Italia unita. Il viaggio, iniziato il 15 luglio, vide l’intera famiglia Manzoni (i figli, l’anziana madre Giulia e la moglie Enrichetta) passare per Pavia (dove si fermarono per salutare il canonico Tosi, divenuto vescovo della città), Genova, Lucca, Pisa e infine, il 29 agosto, nella capitale del Granducato di Toscana. Il soggiorno, che durerà fino a ottobre, fu un trionfo per don Alessandro: i membri del Gabinetto Vieusseux (con in testa Niccolò Tommaseo, lo stesso Giovan Pietro Vieusseux, Giovanni Battista Niccolini e Gino Capponi) gli vennero incontro con tutti gli onori, e anche lo stesso Giacomo Leopardi, che non ammirava né condivideva l’ideologia e la poetica del Manzoni, lo salutò cordialmente. La fama de I promessi sposi superò presto i confini dei circoli letterari, giungendo presso la stessa corte granducale, ove Leopoldo II in persona ricevette il romanziere. Durante questi incontri (impegnativi per Manzoni, per via dei suoi problemi nervosi), don Alessandro approfondì la sua indagine linguistica, avvalendosi del contatto diretto sia con la nobiltà fiorentina, sia con il popolo, notando la somiglianza della terminologia utilizzata dalle due classi. Il frutto di tali osservazioni fu fondamentale per la scelta del fiorentino (in luogo del generico toscano) come lingua quotidiana per i personaggi del suo romanzo, scelta che portò, nel corso degli anni trenta, a rivedere i suoi promessi sposi, pubblicandoli definitivamente nel 1840 (da qui il nome di Quarantana) insieme alla Storia della colonna infame, un saggio che riprende e sviluppa il tema degli untori e della peste, che già tanta parte aveva avuto nel romanzo, del quale inizialmente costituiva un excursus storico. Gli anni del silenzio (1827-1873) I primi lutti familiari e il secondo matrimonio La quiete famigliare su cui Manzoni aveva instaurato il proprio regime di vita quotidiana, basato sull’affetto che Enrichetta, la madre e i figli nutrivano per lui, si frantumò a partire dagli anni trenta, allorché lo colpirono i primi lutti famigliari: il primo fu quello per l’adorata moglie Enrichetta, morta il 25 dicembre 1833 di tabe mesenterica, malattia contratta a seguito delle numerose gravidanze. Il dolore di Manzoni fu tale che, quando nel 1834 cercò di scrivere Il Natale del 1833, non riuscì a completare l’opera. Dopo Enrichetta, Manzoni vide morire l’adorata figlia primogenita Giulia, già moglie di Massimo d’Azeglio, il 20 settembre del 1834. Il 2 gennaio 1837, grazie agli uffici della madre e dell’amico Tommaso Grossi, sposò Teresa Borri, vedova del conte Decio Stampa e madre di Stefano, figura cui il Manzoni fu molto legato. La nuova moglie di Manzoni, al contrario di Enrichetta, era dotata di una forte personalità e di una buona cultura letteraria. A causa del suo carattere forte e protettivo nei confronti dell’adorato marito, Teresa entrò presto in conflitto sia con l’anziana suocera, sia con lo stesso Grossi, che dovette abbandonare il palazzo di via del Morone dove abitava da più di vent’anni. Gli anni successivi furono ancora costellati dalla morte di molti dei suoi cari: della figlia Cristina (27 maggio 1841), seguita due mesi dopo dalla madre Giulia Beccaria (7 luglio) e, infine, dell’amico Fauriel (1844). Il 1848 e l’esilio a Lesa: Antonio Rosmini e la critica al romanzo Milano, come le altre grandi città europee, non fu immune dalle rivolte che esplosero in tutta Europa: durante le famose cinque giornate di Milano i patrioti riuscirono a scacciare, seppur momentaneamente, gli austriaci del feldmaresciallo Radetzky dalla città. Tra questi uomini imbevuti dell’epos risorgimentale c’era anche il figlio ventiduenne del Manzoni, Filippo, che finì incarcerato all’inizio dei combattimenti. Se il figlio combatteva sulle barricate, il padre Alessandro pubblicò quelle odi politiche (Aprile 1814 e Marzo 1821) che, per timore della rappresaglia austriaca, non aveva mai edito. Al momento del rientro di Radetzky, Manzoni, timoroso di subire delle ripercussioni per il suo sostegno “morale” alla causa risorgimentale, si rifugiò a Lesa, dove la moglie Teresa aveva una villa. Il soggiorno di Lesa, che durerà fino al 1850, non fu un esilio infecondo: a Stresa, non molto lontano, viveva il grande filosofo e sacerdote Antonio Rosmini, conoscente del Manzoni già dal 1827. Il ritiro sul lago Maggiore servì allo scrittore per conoscere meglio l’animo e il pensiero del Rosmini, del quale apprezzò profondamente la personalità e la pietà (oltre alle discussioni religiose, linguistiche e politiche), come si può desumere dal folto carteggio epistolare fra i due uomini. Questi anni, dal punto di vista strettamente letterario, videro Manzoni rigettare quell’equilibrio tra vero storico e vero poetico impostato nel suo romanzo. Attratto in maniera crescente dagli studi linguistici, storici e filosofici, Manzoni sentì sempre più necessaria e urgente la ricerca della "verità oggettiva" condannando, nel saggio Del romanzo storico e, in genere, de’ componimenti misti di storia e di invenzione e nel dialogo Dell’Invenzione (pubblicati entrambi del 1850), la commistione tra inventio e historia. Gli anni del Risorgimento: lutti privati e simbolo della Patria Gli anni seguenti furono assai penosi: nel 1853 morì Tommaso Grossi, nel 1855 l’amico Rosmini e l’anno successivo la figlia Matilde, da tempo ammalata di tisi; nel 1858 lo zio Giulio Beccaria e nel 1861 la moglie Teresa, la cui salute era stata irrimediabilmente compromessa dopo una difficoltosa gravidanza anni addietro. Questa serie di lutti fu alternata dal conferimento di onorificenze da parte del neonato Regno d’Italia, e dalle visite di illustri ospiti. Il 29 febbraio 1860, ancor prima della proclamazione ufficiale del nuovo Stato unitario, fu nominato senatore del Regno di Sardegna per meriti verso la patria. Con questo incarico votò nel 1864 a favore dello spostamento della capitale da Torino a Firenze fintanto che Roma non fosse stata liberata. Dal punto di vista intellettuale, gli ultimi anni videro Manzoni, oltre che conversare col Rosmini, scrivere saggi storici (La Rivoluzione francese del 1789 e la Rivoluzione italiana del 1859: saggio comparativo) e linguistici intorno alla lingua italiana. Come presidente della commissione parlamentare sulla lingua, infatti, Manzoni scrisse, nel 1868, una breve relazione sulla lingua italiana (Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla) indirizzata al ministro Broglio, in cui si cerca di trovare una soluzione pratica alla diffusione del fiorentino in tutta Italia. Il 28 giugno 1872 fu nominato cittadino onorario di Roma. La morte e il funerale Manzoni, a parte i disturbi nervosi da cui era affetto e una malattia che lo colpì nel 1858, godette sempre di ottima salute. L’anno 1873 fu però l’ultimo della sua vita: il 6 gennaio cadde battendo la testa su uno scalino all’uscita dalla chiesa di San Fedele di Milano, procurandosi un trauma cranico. Manzoni si accorse, già dopo qualche giorno, che le sue facoltà intellettive cominciavano lentamente a scemare, fino a cadere in uno stato catatonico negli ultimi mesi di vita. Le sofferenze furono acuite dalla morte del figlio maggiore Pier Luigi, avvenuta il 28 aprile, e quasi un mese dopo, il 22 maggio alle ore sei e quindici del pomeriggio, spirò per una meningite contratta a seguito del trauma. Il corpo fu poi imbalsamato da sette medici incaricati del processo da parte del Comune di Milano tra il giorno 24 e il 27 maggio. Ai solenni funerali del Senatore, celebrati in Duomo il 29, parteciparono le massime autorità dello Stato, tra cui il futuro re Umberto I, il ministro degli esteri Emilio Visconti Venosta e le rappresentanze della Camera, del Senato, delle Province e delle Città del Regno . Felice Venosta ne narra i particolari descrivendo, non senza note di patetismo, lo stato d’animo in cui versava la città al momento della sua scomparsa: Dopo la morte Elogi e critiche L’attacco dei cattolici reazionari La scomparsa di Alessandro Manzoni non suscitò unanime cordoglio: il mondo cattolico più reazionario e clericale, per esempio, non ne compianse la morte. Anzi, i gesuiti de La Civiltà Cattolica la passarono sotto silenzio, per poi scagliarsi contro il Manzoni scrittore e cristiano nell’articolo del 26 giugno 1873, Alessandro Manzoni e Giuseppe Puccianti. Nel grave dissidio tra le due anime del cattolicesimo italiano dell’epoca, Manzoni veniva ritenuto, anche da altri sostenitori dell’ala reazionaria, il vessillo tramite cui i liberali poterono attuare la loro politica laicista e l’abbattimento del potere temporale dei papi. A tal proposito don Davide Albertario, uno dei più accesi critici della religiosità manzoniana e “paradigma” delle accuse mosse dagli zelanti al liberale Manzoni, non risparmiò dure critiche sull’ambiguità del comportamento di Alessandro: Benedetto Croce, nel 1941, riportò come ancora a distanza di anni dopo la morte di Manzoni i cattolici “intransigenti” facessero sentire la loro voce tramite quella di Giovanni Papini: Onoranze postume Nel 1874, nel primo anniversario della morte, Giuseppe Verdi diresse personalmente nella chiesa di San Marco di Milano la Messa di requiem, composta per onorarne la memoria. La mattina del 22 maggio 1883, a dieci anni esatti dalla morte, in presenza del duca di Genova e di una rappresentanza parlamentare, con una cerimonia pubblica la salma fu tolta dal Colombario e posta nel famedio del Cimitero Monumentale di Milano in una tomba di granito rosso con inciso solo il suo nome; nel pomeriggio fu inaugurato il monumento in piazza San Fedele, opera di Francesco Barzaghi. Il 29 dicembre 1923, in occasione del cinquantesimo anno dalla morte, il Regno d’Italia emise una serie commemorativa di sei francobolli ceduta in parte al comitato promotore della celebrazione. La critica letteraria su Manzoni Il mito manzoniano: tra luci e ombre Le prime biografie di Manzoni furono scritte da Cesare Cantù (1885), Stefano Stampa (edita anch’essa nel 1885, in risposta a delle inesattezze del Cantù), Cristoforo Fabris, Angelo De Gubernatis (1879), mentre una parte delle lettere di Manzoni fu pubblicata da Giovanni Sforza nel 1882. La figura enigmatica dello scrittore, costantemente afflitto da sintomi depressivi e relegato ad una vita appartata e isolata dagli eventi mondani, spinsero Paolo Bellezza a comporre il saggio Genio e follia in Alessandro Manzoni (1898), in cui si analizzano paure bizzarre dello scrittore, quali l’agorafobia, gli svenimenti continui e la paura delle pozzanghere. Manzoni non fu però solo oggetto di indagini psicoanalitiche, ma anche di vere e proprie critiche nel campo strettamente letterario: in primo luogo dagli Scapigliati, che videro in Manzoni l’espressione del perbenismo borghese da loro tanto detestato; da Giosuè Carducci, estimatore dell’Adelchi ma implacabile verso il romanzo; da Luigi Settembrini, autore del Dialogo tra Manzoni e Leopardi in cui l’anticlericale napoletano si burla della sua fede cattolica. Ammirazione incondizionata, invece, venne da Francesco De Sanctis, Giovanni Verga, Luigi Capuana e da Giovanni Pascoli, che gli dedicò il saggio critico Eco di una notte mitica (1896). Nel Novecento, a causa dei movimenti anticlassicisti delle avanguardie, dell’evoluzione della lingua e all’edulcoramento della figura del romanziere che veniva insegnata nelle scuole, Manzoni subì varie critiche da parte di letterati e intellettuali: tra questi, D’Annunzio, avverso alla teoria linguistica manzoniana, il “primo” Croce e il marxista Gramsci, che accusò Manzoni di paternalismo. La più importante apologia del Manzoni fu operata dal filosofo Giovanni Gentile, che nel 1923 lo definì, in una conferenza alla Scala, un «grande maestro nazionale» come già avevano fatto Mazzini e Gioberti, ravvisando in lui il promotore di quell’idealismo religioso, in cui Gentile si riconosceva, che costituiva ai suoi occhi le fondamenta del Risorgimento italiano. In difesa di Manzoni si schiererà anche Carlo Emilio Gadda, che al suo esordio pubblicò nel 1927 l’Apologia manzoniana, e nel 1960 attaccò il piano di Alberto Moravia di affossarne la proposta linguistica. Soltanto nel Secondo Novecento, grazie agli studi di Luigi Russo, Giovanni Getto, Lanfranco Caretti, Ezio Raimondi e Salvatore Silvano Nigro si è riusciti a “liberare” Manzoni dalla patina ideologica di cui era stato rivestito già all’indomani della sua morte, indagandone con occhio più libero di pregiudizi la poetica e, anche, la modernità dell’opera. Pensiero e poetica Tra illuminismo e romanticismo Gli esordi neoclassici e illuministi Dopo il periodo della prima giovinezza, caratterizzato da una formazione basata sullo studio dei grandi classici antichi e italiani, il giovane Alessandro entrò in contatto prima col giacobinismo italiano (Lomonaco e Cuoco) poi, dal 1805 in avanti, con il gruppo degli Idéologues francesi (Fauriel, Cabanis). Il risultato fu che il giovane Manzoni aderì fino agli ultimi anni del primo decennio dell’Ottocento a un illuminismo scettico nel campo della religione, in cui predominava il valore per la libertà propugnata dagli ideali rivoluzionari, filtrandoli con gli apporti paideutico-educativi propri della lezione di Giuseppe Parini, del nonno Cesare Beccaria e di Pietro Verri. Dopo la conversione: il Manzoni illuminista Neanche dopo la conversione al Cattolicesimo nel 1810 e il rifiuto dei versi dell’Urania (1809), Manzoni abbandonò totalmente l’apporto illuminista della ragione, della coscienza individuale, e i valori della sua prima educazione. Riconoscendo il ruolo civile del letterato (apporto proprio dell’illuminismo milanese e dell’Alfieri), Manzoni intervenne più volte, sia in privato che nel circolo dell’azione letteraria, nelle vicende della storia, come attestano le Odi civili del 1814 e del 1821. Comunque, il manifesto di questa vocazione “civile” è pienamente espresso a più riprese nella Lettera sul Romanticismo inviata al marchese Cesare d’Azeglio (1823), in cui Manzoni ribadisce il valore sociale che un’opera d’arte letteraria deve avere come principale finalità: L’affinità col romanticismo L’elemento romantico nella produzione poetica manzoniana emerge negli Inni Sacri, dove per la prima volta l’io del poeta si eclissa a favore di un’universalità corale che eleva il suo grido di speranza e la sua fiducia in Dio. La moltitudine degli uomini, il sentimento religioso e l’attenzione ai moti dell’anima nel cuore dei fedeli sono tutti elementi che avvicinano Manzoni al nascente movimento romantico, rendendo il giovane poeta meneghino e la cultura d’oltralpe legati da vincoli estetici e poetici affini. Oltre alla dimensione “ecclesiale” della religiosità manzoniana, non si può dimenticare, per quanto riguarda l’attenzione al popolo, l’apporto fondamentale della storiografia francese di Augustin Thierry e degli idéologues in generale, che propugnavano di incentrare la storia sugli umili, piccoli personaggi che non scemano nell’oblio del tempo perché non sono oggetto d’interesse da parte dei cronisti loro coevi e che subiscono violenza per le decisioni dei potenti. Il cattolicesimo manzoniano Il ruolo della Provvidenza e il giansenismo Persa, alla fine dei primi anni dell’Ottocento, la speranza di raggiungere la serenità per mezzo della ragione, la vita e la storia gli parvero romanticamente immerse in un vano, doloroso, inspiegabile disordine: bisognava trovare un fine salvifico che potesse aiutare l’uomo sia a costituire un codice etico da praticare nella vita terrena, sia a sopportare i mali del mondo in previsione della pace celeste. Il critico Alessandro Passerin d’Entrèves sottolinea l’importanza che ebbero Blaise Pascal e i grandi moralisti francesi del Seicento (Bossuet) nella formazione religiosa del Manzoni: da essi l’autore aveva attinto l’ambizione a conoscere l’animo umano e «la convinzione che il cristianesimo è l’unica spiegazione possibile della natura umana, che è stata la religione cristiana che ha rivelato l’uomo all’uomo», trovando nei loro insegnamenti quella fiducia nella religione come strumento di sopportazione dell’infelicità umana. La fiducia in Dio è il punto di distacco dal pessimismo propugnato da Giacomo Leopardi. Su un terreno così impregnato di pessimismo esistenziale, gioca un ruolo fondamentale la Provvidenza, cioè il modo misterioso con cui Dio agisce nella vita umana elargendo la Salvezza ai suoi figli. Appresa alla scuola del moralista seicentesco Bossuet, la Provvidenza giocherà un ruolo fondamentale non soltanto all’interno de I promessi sposi, ma anche delle altre opere “minori”: i vari personaggi manzoniani dovranno subire patimenti e ingiustizie all’interno del mondo, e soltanto l’agire della Provvidenza (chiamata, in questo contesto doloroso, anche con il nome di provvida sventura) permetterà loro di divenire vittime e di ottenere quella giustizia attesa vanamente sulla terra e che sarà invece elargita in Cielo. Questa visione così pessimista del mondo è dovuta, anche, alle venature profondamente gianseniste che i direttori spirituali di Manzoni, Degola prima e Tosi poi, gli hanno impartito nell’affrontare le vicende umane. In realtà, però, Manzoni rimase sempre, dal punto di vista dogmatico, un cattolico, mantenendo soltanto una severa morale di vita vicina agli ambienti giansenisti. Come sottolinea Giuseppe Langella, sulla questione fondamentale della Grazia «Manzoni si attiene senza riserve all’insegnamento ufficiale della Chiesa, confida nell’esortazione apostolica del vangelo secondo Matteo: “petite, et dabitur vobis”… Nessuna discriminazione, dunque, nell’offerta misericordiosa della grazia. Manzoni è perentorio: l’aiuto divino non è negato a nessuno che lo chieda…». Manzoni drammaturgo e romanziere Tra morale e realismo Il palcoscenico, secondo Manzoni, non deve veicolare passioni e forti emozioni, nell’esasperazione dell’io del protagonista, ma indurre lo spettatore a meditare sulle scene cui assiste: all’«identificazione emozionale» di Racine e del teatro francese bisogna sostituire la «commozione meditata», per dirla con Gino Tellini. La vicenda e la rappresentazione devono trasmettere un messaggio cristiano, senza per questo presentare una realtà idilliaca: al contrario, Manzoni va in cerca di personaggi, che, come Francesco Bussone (il conte di Carmagnola), si oppongano al male che domina la società umana, anche a prezzo della loro vita. L’importante è che il drammaturgo cerchi la verità e si mantenga fedele alla realtà storica (il vero storico), lasciando al poeta il compito di indagare ciò che il cuore umano del protagonista può aver provato in un determinato contingente. Si profila, pertanto, quella forte vena realistica che dominerà anche l’economia del romanzo, dal Fermo e Lucia fino alla Quarantana de I promessi sposi, dove il realismo emerge proprio dall’ultimo capitolo: non c’è un lieto fine, ma una ripresa della vita quotidiana spezzata però dalle disavventure dei protagonisti. L’allontanamento da Lecco di Renzo e Lucia e la ripresa delle attività giornaliere sono il frutto della scelta, da parte dell’autore, di far continuare, nelle situazioni della vita quotidiana, le vite dei due protagonisti all’interno della quotidianità storica. La Questione della lingua in Manzoni Manzoni, sulla spinta del romanticismo e della sua necessità di instaurare un dialogo con un vasto pubblico eterogeneo, si prefisse lo scopo di trovare una lingua in cui ci fosse un lessico pregno di termini legati all’uso quotidiano e agli ambiti specifici del sapere, e priva di una grande disparità tra la lingua parlata e quella scritta. Questo percorso, iniziato già all’indomani della pubblicazione del Fermo e Lucia, vide Manzoni passare, tra il 1822 e il 1827, dal “compromesso” della buona lingua letteraria all’avvicinamento col toscano, e si concluse dopo anni di studi linguistici (facilitati anche dalla presenza della governante fiorentina Emilia Luti) nel 1840 con la revisione linguistica de I promessi sposi sul modello del fiorentino colto, che presentava ancor più del toscano questa dimensione unitaria tra la dimensione orale e quella letteraria. Infatti, tra l’edizione del 1827 e quella del 1840 vengono eliminati tutti quei lemmi toscani municipali e distanti dall’uso del fiorentino corrente. Tale scelta linguistica, benché approvata dal ministro Emilio Broglio nella relazione del 1868, non fu accettata da tutti i contemporanei del Manzoni: Carlo Tenca, in un articolo datato 11 gennaio 1851 della rivista «Crepuscolo», si oppose alla soluzione manzoniana. L’uomo Manzoni Una vita a prima vista tranquilla Come conseguenza del suo stile di vita estremamente riservato, non è facile inquadrare Manzoni come uomo. Egli visse perlopiù appartato dalla vita pubblica, mantenendosi estraneo dai principali eventi mondani della città (se si eccettua la frequentazione del salotto intellettuale tenuto da Clara Maffei) e distante dall’impegno politico attivo dei grandi moti nazionalistici che stavano sconquassando l’Italia nel pieno del fervore risorgimentale, mantenendo però una posizione culturalmente e moralmente favorevole alla causa dell’Unità (si vedano l’Adelchi e Marzo 1821), che lo spingerà ad accettare la nomina a senatore a vita durante la vecchiaia. La ragione di questo atteggiamento, oltre che al carattere del Manzoni, è forse da ricercare nei suoi continui disturbi nevrotici (che curava con lunghissime passeggiate e uno stile di vita estremamente regolare) come agorafobia, attacchi di panico, ipocondria, svenimenti, fobie varie (timore della folla, dei tuoni e delle pozzanghere). Amante del quieto vivere, condusse apparentemente una vita silenziosa tra Brusuglio (ove lo scrittore si dilettava di botanica e giardinaggio, intessendo con Fauriel un ricco epistolario al riguardo) e via del Morone, dedito ai suoi studi, alla cura della famiglia (anche se, per i complessi di cui era afflitto, era sempre oggetto di cure da parte dei suoi cari) e alla coltivazione delle amicizie più strette. Nella conversazione usava l’italiano con i visitatori provenienti da altre regioni italiane, ma soprattutto adoperava il dialetto milanese nella vita quotidiana. Inetto nell’amministrazione dei suoi beni, dimostrava al contrario una grande attenzione nei confronti del mondo che lo circondava, non mancando di giudicare, placidamente e con ironia, gli eventi politici e sociali di cui veniva a conoscenza, o di adottare autoironia verso i suoi mali. Le persone a lui più vicine ne sottolineavano la cortesia, la memoria vivacissima, l’ingegno e una capacità discorsiva elegante, benché minato dalla balbuzie di cui lo scrittore era afflitto. La descrizione fisica Il figliastro Stefano Stampa, infine, offre un ritratto fisiognomico assai dettagliato del patrigno, delineandone anche i movimenti e quel sorriso indice del suo carattere ironico: Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manzoni
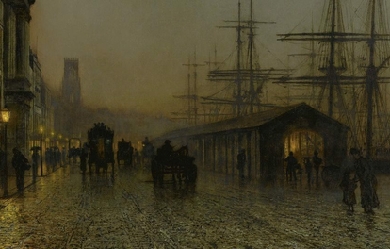

Edward Dowden (/ˈdaʊdən/; 3 May 1843– 4 April 1913), was an Irish critic and poet. Biography He was the son of John Wheeler Dowden, a merchant and landowner, and was born at Cork, three years after his brother John, who became Bishop of Edinburgh in 1886. Edward’s literary tastes emerged early, in a series of essays written at the age of twelve. His home education continued at Queen’s College, Cork and at Trinity College, Dublin; at the latter he had a distinguished career, becoming president of the Philosophical Society, and winning the vice-chancellor’s prize for English verse and prose, and the first senior moderatorship in ethics and logic. In 1867 he was elected professor of oratory and English literature in Dublin University. Dowden’s first book, Shakespeare, his Mind and Art (1875), resulted from a revision of a course of lectures, and made him widely known as a critic: translations appeared in German and Russian; his Poems (1876) went into a second edition. His Shakespeare Primer (1877) was translated into Italian and German. In 1878 the Royal Irish Academy awarded him the Cunningham gold medal “for his literary writings, especially in the field of Shakespearian criticism.” Later works by him in this field included an edition of The Sonnets of William Shakespeare (1881), Passionate Pilgrim (1883), Introduction to Shakespeare (1893), Hamlet (1899), Romeo and Juliet (1900), Cymbeline (1903), and an article entitled “Shakespeare as a Man of Science” (in the National Review, July 1902), which criticized T.E. Webb’s Mystery of William Shakespeare. His critical essays “Studies in Literature” (1878), “Transcripts and Studies” (1888), “New Studies in Literature” (1895) showed a profound knowledge of the currents and tendencies of thought in various ages and countries; but his Life of Shelley (1886) made him best known to the public at large. In 1900 he edited an edition of Shelley’s works. Other books by him which indicate his interests in literature include: Robert Southey (in the “English Men of Letters” series, 1880), his edition of Southey’s Correspondence with Caroline Bowles (1881), and Select Poems of Southey (1895), his Correspondence of Sir Henry Taylor (1888), his edition of Wordsworth’s Poetical Works (1892) and of his Lyrical Ballads (1890), his French Revolution and English Literature (1897; lectures given at Princeton University in 1896), History of French Literature (1897), Puritan and Anglican (1900), Robert Browning (1904) and Michel de Montaigne (1905). His devotion to Goethe led to his succeeding Max Müller in 1888 as president of the English Goethe Society. In 1889 he gave the first annual Taylorian Lecture at the University of Oxford, and from 1892 to 1896 served as Clark lecturer at Trinity College, Cambridge. To his research are due, among other matters of literary interest, the first account of Thomas Carlyle’s Lectures on periods of European culture; the identification of Shelley as the author of a review (in The Critical Review of December 1814) of a lost romance by James Hogg; a description of Shelley’s Philosophical View of Reform; a manuscript diary of Fabre d’Églantine; and a record by Dr Wilhelm Weissenborn of Goethe’s last days and death. He also discovered a Narrative of a Prisoner of War under Napoleon (published in Blackwood’s Magazine), an unknown pamphlet by Bishop Berkeley, some unpublished writings of William Hayley relating to Cowper, and a unique copy of the Tales of Terror. His wide interests and scholarly methods made his influence on criticism both sound and stimulating, and his own ideals are well described in his essay on The Interpretation of Literature in his Transcripts and Studies. As commissioner of education in Ireland (1896–1901), trustee of the National Library of Ireland, secretary of the Irish Liberal Union and vice-president of the Irish Unionist Alliance, he enforced his view that literature should not be divorced from practical life. His biographical/critical concepts, particularly in connection with Shakespeare, are played with by Stephen Dedalus in the library chapter of James Joyce’s Ulysses. Leslie Fiedler was to play with them again in The Stranger in Shakespeare. Dowden married twice, first (1866) Mary Clerke, and secondly (1895) Elizabeth Dickinson West, daughter of the dean of St Patrick’s. His daughter by his first wife, Hester Dowden, was a well-known spiritualist medium. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Dowden
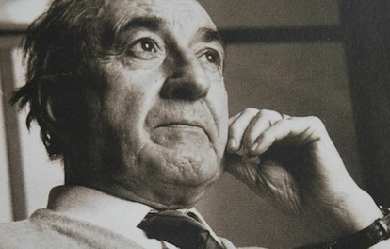
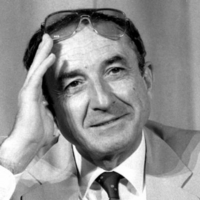
Giovanni Giudici (Porto Venere, 26 giugno 1924 – La Spezia, 24 maggio 2011) è stato un poeta e giornalista italiano. Cresciuto nel borgo marinaro di Le Grazie vicino a Porto Venere, è stato un aderente alla linea della poesia anti-novecentesca. Biografia Figlio di Gino Giudici, impiegato presso vari enti privati, e Alberta Giuseppina Portunato, maestra elementare nella scuola dell’isola Palmaria e poi in quella delle Grazie, il poeta è il quartogenito e l’unico sopravvissuto di cinque figli tutti morti poco dopo la nascita o al momento del parto. Gli anni dell’infanzia e i primi studi Alle Grazie, dove il nonno paterno, discendente da una famiglia di piccoli possidenti di Casale Marittimo (Pisa), esercita la professione di farmacista, abitano anche i nonni materni e Giovanni trascorre i primi anni dell’infanzia nel paese natio tra la casa dei genitori e quella dei nonni ricevendo dalla madre una seria educazione cattolica. La morte della madre, avvenuta l’8 novembre 1927 per una eclampsia da parto, lascia in Giovanni una “voragine di privazione” che anziché colmarsi si allargherà col trascorrere degli anni. Nel 1928, il padre Gino si risposa con Clotilte Carpena, dalla quale avrà cinque figli, e nel 1929 si trasferisce a Cadimare aumentando così la sofferenza di Giovanni che deve allontanarsi dalle Grazie e dai nonni. A Cadimare egli frequenta presso un Istituto di suore l’asilo e, avendogli il padre fatto saltare una classe, la seconda elementare, ma verso la fine degli anni trenta il padre si trasferisce con i suoi familiari alla Spezia e sarà questo un altro periodo difficile per Giovanni che risentirà della ristrettezza economica della famiglia e dei ricatti sentimentali ai quali lo sottopongono, pur a fin di bene, i nonni paterni e i parenti della madre che lo vorrebbero in affido. Alle Grazie Giovanni riuscirà a tornare nel 1932 e a frequentare per due trimestri la quarta elementare fino a quando il padre Gino, impiegato presso l’Istituto ISTAT e in seguito al Ministero della guerra, si trasferisce, nel 1933, a Roma e, in attesa di un definitivo alloggio, colloca il figlio presso il Pontificio Collegio Pio X dove Giovanni rimane fino alla primavera del 1935 terminando la quinta elementare e la prima ginnasiale. Durante l’estate però gli è concesso di trascorrere le vacanze alla Grazie presso le famiglie dei nonni e della zia materna Angela. Gli studi superiori Nel 1935, quando la famiglia ottiene l’assegnazione di un appartamento dell’Istituto Case Popolari, il padre gli fa lasciare il collegio ed egli prosegue gli studi presso l’Istituto Quinto Orazio Flacco a Monte Sacro.Risalgono a questo periodo i primi tentativi poetici tra i quali rimane un sonetto, ispirato al monumento che si trova sul piazzale di Porta Pia, intitolato Il bersagliere. La famiglia intanto si trova sempre in gravi difficoltà economiche e Giovanni riceverà in dono i libri scolastici da alcune sue insegnanti tra le quali Letizia Falcone che diventerà in seguito nota ispanista e traduttrice di Cervantes e di Teresa di Lisieux. Scrive in questo periodo altri componimenti poetici, sempre in forma di sonetto, dedicati ad una compagna di scuola. Risalgono a questo periodo le sue numerose letture extrascolastiche che, non avendo i mezzi per comprarsi i libri, compie prendendoli in prestito preso la Biblioteca comunale. Nel 1939 si iscrive al Liceo classico statale Giulio Cesare presso la sezione staccata di Monte Sacro e al termine della seconda liceo, con la media di otto decimi, può affrontare direttamente l’esame di maturità e per pagarsi le lezioni di matematica dà, a sua volta, lezioni di greco e latino. L’università e i primi racconti Su insistenza del padre, nel 1941, si iscrive alla facoltà di Medicina ma è attirato da quella di Lettere dove si reca spesso ad ascoltare le lezioni. Proprio alla fine del 1941 risalgono i primi contatti con i militanti dell’antifascismo a Monte Sacro e in seguito, sempre più frequenti, quelli con i gruppi romani e del PCI. Nella primavera del 1942 decide di cambiare il corso di studi e si iscrive alla Facoltà di Lettere dove frequenta i corsi di famosi maestri come Giulio Bertoni di Filologia romanza, Alfredo Schiaffini di Storia delle Lingue, Gino Funaioli di Letteratura latina, Natalino Sapegno di Letteratura italiana, Antonino Pagliaro di Glottologia, Giuseppe Cardinali di Storia romana, Pietro Paolo Trompeo di lingua e letteratura francese, Gennaro Perrotta di letteratura greca. Si ampliano le sue conoscenze letterarie e le letture diventano più varie. Risale a questo periodo, come il poeta stesso ci racconta, le letture di Rilke e di Campana, la lettura assidua della rivista Primato di Bottai e stringe amicizia con un suo compagno di studi, Ottiero Ottieri. Risalgono al 1943 i suoi primi racconti e un gruppo di poesie che gli vengono però rifiutate. Legge una poesia di Sereni sul settimanale Tempo edito da Mondadori e, sempre sullo stesso settimanale qualche poesia di Ungaretti, Quasimodo, Penna e Gatto. Il periodo della guerra Nel periodo della guerra, per non essere richiamato al servizio militare, trova rifugio presso la casa di un amico dove rimane nascosto e dopo l’8 settembre partecipa, all’interno del quartiere dove abita, all’attività clandestina del Partito d’Azione e fonda, insieme ad un gruppo, il giornale “La nostra lotta”. Il 6 gennaio 1944 riesce ad entrare nella Guardia di Finanza della Città aperta di Roma dove presta servizio per sette mesi e il 4 giugno assiste alla presa di Roma da parte dell’esercito statunitense. Riprende intanto gli studi interrotti e per aiutare finanziariamente la famiglia dà lezioni private. Conosce in questo periodo il sacerdote Ernesto Buonaiuti che era stato privato dell’insegnamento universitario per non aver voluto giurare fedeltà al regime fascista che gli offre di lavorare per qualche tempo per lui scrivendo a macchina sotto dettatura. Risale al luglio del 1944 il racconto L’odore d’acetilene e verso la fine dell’anno trova lavoro come garzone di cucina presso la caserma della Royal Air Force inglese ma presto, dietro raccomandazione si inserisce al Ministero dell’interno e viene assegnato alla Questura di Roma dove lavora per un po’ di tempo all’ufficio stampa. Pubblica nel frattempo, sulla rivista "1945" diretta dal Buonaiuti, due articoli sul pensiero di Charles Péguy e riesce, con i primi guadagni, ad acquistare Il Canzoniere di Saba. Continua a cimentarsi con il racconto e scrive Il colore blu della morte, Uomini a gara oltre ad alcune poesie e il 1º agosto dibatte una tesi di laurea, con il relatore Pietro Paolo Trompeo, in Letteratura francese sul poeta francese Anatole France, anche se avrebbe desiderato lavorare su Charles Baudelaire, e prima della fine dell’anno entra a far parte del PSIUP come segretario del circolo giovanile di Monte Sacro. Gli anni del dopoguerra Nella primavera del 1946 riesce a trascorrere un periodo di vacanza a Monte Sacro che sente sempre di più essere il paese che maggiormente ama. Cresce in lui, oltre il bisogno di poesia, il desiderio di mettere ordine nella sua vita, come avere un lavoro stabile, una famiglia e una casa, ma la sua situazione economica non glielo permette ancora. Continua a svolgere attività politica nello PSIUP e comincia a compiere i primi viaggi a Milano e a Torino, dove fa diverse importanti conoscenze e sul numero speciale del 2 giugno di “Rivoluzione Socialista”, il supplemento settimanale dell’"Avanti!", esce la sua prima poesia edita dal titolo Compagno, qualche volta. L’attività di giornalista Inizia nel 1947 la sua attività di cronista presso il quotidiano "L’Umanità" di Roma, venendo assunto come giornalista professionista il 1º gennaio 1948, col ruolo di capocronista. Alla chiusura del giornale, il 31 luglio dello stesso anno, Giudici passa alla redazione de "L’Umanità" di Milano. Durante questo periodo conosce Mario Picchi con il quale stringe una salda amicizia. Nel dicembre del 1947 ha l’occasione di ascoltare Thomas Stearns Eliot che legge i suoi versi nell’aula magna del Collegio Romano, avvenimento che lo riempie di entusiasmo. Nel frattempo ottiene l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media. Nel 1949, grazie ad Alberto Frattini che aveva conosciuto ai tempi dell’università, riesce a pubblicare due liriche (Là dove gli angeli cantano, Sola caduta a infrangere) e un articolo su Saba sulla rivista Accademia e il 14 settembre su Il cittadino. Settimanale dell’Italia socialista propone un’inchiesta che riguarda i viaggi all’estero degli italiani. Negli anni collabora con vari giornali di sinistra, come l’Espresso, l’Unità e Rinascita. Legge in questo periodo l’opera di Piero Jahier (Ragazzo), che conoscerà a Milano nel 1963, e ne rimane molto colpito. Gli si offrono intanto tre proposte di lavoro, l’insegnamento in una scuola media di Velletri, l’assunzione nella redazione di “Paese Sera” e un impiego presso gli uffici romani dell’USIS (United States Information Service) che dipendono dall’ambasciata statunitense. Egli sceglie quest’ultimo, anche perché meglio retribuito, ed inizia l’attività come redattore del bollettino quotidiano da inviare ai vari giornali. Opere * Fiorì d’improvviso, Roma, Edizioni del Canzoniere, 1953. * La stazione di Pisa e altre poesie, Urbino, Istituto Statale d’Arte, 1955. * L’intelligenza col nemico, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1957. * L’educazione cattolica (1962-1963), Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1963. * La vita in versi, Milano, Mondadori, 1965. * Autobiologia, Milano, Mondadori, 1969. * O Beatrice, Milano, Mondadori, 1972. * Poesie scelte (1957-1974), a cura di Fernando Bandini, Milano, Mondadori, 1975. * Il male dei creditori, Milano, Mondadori, 1977. * Il ristorante dei morti, Milano, Mondadori, 1981. * Lume dei tuoi misteri, Milano, Mondadori, 1984. * Salutz (1984-1986), Torino, Einaudi, 1986. * Prove del teatro, Torino, Einaudi, 1989. * Frau Doktor, Milano, Mondadori, 1989. * Fortezza, Torino, Milano, Mondadori, 1990. * Poesie (1953-1990), Milano, Garzanti, 1991 (2 voll.). * Quanto spera di campare Giovanni, Milano, Garzanti, 1993. * Un poeta del golfo, a cura di Carlo Di Alesio, Milano, Longanesi, 1995. * Empie stelle, Milano, Garzanti, 1996. * Eresia della Sera, Milano, Garzanti, 1999. * I versi della vita, a cura di Rodolfo Zucco, Milano, Mondadori, 2000 (I Meridiani). * Dedicato ai pompieri di New York da 'Poesia’, 2001. * Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002, Casette d’Ete, Grafiche Fioroni, 2004. * Prove di vita in versi. Il primo Giudici da 'Istmi. Tracce di vita letteraria’, 2012. * Tutte le poesie, introduzione di Maurizio Cucchi, Milano, Mondadori, 2014. Saggi * La letteratura verso Hiroshima e altri scritti (1959-1975), Roma, Editori Riuniti, 1976. * La dama non cercata. Poetica e letteratura (1968-1984), Milano, Mondadori, 1985. * Andare in Cina a piedi. Racconto sulla poesia, Roma, Edizioni e/o, 1992. * Per forza e per amore, Milano, Garzanti, 1996. Traduzioni * Addio, proibito piangere e altri versi tradotti (1955-1980), Torino, Einaudi, 1982. * A una casa non sua. Nuovi versi tradotti (1955-1995), Milano, Mondadori, 1997. * Eugenio Onieghin di Aleksandr S. Puskin in versi italiani, Milano, Garzanti, 1999. * Vaga lingua strana. Dai versi tradotti, Milano, Garzanti, 2003. Altri progetti * Wikiquote contiene citazioni di o su Giovanni Giudici * Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giovanni Giudici Collegamenti esterni * Giovanni Giudici, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana. * Pagina dedicata a Giovanni Giudici da Scrittori in corso, su scrittorincorso.net. * Rodolfo Zucco, Itinerari di Spina, in Atti di INCONTROTESTO. Ciclo di incontri su e con scrittori del Novecento e contemporanei, Siena, ottobre-novembre 2011, Pisa, Pacini editore, 2011, pp. 77–83. Damiano Frasca, Vite ordinarie. Giudici e il crepuscolarismo, in Atti di INCONTROTESTO. Ciclo di incontri su e con scrittori del Novecento e contemporanei, Siena, ottobre-novembre 2011, Pisa, Pacini editore, 2011, pp. 85–91. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giudici

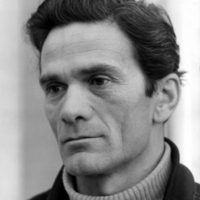
Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 – Roma, 2 novembre 1975) è stato un poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, drammaturgo e giornalista italiano, considerato tra i maggiori artisti e intellettuali del XX secolo. Culturalmente versatile, si distinse in numerosi campi, lasciando contributi anche come pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista, non solo in lingua italiana, ma anche friulana. Attento osservatore dei cambiamenti della società italiana dal secondo dopoguerra sino alla metà degli anni settanta nonché figura a tratti controversa, suscitò spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi, assai critici nei riguardi delle abitudini borghesi e della nascente società dei consumi, come anche nei confronti del Sessantotto e dei suoi protagonisti. Il suo rapporto con la propria omosessualità fu al centro del suo personaggio pubblico. Biografia L’infanzia e la giovinezza Pier Paolo Pasolini, primogenito dell’ufficiale di fanteria bolognese Carlo Alberto Pasolini e della maestra casarsese Susanna Colussi, nacque nella zona universitaria di Bologna il 5 marzo 1922 in una foresteria militare, in via Borgonuovo 4, dove ora c’è una targa in marmo che lo ricorda. A causa dei frequenti trasferimenti del padre, la famiglia, che da Bologna si era già trasferita a Parma, nel 1923 si trasferì a Conegliano, e nel 1925 a Belluno, dove nacque il fratello Guido Alberto. A Belluno viene mandato all’asilo dalle suore, ma dopo pochi giorni si rifiuta di andarci e la famiglia acconsente. Nel 1927 i Pasolini furono nuovamente a Conegliano, dove Pier Paolo prima di compiere i sei anni fu iscritto alla prima elementare. L’anno successivo traslocarono a Casarsa della Delizia, in Friuli, ospiti della casa materna, poiché il padre era agli arresti per alcuni debiti. La madre, per far fronte alle difficoltà economiche, riprese l’insegnamento. Terminato il periodo di detenzione del padre, ripresero i trasferimenti a un ritmo quasi annuale. Fondamentali rimasero i soggiorni estivi a Casarsa. Nel 1929 i Pasolini si spostarono nella vicina Sacile, sempre in ragione del mestiere del capofamiglia, e in quell’anno Pier Paolo aggiunse alla sua passione per il disegno quella della scrittura, cimentandosi in versi ispirati ai semplici aspetti della natura che osservava a Casarsa. Dopo un breve soggiorno a Idria nella Venezia Giulia (oggi in territorio sloveno), la famiglia ritornò a Sacile, dove Pier Paolo affrontò l’esame di ammissione al ginnasio. Venne bocciato in italiano, per poi superare la prova a ottobre. A Conegliano cominciò a frequentare la prima classe, ma a metà dell’anno scolastico 1932-1933 il padre fu trasferito a Cremona, dove la famiglia rimase fino al 1935 e Pier Paolo frequentò il Liceo Ginnasio Daniele Manin. Fu questo un triennio di intense fascinazioni e di un precoce ingresso nell’adolescenza, come testimonia il vibrante tratto autobiografico Operetta marina, scritto alcuni anni più tardi e pubblicato postumo assieme a Romàns. Successivamente il padre ebbe un nuovo trasferimento a Scandiano, con gli inevitabili problemi di adattamento per il tredicenne causati anche dal cambiamento di ginnasio a Reggio Emilia, che raggiungeva in treno.In Pier Paolo crebbe la passione per la poesia e la letteratura, mentre lo abbandonava il fervore religioso del periodo dell’infanzia. Completato il ginnasio a Reggio Emilia, frequentò il Liceo Galvani di Bologna, dove incontrò il primo vero amico della giovinezza, il reggiano Luciano Serra. A Bologna, dove avrebbe trascorso sette anni, Pier Paolo coltivò nuove passioni, come quella del calcio, e alimentò la sua passione per la lettura comprando numerosi volumetti presso le bancarelle di libri usati sotto il portico della Libreria Nanni, circa di fronte a Piazza Maggiore. Le letture spaziavano da Dostoevskij, Tolstoj e Shakespeare ai poeti romantici del periodo di Manzoni.Al Liceo Galvani di Bologna fece conoscenza con altri amici, tra i quali Ermes Parini, Franco Farolfi, Elio Melli, e con loro costituì un gruppo di discussione letteraria. Intanto la sua carriera scolastica proseguiva con eccellenti risultati e nel 1939 venne promosso alla terza liceo con una media tanto alta da indurlo a saltare un anno per presentarsi alla maturità in autunno. Si iscrisse così, a soli diciassette anni, alla Facoltà di Lettere dell’Università di Bologna, e scoprì nuove passioni culturali, come la filologia romanza e soprattutto l’estetica delle arti figurative insegnata al tempo dall’affermato critico d’arte Roberto Longhi. Frequentava intanto il Cineclub di Bologna dove si appassionò al ciclo dei film di René Clair; si dedicò allo sport e fu promosso capitano di calcio della Facoltà di Lettere; faceva gite in bicicletta con gli amici e frequentava i campeggi estivi che organizzava l’Università di Bologna. Con gli amici – l’immagine da offrire ai quali era sempre quella del “noi siamo virili e guerrieri”, perché non percepissero nulla dei suoi travagli interiori – si incontrava, oltre che nelle aule dell’Università, anche nei luoghi istituiti dal Regime fascista per la gioventù, come il GUF, i campeggi della “Milizia”, le competizioni dei Littoriali della cultura. Procedevano in questo periodo le letture delle Occasioni di Montale, di Ungaretti e delle traduzioni dei lirici greci di Quasimodo, mentre fuori dall’ambito poetico leggeva soprattutto Freud e ogni cosa che fosse disponibile in traduzione italiana. Nel 1941 la famiglia Pasolini trascorse come ogni anno le vacanze estive a Casarsa, e Pier Paolo scrisse poesie che allegava alle lettere per gli amici bolognesi tra i quali, oltre l’amico Serra, erano inclusi Roberto Roversi e il cosentino Francesco Leonetti, verso i quali sentiva un forte sodalizio: Il padre era stato richiamato in servizio ed era partito per l’Africa Orientale, dove verrà fatto prigioniero dagli Inglesi. I quattro giovani pensarono di fondare una rivista dal titolo Eredi alla quale Pasolini volle conferire un programma sovraindividuale: La rivista non vedrà la luce a causa delle restrizioni ministeriali sull’uso della carta, ma quell’estate del 1941 rimarrà per i quattro amici indimenticabile. Cominciarono intanto ad apparire nelle poesie di Pasolini alcuni frammenti di dialogo in friulano anche se le poesie inviate agli amici continuavano a essere composte da versi improntati alla letteratura in lingua italiana. Le prime esperienze letterarie Di ritorno da Casarsa all’inizio dell’autunno scoprì di aver nel cuore la lingua friulana e tra gli ultimi mesi del 1941 e i primi del 1942 scrisse i versi che, raccolti in un libretto intitolato Poesie a Casarsa, verranno pubblicati il 14 luglio 1942, a spese dell’autore, e saranno subito notati da Gianfranco Contini (che gli dedicherà una recensione positiva), da Alfonso Gatto e dal critico Antonio Russi. Nel luglio 1942 passò tre settimane in un campo di addestramento per allievi ufficiali presso Porretta Terme.A Bologna intanto riprese la fervida vita culturale, che si svolse all’interno dell’università, e, anche perché incoraggiato dal giudizio positivo che Francesco Arcangeli aveva dato ai suoi quadri, chiese di svolgere una tesi di laurea sulla pittura italiana contemporanea con Roberto Longhi, docente di Storia dell’arte. Di questa tesi, il cui manoscritto andrà perduto durante i giorni dell’otto settembre del 1943, Pasolini abbozzerà solamente i primi capitoli per poi rinunciarvi e passare a una tesi più motivata sulla poesia di Pascoli. Scelto come relatore il suo professore di letteratura italiana Carlo Calcaterra, Pasolini lavorò al progetto dell’Antologia della poesia pascoliana (introduzione e commenti) tra il 1944 e il 1945, mettendo a punto, dopo un’ampia introduzione in cui sono esposte e discusse le premesse teoriche della tesi, una personale selezione di testi provenienti dalle differenti raccolte del Pascoli, analizzati e commentati con sensibilità peculiare. Il 26 novembre 1945, Pasolini si laureò in Lettere con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi su Giovanni Pascoli ma solo nel 1993 l’Antologia vide la luce per la casa editrice Einaudi. La GIL di Bologna aveva intanto in programma di pubblicare una rivista, Il Setaccio, con qualche fronda culturale. Pasolini aderì insieme e ne diventò viceredattore, ma presto entrò in contrasto con il direttore responsabile, Giovanni Falzone, che era molto ligio alla retorica del regime. La rivista cesserà le pubblicazioni dopo soli sei numeri ma rappresenterà per Pasolini un’esperienza importante, grazie alla quale comprenderà la natura regressiva e provinciale del fascismo e maturerà un atteggiamento culturale antifascista anche grazie all’incontro con Giovanna Bemporad a cui propose di tradurre per la rivista dove lei si firmava Giovanna Bembo per sfuggire alle leggi razziali.Nell’autunno del 1942 partecipò a un viaggio nella Germania nazista, organizzato come incontro della gioventù universitaria dei paesi fascisti, che gli rivelò aspetti della cultura europea sconosciuti al provincialismo italiano. Al ritorno dal viaggio pubblicò, sulla rivista del GUF, l’articolo Cultura italiana e cultura europea a Weimar (gennaio 1943), che anticipava già quello che sarà il Pasolini “corsaro”, e sul “Setaccio” tracciò le linee di un programma culturale i cui principi erano quelli dello sforzo di autocoscienza, del travaglio interiore, individuale e collettivo, e della sofferta sensibilità critica, un percorso che lo poneva già al di fuori del fascismo. Il periodo della guerra Il 1942 si concluse con la decisione della famiglia di sfollare in Friuli, a Casarsa, ritenuto un luogo più tranquillo e sicuro per attendere la fine della guerra. Nel 1943 a Casarsa il giovane Pier Paolo fu colto da quei turbamenti erotici che in passato aveva cercato di allontanare: Continuava intanto a tenersi in contatto epistolare con gli amici, ai quali questa volta non volle nascondere nulla, raccontando quanto gli stava capitando: Alla vigilia dell’Armistizio, Pasolini fu chiamato alle armi. Costretto ad arruolarsi a Pisa il primo settembre 1943, una settimana dopo, l’8 settembre, disobbedì all’ordine di consegnare le armi ai tedeschi e riuscì a fuggire dalla deportazione travestito da contadino e a rifugiarsi a Casarsa. Lì c’erano alcuni giovani appassionati di poesia (Cesare Bortotto, Riccardo Castellani, Ovidio Colussi, Federico De Rocco e il cugino Domenico Naldini) con i quali fondò l’Academiuta di lenga furlana che si proponeva di rivendicare l’uso letterario del friulano casarsese contro l’egemonia di quello udinese. Il nuovo gruppo si propose di pubblicare una rivista che fosse in grado di rivolgersi al pubblico del paese e nello stesso tempo promuovere la sua poetica. Il primo numero della rivista uscì nel maggio del 1944 con il titolo "Stroligùt di cà da l’aga" ("Lunario [pubblicato] di qua dall’acqua [il Tagliamento]"). Nel frattempo la tranquillità di Casarsa era compromessa dai bombardamenti e dai rastrellamenti di fascisti per l’arruolamento forzato nel nuovo esercito della Repubblica di Salò e cominciavano a formarsi i primi gruppi partigiani. Pier Paolo cercò di astrarsi il più possibile dedicandosi agli studi e alla poesia, e intanto tenne lezioni private per quegli studenti che a causa dei bombardamenti non potevano raggiungere le scuole di Pordenone o il ginnasio di Udine.Nell’ottobre del 1944 Pier Paolo e la madre – il fratello Guido si era intanto unito alle formazioni partigiane della Carnia – si trasferirono a Versuta, che sembrava essere un luogo più tranquillo e lontano dagli obiettivi militari. Nel villaggio mancava la scuola e i ragazzi dovevano percorrere più di tre chilometri per raggiungere la loro sede scolastica a Casarsa che era stata bombardata. Susanna e Pier Paolo decisero così di aprire una scuola gratuita nella loro casa. Pier Paolo visse il suo primo amore in quei momenti per un allievo tra i più grandi («In quelle membra splendevano un’ingenuità, una grazia… o l’ombra di una razza scomparsa che durante l’adolescenza riaffiora») e, al contempo, si innamorò di lui una giovane violinista slovena, Pina Kalc (Josipina Kalc), che aveva raggiunto con la sua famiglia il rifugio di Pasolini. La vicenda del ragazzo e l’amore di Pina per lui si intrecciarono complicando dolorosamente quei lunghi mesi che mancavano alla fine della guerra.Il 7 febbraio del 1945, Guido, il fratello diciannovenne di Pier Paolo fu ucciso, insieme ad altri 16 partigiani della Brigata Osoppo, a Porzus, in Friuli, da una milizia di partigiani comunisti in quello che fu ricordato come l’Eccidio di Porzûs. Questa notizia fu data a Pasolini il 2 maggio 1945 dal suo amico partigiano Cesare Bortotto gettando Pier Paolo e la madre in un terribile strazio. Proseguirono comunque le lezioni nella piccola scuola di Versuta, dove Pier Paolo era considerato un vero maestro. Il 18 febbraio dello stesso anno venne fondata l’"Academiuta di lenga furlana" che raccoglieva un piccolo gruppo di neòteroi e che, sulle basi delle esperienze precedenti di Pier Paolo, fondò i principi del felibrismo regionale: In agosto fu pubblicato il primo numero de Il Stroligut, con una numerazione nuova per distinguersi dal precedente Stroligut di cà da l’aga e, nello stesso periodo, cominciò la serie dei “diarii” in versi italiani pubblicati nel 1946 in un primo volumetto a spese dell’autore sulle “Edizioni dell’Academiuta”, e sulla rivista fiorentina Il Mondo, pubblicò due poesie tratte dalla raccolta e scelte dallo stesso Montale. Nello stesso anno aderì a Patrie tal Friul (l’associazione per l’autonomia del Friuli creata da Tiziano Tessitori, con sede a Udine) e dopo il ritorno del padre nell’autunno del 1945, prigioniero degli inglesi in Africa poi rimpatriato, in anticipo per il lutto ricevuto, dal Kenya. Il dopoguerra in Friuli e il primo processo Nel 1946 Pasolini lavorò a un romanzo autobiografico rimasto incompiuto intitolato dapprima Quaderni rossi perché scritti a mano su cinque quaderni scolastici dalla copertina rossa, poi Pagine involontarie e infine “Il romanzo di Narciso”. In queste pagine l’autore descrive per la prima volta le sue esperienze omosessuali. Scrive di queste pagine Nico Naldini: "Prima di allora Pier Paolo non aveva mai descritto, se non per simboli ed ellissi, il suo eros e il suo dolore. Lo ha fatto con una sincerità che direi “musicale” dove anche l’ombra di una falsità avrebbe stonato." Isolato a Versuta (la casa di Casarsa era stata danneggiata dai bombardamenti) Pasolini cercò di ristabilire i rapporti con il mondo letterario e scrisse a Gianfranco Contini per presentargli il progetto di trasformare lo Stroligùt da semplice foglio a rivista. In seguito alla visita fatta da Silvana Mauri, sorella di un suo amico e innamorata di Pasolini, a Versuta, si recò in agosto a Macugnaga dove risiedeva la famiglia Mauri, e approfittando dell’occasione si recò a Domodossola per incontrare Contini. Usciva nel frattempo a Lugano il bando del premio “Libera Stampa” e Contini, che era membro della giuria, sollecitò il giovane amico a inviare il dattiloscritto che gli aveva mostrato, L’usignolo della Chiesa Cattolica, con la seconda parte de Il pianto della rosa. L’operetta riceverà solamente una segnalazione ma intanto Pasolini uscì dal suo isolamento e, grazie anche al clima più sereno del dopoguerra, ricominciò a frequentare la compagnia dei ragazzi più grandi di Versuta. Il 29 marzo 1947 vince a Venezia il premio Angelo (presieduto da Giuseppe Marchiori) per poesie in friulano e veneto. In ottobre Pasolini si recò a Roma dove fece la conoscenza di alcuni letterati che lo invitarono a collaborare alla “Fiera Letteraria”. Completò inoltre il dramma in italiano in tre atti intitolato Il Cappellano e pubblicò, nelle Edizioni dell’Academiuta, la raccolta poetica, sempre in italiano, I Pianti. Nel corso del 1947 si iscrisse al PCI di San Giovanni di Casarsa, di cui divenne segretario nel 1949. Il 26 gennaio del 1947 Pasolini scrisse sul quotidiano "Libertà" di Udine: «Noi, da parte nostra, siamo convinti che solo il comunismo attualmente sia in grado di fornire una nuova cultura “vera”, (...) una cultura che sia moralità, interpretazione intera dell’esistenza». Dopo la guerra Pasolini, che era stato a lungo indeciso sul campo in cui scendere, osservò le nuove esigenze di giustizia che erano nate nel rapporto tra il padrone e le varie categorie di diseredati e non ebbe dubbi sulla parte da cui voleva schierarsi. Cercò così di consolidare una prima infarinatura dottrinaria con la lettura di Karl Marx e soprattutto con i primi libri di Antonio Gramsci. Scriverà all’amica poetessa Giovanna Bemporad: Ed è pensando all’altro che nacque la decisione importante di aderire al comunismo. Progettò intanto di allargare la collaborazione della rivista dell’Academiuta alle altre letterature neolatine e fu messo in contatto, da Contini, con il poeta catalano in esilio Carles Cardó. Sempre a Contini inviò la raccolta completa delle sue poesie in friulano che per ora si intitolava Cjants di un muàrt, titolo che verrà cambiato in seguito in La meglio gioventù. Non riuscì però a ottenere l’aiuto di nessun editore per pubblicare i versi. Alla fine dell’anno ottenne l’incarico, per due anni 1947-1948 e 1948-1949, di insegnare materie letterarie alla prima media della scuola di Valvasone, che raggiungeva ogni mattina in bicicletta. Continuò con grande convinzione la sua adesione al PCI e in gennaio partecipò alla manifestazione, che si tenne nel centro di San Vito, il 7 gennaio 1948, organizzata dalla Camera del lavoro per ottenere l’applicazione del Lodo De Gasperi e fu in questa occasione che, osservando le varie fasi degli scontri con la polizia e parlando con i giovani contadini, si delineò il progetto di scrivere un romanzo su quel mondo in fermento, pubblicato solo nel 1962 con il titolo Il sogno di una cosa. Il primo titolo del romanzo è La meglio gioventù. Sempre impegnato nel PCI partecipò nel febbraio del 1949 al primo congresso della Federazione comunista di Pordenone e in maggio si recò a Parigi per il Congresso mondiale della pace. Il 29 agosto del 1949 alla sagra di Santa Sabina a Ramuscello Pasolini pagò tre minori per dei rapporti di masturbazione. La voce arrivò ai carabinieri della Stazione di Cordovado, competente per il territorio. La famiglia di Pasolini intervenne e l’avvocato Bruno Brusin convinse le famiglie dei ragazzi a non sporgere denuncia, offrendo 100 000 lire a testa alle famiglie per il danno subito. L’indagine proseguì, con l’imputazione di atti osceni in luogo pubblico e di corruzione di minore (uno dei ragazzi era sotto i sedici anni). Il 28 dicembre venne stralciata l’accusa di corruzione di minori per mancanza di denuncia e il dibattimento si concentrò sul fatto che gli eventi non si svolsero in un luogo pubblico ma in un campo nascosto da siepe e da un boschetto d’acacie. La sentenza arrivò nel gennaio del 1950: Pier Paolo Pasolini, e i due ragazzi sopra i sedici anni vennero giudicati colpevoli di atti osceni in luogo pubblico e condannati a tre mesi di reclusione ciascuno e al pagamento delle spese processuali; la pena venne interamente condonata per effetto dell’indulto.. mentre i dirigenti del PCI di Udine, il 26 ottobre, decisero di espellerlo dal partito «per indegnità morale e politica». Fu anche sospeso dall’insegnamento, come previsto in simili casi. A questo punto aveva ormai maturato la consapevolezza di essere una sorta di “poeta maledetto". Gli anni cinquanta a Roma Pasolini nel gennaio del 1950 si rifugiò con la sola madre, che dovette prendere servizio come cameriera, a Roma. I primi tempi a Roma furono difficili, a piazza Costaguti dove viveva in una stanza in affitto, per il giovane che sentiva il dovere di trovare un lavoro. Grazie all’intervento del poeta dialettale abruzzese Vittorio Clemente, Pasolini ottenne un lavoro come insegnante in una scuola privata a Ciampino. Sempre per cercare di sbarcare il lunario, si iscrisse al sindacato comparse di Cinecittà, e si offrì come correttore di bozze presso un giornale; riuscì a pubblicare qualche articolo su alcuni quotidiani cattolici e continuò a scrivere i romanzi che aveva cominciato in Friuli: Atti impuri, Amado mio, La meglio gioventù. Comincia a scrivere Ragazzi di vita e alcune pagine romane, come Squarci di notti romane, Gas e Giubileo, che saranno in seguito riprese in Alì dagli occhi azzurri. Dopo l’amicizia con Sandro Penna, che diventò l’amico inseparabile delle passeggiate notturne sul lungotevere, conobbe nel '51 un giovane imbianchino, Sergio Citti, che lo aiuterà ad apprendere il gergo e il dialetto romanesco costituendo, come scriverà lo stesso Pasolini, il suo “dizionario vivente”. Compose in questo periodo le poesie che verranno raccolte in Roma 1950 – Diario pubblicate nel 1960 da Scheiwiller e finalmente riuscì a ottenere un posto di insegnante presso una scuola media di Ciampino, dove insegnò dal 1951 al 1953, cosa che gli permise di far smettere la madre di lavorare e di affittare una casa in via Tagliere – nella borgata Rebibbia – dove li raggiunse il padre. Durante l’estate pubblicò sulla rivista Paragone il racconto Il Ferrobedò, che diventerà in seguito un capitolo di Ragazzi di vita, scrisse il poemetto L’Appennino che farà da apertura a Le ceneri di Gramsci e altri racconti romani. Partecipò al premio di poesia dialettale Cattolica (nella giuria anche Eduardo De Filippo) vincendo il secondo premio (50.000 lire) con Il testamento di Coran (ora compreso ne La meglio Gioventù). Riuscirà a vincere un premio anche i due anni successivi, (premio Sette Stelle di Sinalunga e Le Quattro arti di Napoli).In questo periodo strinse amicizia con Giorgio Caproni, Carlo Emilio Gadda e Attilio Bertolucci grazie al quale firmerà il primo contratto editoriale per una Antologia della poesia dialettale del Novecento che uscirà nel dicembre del '52 con una recensione di Eugenio Montale. Nel 1953 prese a lavorare a un’antologia della poesia popolare, per la collana dell’editore Guanda diretta dall’amico Bertolucci, che uscirà con il titolo Canzoniere italiano nel 1955 e nel frattempo pubblicò il primo volumetto di versi friulani Tal còur di un frut. Nell’ottobre dello stesso anno uscì su “Paragone” un’altra anticipazione del futuro Ragazzi di vita e Bertolucci lo presentò a Livio Garzanti perché si impegnasse a pubblicare il romanzo. Nel 1954, in situazione di ristrettezze economiche, riesce a far pubblicare La meglio gioventù, presso l’editore Sansoni, una raccolta di poesie in friulano con una dedica a Gianfranco Contini, con cui Pasolini vinse il Premio Giosuè Carducci ex aequo con Paolo Volponi, premio storico, ancora oggi vigente, della città di Pietrasanta.Come scrive in una lettera indirizzata a Vittorio Sereni, datata 7 agosto 1954, Pasolini si trova ad accettare il Premio soprattutto "per l’urgente, odioso bisogno delle 150mila". Risale al marzo del 1954 il suo primo lavoro cinematografico che consisteva nella collaborazione con l’amico Giorgio Bassani alla sceneggiatura del film di Mario Soldati La donna del fiume. Il lavoro con il cinema gli permette di lasciare l’insegnamento e trasferirsi nell’aprile del 1954 in un appartamento in via Fonteiana. Intanto Vittorio Sereni gli propone di pubblicare una raccolta di poesie nella collana per La Meridiana che curava insieme a Sergio Solmi che uscirà nel gennaio del 1954 con il titolo Il canto popolare e che confluirà in seguito nell’opera “Le ceneri di Gramsci”. Il romanzo Ragazzi di vita Tra il 1955 e il 1960 Pasolini, iniziando con il successo di Ragazzi di vita, assunse un ruolo centrale nel panorama della cultura italiana. Il 13 aprile del 1955 Pasolini spedì all’editore Garzanti il dattiloscritto completo di Ragazzi di vita che viene dato alle bozze. Il romanzo uscirà quello stesso anno ma il tema scabroso che trattava, quello della prostituzione omosessuale maschile, causa all’autore accuse di oscenità. Nonostante l’intervento feroce della critica (tra questi Emilio Cecchi, Asor Rosa e Carlo Salinari) e l’esclusione dal premio Strega e dal premio Viareggio, il libro ottenne un grande successo da parte del pubblico, venne festeggiato a Parma da una giuria presieduta da Giuseppe De Robertis e vinse il “Premio letterario Mario Colombi Guidotti”. Nel frattempo la magistratura di Milano aveva accolto la segnalazione della presidenza del consiglio dei ministri, rappresentata da Antonio Segni, di “carattere pornografico” del libro.Il vecchio amico cosentino Francesco Leonetti gli aveva scritto dicendo che era giunto il momento di fare una nuova rivista, annunciando in questo modo quella che diventerà Officina (maggio 1955-giugno 1959), rivista che ritrova i suoi precedenti nella rivista giovanile Eredi. Il progetto della rivista, lanciato appunto da Leonetti e da Roberto Roversi (con il coinvolgimento dell’amico bolognese Gianni Scalia), procedette in quello stesso anno con numerosi incontri per la stesura del programma al quale Pasolini aderì attivamente.Sempre nel 1955 uscì l’antologia della poesia popolare, Canzoniere italiano con una dedica al fratello Guido e in luglio Pasolini si recherà a Ortisei con Giorgio Bassani per lavorare alla sceneggiatura del film di Luis Trenker Il prigioniero della montagna. Questo è il periodo in cui cinema e letteratura cominciano a procedere su due binari paralleli come scrive Pasolini stesso a Contini: Continuava nel frattempo la polemica della critica marxista a Ragazzi di vita e Pasolini pubblicò sul numero di aprile della nuova rivista Officina un articolo contro Carlo Salinari e Antonello Trombadori che scrivevano sul Contemporaneo. A luglio si tenne a Milano il processo contro Ragazzi di vita che terminerà con una sentenza di assoluzione con “formula piena”, grazie anche alle testimonianze di Pietro Bianchi e Carlo Bo, che aveva dichiarato il libro essere ricco di valori religiosi "perché spinge alla pietà verso i poveri e i diseredati" e non contenente oscenità perché "i dialoghi sono dialoghi di ragazzi e l’autore ha sentito la necessità di rappresentarli così come in realtà", e di Giuseppe Ungaretti, che inviò una lettera firmata ai magistrati che si occupavano del caso Ragazzi di vita dicendo loro che si trattava di un abbaglio clamoroso perché il romanzo di Pasolini era semplicemente la cosa più bella che si poteva leggere in quegli anni. Pasolini si dichiarava razionalmente ateo e anticlericale ma «...io so che in me ci sono duemila anni di cristianesimo: io con i miei avi ho costruito le chiese romaniche, e poi le chiese gotiche, e poi le chiese barocche: esse sono nel mio patrimonio, nel contenuto e nello stile.». Cineasta e letterato Nel mese di agosto scrisse la sceneggiatura per il film di Mauro Bolognini, Marisa la civetta, e contemporaneamente collaborò con Fellini alle Notti di Cabiria. Alternando il suo impegno di cineasta con quella di letterato, scrisse, in questo periodo, articoli di critica sul settimanale “Il Punto” (la prima recensione sarà per “La Bufera” di Montale) e assistette i nuovi giovani scrittori di “Officina”, come Arbasino, Sanguineti e Alfredo Giuliani, che emergeranno in seguito nel Gruppo '63. Fece nuove amicizie tra le quali si annovera quella con Laura Betti, Adriana Asti, Enzo Siciliano, Ottiero Ottieri. Ispirato dalla crisi ideologica e politica in atto (il rapporto Kruscev al “XX Congresso” del Partito comunista sovietico aveva segnato il rovesciamento dell’epoca staliniana mettendo in evidenza il contrasto con quanto era successo in Polonia e in Ungheria), il 1956 sarà l’anno della stesura definitiva delle “Ceneri di Gramsci” e della prima bozza del romanzo Una vita violenta.Il dattiloscritto de Le ceneri di Gramsci, composto da undici poemetti scritti tra il 1951 e il 1956, venne spedito da Pasolini a Garzanti nell’agosto del 1957. L’opera, come già era successo per Ragazzi di vita, accese un contrastato dibattito critico ma ebbe un forte impatto sul pubblico che in quindici giorni esaurì la prima edizione. Al premio Viareggio, che si tenne nell’agosto di quell’anno, il libro venne premiato insieme al volume Poesie di Sandro Penna, e Quasi una vicenda, di Alberto Mondadori. Italo Calvino aveva già espresso, con dure parole, il suo giudizio nei confronti del disinteresse di alcuni critici marxisti sostenendo che per la prima volta “in un vasto componimento poetico viene espresso con una straordinaria riuscita nell’invenzione e nell’impiego dei mezzi formali, un conflitto di idee, una problematica culturale e morale di fronte a una concezione del mondo socialista”.Nel settembre 1958, in veste di inviato speciale, si recò a Mosca al Festival della gioventù mentre presso l’editore Longanesi uscirono i versi de L’usignolo della Chiesa cattolica. Lavorò anche alacremente a “Una vita violenta”, scrisse la sua prima autonoma sceneggiatura, “La notte brava”, e collaborò con Bolognini a “Giovani mariti”. Il 19 dicembre 1958 muore suo padre, Carlo Alberto: l’evento coincide con una crisi del rapporto di Pasolini con la comunità degli intellettuali, sancito dalla traumatica fine della rivista Officina e un conseguente impegno di Pasolini nel cinema con una riduzione della sua produzione letteraria. Il romanzo Una vita violenta Nel dicembre del 1958 terminò Una vita violenta che consegnerà all’editore Garzanti nel marzo del 1959 e, alla fine di un lungo lavoro di “autocensura” reso necessario soprattutto per un episodio considerato dall’editore pericoloso dal punto di vista politico, il libro uscirà a maggio dello stesso anno ma, come già successo per Ragazzi di vita, non otterrà né il premio Viareggio né quello Strega. Apprezzato e stimato comunque da un consistente gruppo di letterati otterrà il “premio Crotone” da una giuria composta da Ungaretti, Debenedetti, Moravia, Gadda e Bassani. Il lavoro di sceneggiatore gli permette di cambiare appartamento, nel giugno 1959, da via Fonteiana a via Giacinto Carini, dove abitava anche Bernardo Bertolucci.Durante l’estate Pasolini fece un viaggio giornalistico lungo le coste italiane come inviato del mensile Successo e scrisse tre puntate dal titolo La lunga strada di sabbia. Il sindaco democristiano di Cutro querelò Pasolini per diffamazione a mezzo stampa a causa della descrizione del suo paese nel servizio, cinque giorni dopo la consegna del Premio Crotone, città governata allora dal partito comunista, la querela venne archiviata. Tradusse l’Orestiade di Eschilo per la compagnia teatrale di Vittorio Gassman e riordinò i versi che compongono La religione del mio tempo. L’Azione cattolica nel frattempo aveva provveduto a sporgere denuncia "per oscenità" alla magistratura per “Una vita violenta”, denuncia che verrà però subito archiviata. Nell’anno 1960 Pasolini cominciò a collaborare a “Vie nuove”, a scrivere le bozze del libro di saggi Passione e ideologia, e raccolse i versi de La religione del mio tempo. Gli anni sessanta Nel 1960 uscirono due volumi di vecchi versi, Roma 1950 – Diario e Sonetto primaverile. Prima del Capodanno del 1961 partì per l’India con Alberto Moravia e Elsa Morante e il viaggio gli fornirà il materiale per scrivere una serie di articoli per Il Giorno che andranno a formare il volume L’odore dell’India. A maggio venne pubblicata la raccolta La religione del mio tempo molto apprezzata dall’amico Franco Fortini che gli scriverà: “Vorrei che fossi qui per abbracciarti”. Dal 4 giugno 1960 fino al 30 settembre 1965 tenne, su invito di Antonello Trombadori, una rubrica Dialogo con i lettori sul popolare settimanale comunista “Vie Nuove”.In quello stesso anno si dedicò al suo amore per il cinema scrivendo le sceneggiature de La giornata balorda di Bolognini, Il carro armato dell’8 settembre per Gianni Puccini, La lunga notte del '43 per Florestano Vancini tratto dal racconto di Bassani e Il bell’Antonio tratto dal romanzo di Vitaliano Brancati. Si era intanto prospettato alla sua mente il progetto di scrivere un film in proprio con un soggetto dal titolo La commare secca, ma i fatti di luglio, con i drammatici giorni del governo Tambroni, gli faranno mettere da parte il progetto per scrivere il soggetto di Accattone. Pasolini provò a proporre il soggetto alla casa di produzione dell’amico Fellini, la Federiz. Fellini gli chiese di girare due intere scene di prova, ma il girato non piacque alla produzione che lo rifiutò. L’amico Bolognini gli trovò un produttore, Alfredo Bini (a cui si associò Cino del Duca), al quale Pier Paolo spiegò come voleva fosse girato il film: molti primi piani, prevalenza dei personaggi sul paesaggio e soprattutto grande semplicità. Protagonista sarà Franco Citti, il fratello di Sergio e aiuto regista Bernardo Bertolucci al suo primo film. le riprese del film 'Accattone furono ultimate nel luglio del 1961, il film non ottenne il visto della censura per la proiezione nelle sale italiane, ma verrà lo stesso presentato, il 31 agosto 1961 al Festival di Venezia, fuori concorso. Non particolarmente apprezzato dalla critica italiana, a Parigi, dove venne presto proiettato, ricevette invece il giudizio entusiastico di Marcel Carné e di André Chamson. Dopo la tempestosa accoglienza alla Mostra di Venezia Accattone divenne il primo film italiano a ottenere il divieto ai minori di anni 18. La prima del film a Roma, al cinema Barberini, il 23 novembre 1961, vide l’irruzione di un gruppo di neofascisti che interruppero la proiezione, aggredendo gli spettatori e vandalizzando la sala. Nell’autunno del 1961 si recò al Circeo nella villa di un’amica per scrivere insieme a Sergio Citti la sceneggiatura del film Mamma Roma la cui lavorazione verrà programmata per la primavera del 1962, annoverando fra gli interpreti Anna Magnani. Denunce e processi Nel corso della sua vita Pasolini ricevette 24 denunce e/o querele. Il 30 del giugno 1960 Pasolini venne convocato in commissariato per ricevere una denuncia della polizia per favoreggiamento personale perché aveva dato un passaggio a due ragazzi di Trastevere che erano stati coinvolti in una rissa. Ne risulterà innocente.Il 22 novembre 1961 la polizia perquisì, senza risultato, il suo appartamento in cerca di una pistola con cui Pasolini avrebbe rapinato, il 18 sera, un distributore di benzina di San Felice Circeo. Il 30 novembre Il Tempo uscì a tutta pagina con un articolo Denunciato per tentata rapina Pier Paolo Pasolini con una foto di scena che lo ritraeva con un mitra in mano. Il processo che ne seguì si svolse il 3 luglio a Latina e condannò Pasolini per minaccia con arma. Il romanzo Il sogno di una cosa Terminò nel frattempo il romanzo del periodo friulano, Il sogno di una cosa, che verrà pubblicato in maggio e tra aprile e giugno lavorò alle riprese di Mamma Roma che verrà presentato alla Mostra del cinema di Venezia il 31 agosto 1962 ottenendo un grande successo e una denuncia per oscenità poi archiviata. Alla prima di Mamma Roma, il 22 settembre 1962, al cinema Le quattro fontane di Roma, viene aggredito da un gruppo di neofascisti e interviene la polizia. Durante il settembre di quello stesso anno Pasolini partecipò a un convegno che si tenne alla Cittadella di Assisi ed ebbe occasione di leggere il Vangelo di San Matteo. Da questa lettura nacque l’idea di produrre un film. Nel frattempo partecipò, con il produttore Bini, al film a episodi Ro.Go.Pa.G. insieme a Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard e Ugo Gregoretti e in quell’occasione pensò di ricavare un mediometraggio, girato nell’autunno del 1962, su una ricostruzione cinematografica della Passione di Cristo scritta durante la lavorazione di Mamma Roma dal titolo La ricotta che uscirà il primo marzo del 1963 accolto da un pubblico poco partecipe e che verrà sequestrato lo stesso giorno della sua uscita con l’accusa di “vilipendio alla religione di Stato”. Il processo, che verrà tenuto a Roma tra il 6 e il 7 marzo, condannò Pasolini a quattro mesi di reclusione per essere “colpevole del delitto ascrittogli” e il film venne sequestrato fino al dicembre dello stesso anno. Come scriverà Alberto Moravia su l’Espresso: Nel marzo del 1963 acquistò una casa in via Eufrate, all’EUR, dove si trasferì con la madre, in maggio. Quasi contemporaneamente a La Ricotta, Pasolini gira la prima parte del film, formato dal montaggio di pezzi di cinegiornali commentati da testi di Pasolini, La rabbia (1963), la seconda è per la regia di Giovannino Guareschi. Pasolini, visionato il film, ritirò la firma e cercò di impedirne la distribuzione ritenendosi vittima di una manovra del produttore Gastone Ferrante. il film, uscito in poche sale nell’aprile 1963, ebbe scarso successo e fu ritirato quasi subito.Continuò intanto a tenere i contatti con la Cittadella di Assisi e nel febbraio cominciò le ricerche filologiche e storiche per poter realizzare il progetto di girare un film che avesse come soggetto il Vangelo. Insieme al biblista Andrea Carraro e una troupe di tecnici compì viaggi in Israele e Giordania per trovare i luoghi e le persone adatte per la realizzazione del film. Il personaggio più difficile da trovare fu il Cristo che Pasolini volle dai lineamenti forti e decisi. Dopo averlo cercato nel poeta Evtusenko, trovò per caso, poco prima delle riprese, uno studente spagnolo, Enrique Irazoqui, dal volto fiero e distaccato simile ai Cristi dipinti dal Goya o da El Greco, e comprese di aver trovato la persona giusta.Contemporaneamente alla preparazione dei film, tra marzo e novembre 1963, Pasolini realizzò un film-inchiesta sulla sessualità degli italiani dal titolo Comizi d’amore. Cominciò a scrivere La Divina Mimesis tentativo incompiuto di rifacimento critico della Divina Commedia di Dante, il rifacimento in romanesco del Miles gloriosus di Plauto che intitolerà Il Vantone e su richiesta di Vittorini presentò alcune poesie sulla rivista Il Menabò e la Notizia su Amelia Rosselli. Nel maggio del 1964 pubblicò la quarta raccolta di versi italiani Poesia in forma di rosa e il 24 aprile cominciarono le riprese de Il Vangelo secondo Matteo che verranno concluse all’inizio dell’estate. L’opera è stata girata nei paesaggi rupestri di Matera e Massafra utilizzando moltissime comparse locali. Il film, presentato il 4 settembre 1964 a Venezia e poi diffuso in tutti i paesi europei, ottenne un grande successo di pubblico e partecipò alla prima edizione della Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. In quella occasione Pasolini conobbe Roland Barthes. Nel mese di ottobre del 1965 cominciarono le riprese del nuovo film Uccellacci e uccellini che trattava il tema della crisi politica del PCI e del marxismo in chiave “ideocomica”. Tra gli attori compariranno Totò e il giovane Ninetto Davoli. Totò era stato scelto perché il film, che si svolgeva tra il reale e il surreale, aveva bisogno di un attore che fosse un po’ clown. I titoli di testa e di coda del film sono cantati da Domenico Modugno.Nel novembre del 1965 uscì anche la raccolta narrativa con il titolo suggerito da Sartre Alì dagli occhi azzurri che conteneva nella parte centrale le sceneggiature de La notte brava, Accattone, Mamma Roma, La ricotta, mentre la prima e l’ultima parte era costituita da racconti che risalivano agli anni cinquanta e dagli abbozzi dei romanzi Il Rio della grana e La Mortaccia. In quell’anno fu invitato da Alberto Moravia e Alberto Carocci, che era stato direttore di Solaria, a dirigere con loro la nuova serie della rivista Nuovi Argomenti e, alla fine dell’anno, dopo aver progettato l’uscita di un nuovo film con Totò e la regia di un’opera lirica alla Piccola Scala, partirà per un viaggio in Nordafrica. Già sofferente di ulcera, nel marzo del 1966, Pasolini, venne colpito da una forte emorragia che lo costrinse a letto per quasi un mese. Sarà l’occasione di rileggere con calma i Dialoghi di Platone che lo stimoleranno a scrivere un teatro simile alla prosa, nella convalescenza scriverà l’impianto delle sei tragedie che compongono la sua opera teatrale: Calderón, Pilade, Affabulazione, Porcile, Orgia e Bestia di Stile. Terminata la convalescenza lavorò a Bestemmia, un romanzo sotto forma di sceneggiatura in versi, e abbozzò Orgia e Bestia da stile e tra maggio e giugno lavorò ad alcuni drammi che voleva rappresentare all’estero. Per l’estate del 1966 si comprò una Maserati 3500 GT di seconda mano, con cui trascorse le vacanze estive in Carnia con la madre Susanna.Intanto, al Festival di Cannes che si tenne il 3 maggio, il film Uccellacci e uccellini ebbe grande successo e l’intervento positivo di Roberto Rossellini durante la conferenza stampa suscitò grande interesse. Tra la primavera e l’estate del 1966 scrisse la bozza dei film Teorema e l’Edipo re oltre a elaborare altri drammi: Pilade, Porcile e Calderón. Nell’ottobre del 1966 si recò a New York per la presentazione di Uccellacci uccellini a un festival cinematografico. Conobbe in quell’occasione Allen Ginsberg. All’inizio di ottobre si recò in Marocco per studiare l’ambientazione dell’Edipo re e a novembre girò un episodio del film Le streghe, dal titolo La Terra vista dalla Luna con Silvana Mangano, Totò e Ninetto Davoli. Di ritorno da un secondo viaggio in Marocco realizzò, in una sola settimana, le riprese dell’episodio Che cosa sono le nuvole? del film Capriccio all’italiana, ancora con Totò, Ninetto Davoli, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Domenico Modugno. In aprile ebbero inizio le riprese dell’Edipo re nei deserti rossi del Marocco del sud che continueranno, per alcune scene, nella pianura di Lodi e per il finale nella città di Bologna. Il film, che verrà presentato alla Mostra di Venezia nel settembre 1967, non ebbe successo in Italia, mentre ottenne il favore del pubblico e della critica in Francia e in Giappone. Nello stesso anno scrisse saggi di teoria e tecnica cinematografica che verranno raccolti nel 1972 in Empirismo eretico. Il 26 ottobre dello stesso anno intervistò nella sua casa veneziana il poeta Ezra Pound, allora di 83 anni, per conto della Rai. I due discussero della Neoavanguardia italiana e dell’arte, quindi Pasolini lesse alcuni versi dalla traduzione italiana dei Canti pisani. Il Sessantotto Nel marzo del 1968 venne dato alle stampe il romanzo Teorema che sarà trasformato successivamente nel soggetto di un film, girato nella primavera dello stesso anno, che verrà presentato alla Mostra di Venezia il 4 settembre, alla critica, e che vincerà il secondo premio della carriera di Pasolini, il “Premio OCIC” (Office Catholique International du Cinèma, organizzazione cattolica che si occupa di cinema). Gli autori, tra cui Pasolini, Francesco Maselli e Cesare Zavattini, contestarono la Mostra del Cinema evidenziando come fosse una rassegna di produttori e non di autori e occuparono la Sala Volpi, solo l’intervento della polizia, il 26 agosto, permise la ripresa del festival. Jean Renoir, che assistette alla prima, dirà a un giornalista: A chaque image, à chaque plan, on sent le trouble d’un artiste (In ogni immagine, in ogni scena si sente il turbamento di un artista). Il 13 settembre la Procura di Roma ordinò il sequestro del film per oscenità. In seguito ai celebri scontri di Valle Giulia, scoppiati tra i reparti della polizia che avevano occupato preventivamente la facoltà romana di Architettura e giovani studenti, Pasolini scrisse la poesia Il P.C.I. ai giovani!! che, destinata alla rivista Nuovi Argomenti uscì senza preavviso su L’espresso scatenando una forte polemica. Nella poesia Pasolini si rivolge ai giovani dicendo che la loro è una falsa rivoluzione e che essi sono solamente dei borghesi conformisti, strumenti nelle mani della nuova borghesia. Autore di canzoni A partire dagli anni sessanta Pier Paolo Pasolini fu anche autore di canzoni, cercando un collegamento tra la poesia e la canzone d’autore. Le prime canzoni furono scritte su musiche di Piero Umiliani, Franco Nebbia e Piero Piccioni, e vennero incise da Laura Betti nel 1961, si tratta di Macrì Teresa detta Pazzia, Il valzer della toppa, Cocco di mamma e Cristo al Mandrione. Il valzer della toppa venne in seguito reincisa da Gabriella Ferri, che la inserì nel 1973 nel suo album Sempre, mentre Cristo al Mandrione fu reinterpretata da Grazia De Marchi e, nel 1997, dalla Ferri nel suo album Ritorno al futuro. Nel 1963 collaborò con Sergio Endrigo, per cui preparò un testo utilizzando alcuni versi tratti dalla raccolta La meglio gioventù; la canzone che nasce è Il soldato di Napoleone, contenuta nel primo 33 giri del cantautore istriano. Nel 1967 collaborò con Domenico Modugno, scrivendo il testo di Che cosa sono le nuvole: La canzone è poi stata reinterpretata nel 1996 da gianCarlo Onorato nell’album Il Velluto Interiore, nel 1997 dagli Avion Travel nell’album Vivo di canzoni, nel 2006 da Stefano Bollani nell’album I visionari e nel 2007 da Paolo Benvegnù. Modugno aveva già lavorato con Pasolini l’anno precedente, cantando i titoli di testa e coda del film Uccellacci e uccellini, che il regista aveva scritto in forma letteraria su musica di Ennio Morricone. Nel 1968 collaborò con il gruppo di rock psichedelico Chetro & Co., per cui scrisse il testo della canzone Danze della sera (suite in modo psichedelico), adattandolo da una sua poesia intitolata Notturno. Fine anni sessanta, tra teatro e cinema Nell’estate 1968 Pasolini girò La sequenza del fiore di carta con Ninetto Davoli tratto dalla parabola evangelica del fico infruttuoso che uscirà nel 1969, come terzo episodio del film “Amore e rabbia”. Pubblicò intanto su Nuovi Argomenti un saggio dal titolo Manifesto per un nuovo teatro in cui dichiarava il suo completo rifiuto del teatro italiano. Il 27 novembre 1968 rappresentò, al Deposito del Teatro Stabile di Torino, Orgia che venne accolta malamente dal pubblico e dai critici e, nel novembre del 1968, ebbero inizio le riprese di Porcile. Porcile ha come sfondo, per il suo episodio “metastorico”, l’Etna ed era stato pensato da Pasolini già nel 1965 quando aveva visto il film di Buñuel, Intolleranza: Simon del deserto. In seguito, per girare l’episodio moderno, la troupe si sposterà per le riprese a Villa Pisani a Stra. Dopo Porcile, che l’autore ritenne "il più riuscito dei miei film, almeno esteriormente", realizzò Medea e chiamò per interpretarlo Maria Callas. Le riprese del film vennero girate in Cappadocia, a Grado, a Pisa. La Callas e Pasolini strinsero un fortissimo legame di amicizia. Durante la lavorazione del film compì un viaggio in Uganda, Tanzania e Tanganica per cercare i luoghi dell’ambientazione del film che pensava di girare subito dopo Porcile: Appunti per un’Orestiade africana. Gli anni settanta In questi anni l’opera di Pasolini si allontanò ulteriormente dalle forme della cultura tradizionale per aumentare le occasioni di espressione su vari giornali e riviste. Nell’autunno del 1970, acquistò la Torre di Chia, nei pressi di Soriano nel Cimino, dove fece costruire un appartamento-rifugio per due. Il sito era stato scoperto da Pasolini nella primavera del 1964, dopo aver visionato molti luoghi, per ricostruire la scena del Battesimo di Gesù nel fiume Giordano nel film Il Vangelo secondo Matteo. Scrisse una recensione molto critica su Nuovi Argomenti a “Satura” di Montale, che gli rispose in versi nella Lettera a Malvolio e in aprile uscì la sua ultima raccolta di poesie Trasumanar e organizzar accolta da lettori e critici distratti. All’inizio del 1971 realizzò un documentario, dal titolo 12 dicembre, con la collaborazione di alcuni militanti di “Lotta Continua” sul tema della strage alla Banca dell’Agricoltura di Milano e a marzo presta il suo nome come direttore responsabile dello stesso quotidiano. Ad aprile venne denunciato per “istigazione a delinquere e apologia del reato” per un supplemento sulle forze armate di Lotta Continua, Proletari in divisa. La Trilogia della vita Durante l’estate del 1970 scrisse la sceneggiatura di dieci novelle tratte, tra quelle tragico-comiche, dal Decameron che ambienterà nel mondo napoletano. Il Decameron voleva essere il primo del trittico che Pasolini “dedicava alla vita”. Seguiranno infatti I racconti di Canterbury e Il fiore delle Mille e una notte, i veri successi di pubblico di Pasolini. Nel settembre dello stesso anno cominciò a girare a Casertavecchia le prime riprese per proseguire, con Ser Ciappelletto, a Napoli e a Bressanone. Si accinse poi a scrivere la sceneggiatura dei Racconti di Canterbury tratti da Chaucer e il 28 giugno al Festival di Berlino, “Il Decameron” ottenne l’Orso d’Argento e più di 30 denunce in tutta italia. Nove settimane, dal settembre al novembre 1971, furono impegnate per le riprese nel Regno Unito di “Canterbury”. Nel 1972 cominciò durante l’estate, senza attendere che il film uscisse nelle sale, a lavorare alla terza parte della trilogia tratta dalle novelle delle Mille e una notte e fece diversi sopralluoghi in Egitto, in Giordania, in Guinea, in India e in Ghana.I Racconti di Canterbury vinse l’Orso d’oro al festival di Berlino, ma venne stroncato dalla critica internazionale e ripetutamente sequestrato in Italia. Nel 1973 cominciarono nel frattempo le riprese del Fiore delle mille e una notte a Isfahan, in Iran. Il lavoro procedette con precisione e velocità tanto che l’autore riuscì a girare nel frattempo un documentario, Le mura di Sana’a, che voleva essere un appello all’Unesco perché salvaguardasse l’antica città yemenita.Il fiore delle Mille e una notte uscì nelle sale all’inizio del 1974, vincendo il Grand Prix Spécial du Jury, al Festival di Cannes, e ottenne un gran successo, anche se il giudizio della critica non soddisfece l’autore. Le sceneggiature della Trilogia della vita vennero pubblicate nel 1975 con alcune pagine di introduzione titolate Abiura dalla Trilogia della vita dove prese le distanze dalle sue opere precedenti Il romanzo Petrolio e gli scritti tra il 1972 e il 1975 Nel 1972, accolto da indifferenza da parte della critica, pubblicò la raccolta di saggi Empirismo eretico e continuò a lavorare, rifugiandosi nella torre Chia, al romanzo Petrolio, pubblicato postumo nel 1992, del quale, in tre anni, aveva compilato più di 500 pagine dattiloscritte e che pensò dovesse impegnarlo: “forse per il resto della mia vita”. Nel 1973 interruppe i rapporti con l’editore Garzanti e accettò le offerte di Giulio Einaudi. Nel settembre dello stesso anno uscirono due testi per il teatro, Orgia e Affabulazione.Alla fine del 1973 lo scrittore aveva già in mente il progetto, di cui rimangono solo qualche decina di pagine, per un nuovo film dal titolo provvisorio Porno-Teo-Kolossal al quale avrebbe dovuto partecipare tra i protagonisti Eduardo De Filippo. Il progetto venne rinviato. Durante l’estate del 1974 scrisse una lunga appendice al dramma in versi Bestia da stile. Nel maggio 1975 vide le stampe La nuova gioventù, che era una riproduzione dell’opera La meglio gioventù, e durante l’estate Pasolini lavorò al montaggio di Salò, che fu presentato, dopo la sua morte, il 22 novembre del 1975 al festival di Parigi. A ottobre consegnò a Einaudi La Divina Mimesis. Si recò quindi a Stoccolma per un incontro all’Istituto italiano di cultura e al ritorno si fermò a Parigi per rivedere l’edizione francese di Salò: il 31 ottobre ritornò a Roma.Pasolini scrisse quindi quello che diverrà il suo ultimo documento pubblico. Si tratta del testo dell’intervento che avrebbe dovuto tenere in quei giorni al 15º Congresso del Partito Radicale: Gli Scritti corsari A novembre del 1972 cominciò a collaborare con il settimanale Tempo occupandosi di recensioni letterarie che usciranno nel volume postumo, Descrizioni di descrizioni. All’inizio del 1973 passò al Corriere della Sera, allora diretto da Piero Ottone e da Gaspare Barbiellini Amidei, e il 7 gennaio uscì il primo articolo, Contro i capelli lunghi, che avviò un’ininterrotta serie di interventi riguardo l’ambito politico, il costume, il comportamento pubblico e privato: questi articoli saranno raccolti nel volume Scritti corsari. In seguito al referendum sul divorzio, pubblicò il 10 giugno 1974, sul Corriere, l’articolo Gli italiani non sono più quelli che scatenò dure polemiche con Maurizio Ferrara e Italo Calvino.Pasolini dedicò all’operato politico dei Radicali una certa attenzione. Pur mantenendo inalterata la sua posizione contraria non tanto alla legalizzazione dell’aborto in sé, quanto al conformismo che, riguardo a questa tematica, si traduceva in quello che lui definisce “fanatico abortismo”, anche se "in una situazione pratica avrebbe scelto il male minore cioè l’aborto". Divorzio e aborto erano invece propugnati con forza proprio dal PR, tra il 1974 e il 1975 scrisse alcuni pezzi, sul Corriere della Sera e su altri quotidiani, dedicati alle battaglie radicali e agli scioperi della fame di Marco Pannella, tra cui il famoso articolo Il fascismo degli antifascisti (uscito sul Corriere del 16 luglio 1974). Il 14 novembre del 1974, pubblicò sul Corriere della Sera l’articolo Cos’è questo golpe? Io so, in cui accusava la Democrazia Cristiana e gli altri partiti suoi alleati nel governo di essere i veri mandanti delle stragi, a partire da piazza Fontana.Il 19 gennaio del 1975 uscì sul Corriere della Sera il suo articolo “Sono contro l’aborto”, che suscitò altre polemiche. Scrisse alcuni articoli sul settimanale Il Mondo che andranno a far parte del volume postumo Lettere luterane, tra cui l’ultimo suo scritto pubblicato in vita, il 30 ottobre 1975. Nel mese di maggio uscì il volume Scritti corsari che raccoglieva tutti gli articoli scritti per i quotidiani Corriere della Sera, Tempo illustrato, Il Mondo, Nuova generazione e Paese Sera, tra il 1973 e il 1975, e che comprendeva una sezione di documenti allegati, redatti da vari autori e alcuni scritti di critica che erano apparsi sul settimanale Tempo dal 10 giugno al 22 ottobre 1974. In una lettera del 3 ottobre 1975 indirizzata a Gianni Scalia, Pasolini comprendeva l’urgenza di mettere in termini di economia politica quello che Pasolini scriveva sul Corriere e chiedeva al suo amico di aiutarlo in questa fatica. Questo progetto era rimasto naturalmente solo sulla carta. Il film Salò o le 120 giornate di Sodoma Interessato al progetto del film tratto da Sade si mise a studiare intensamente il kantiano “male radicale” che riduce l’umanità nella schiavitù del consumismo e che corrompe, manipolandole, le anime insieme ai corpi (precedentemente definiti “una terra ancora non colonizzata dal potere”). Ai primi di febbraio del 1975 terminò la sceneggiatura del film che non sarà mai realizzato, Il padre selvaggio e a metà dello stesso mese cominciarono nel mantovano le riprese di Salò o le centoventi giornate di Sodoma, ultimo film scritto e diretto da Pasolini, che verrà presentato al pubblico quando l’autore sarà già morto da tre settimane. Il 12 settembre 2015, in occasione del 72º festival di Venezia, il film verrà premiato nella categoria classici come miglior film restaurato. La morte Nella notte tra il 1º e il 2 novembre 1975 Pasolini fu ucciso in maniera brutale: percosso e travolto dalla sua stessa auto sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia, località del Comune di Roma. Il cadavere massacrato venne ritrovato da una donna alle 6 e 30 circa; sarà l’amico Ninetto Davoli a riconoscerlo. Dell’omicidio fu incolpato Pino Pelosi di Guidonia, di diciassette anni, già noto alla polizia come ladro di auto e “ragazzo di vita”, fermato la notte stessa alla guida dell’auto del Pasolini. Pelosi affermò di essere stato avvicinato da Pasolini nelle vicinanze della Stazione Termini, presso il Bar Gambrinus di Piazza dei Cinquecento, e da questi invitato sulla sua vettura (un’Alfa Romeo 2000 GT Veloce) dietro la promessa di un compenso in denaro. Dopo una cena offerta dallo scrittore, nella trattoria Biondo Tevere nei pressi della Basilica di San Paolo, i due si diressero alla periferia di Ostia. La tragedia, secondo la sentenza, scaturì a seguito di una lite per pretese sessuali di Pasolini alle quali Pelosi era riluttante, degenerata in un alterco fuori dalla vettura. Il giovane venne minacciato con un bastone del quale poi si impadronì per percuotere Pasolini fino a farlo stramazzare al suolo, gravemente ferito ma ancora vivo. Quindi Pelosi salì a bordo dell’auto dello scrittore e travolse più volte con le ruote il corpo, sfondandogli la cassa toracica e provocandone la morte. Gli abiti di Pelosi non mostrarono tracce di sangue. Pelosi venne condannato in primo grado per omicidio volontario in concorso con ignoti e il 4 dicembre del 1976 con la sentenza della Corte d’Appello, pur confermando la condanna dell’unico imputato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado escludendo ogni riferimento al concorso di altre persone nell’omicidio. Controversie e altre ipotesi Due settimane dopo il delitto apparve un’inchiesta su L’Europeo con un articolo di Oriana Fallaci, che ipotizzava una premeditazione e il concorso di almeno altre due persone. Un giornalista di quel giornale ebbe alcuni colloqui con un ragazzo che, tra molte esitazioni e alcuni momenti di isteria, avrebbe dichiarato di aver fatto parte del gruppo che aveva massacrato il poeta; il giovane tuttavia, dopo un’iniziale collaborazione avrebbe rifiutato di proseguire oltre o fornire altre informazioni, dileguandosi dopo aver lasciato intendere di rischiare la vita confessando la propria partecipazione e concludendo che non sarebbe stata intenzione del gruppo uccidere il poeta, ma che si sarebbe trattato di una rapina degenerata, concludendo je volevamo solà er portafoglio ("volevamo rubargli il portafoglio). Diversi abitanti delle numerose abitazioni abusive esistenti in via dell’Idroscalo confidarono in seguito alla stampa di aver sentito urla concitate e rumori– indizio della presenza di ben più di due persone sul posto– e invocazioni disperate di aiuto da parte del Pasolini la notte del delitto, ma senza che alcuno fosse intervenuto in suo soccorso. Sembra che la zona non fosse ignota al Pasolini, che già varie volte vi si era recato con altri partner e addirittura, stando a quanto la Fallaci affermò, avrebbe talvolta affittato per qualche ora una delle abitazioni del posto per trascorrervi momenti di intimità. Nella sua biografia su Pasolini Enzo Siciliano sostiene che il racconto dell’imputato presentava delle falle perché il bastone di legno– in realtà, una tavoletta di legno utilizzata precariamente per indicare il numero civico e l’abitazione di una delle baracche– a lui sembrava marcita per l’umidità e troppo deteriorata per costituire l’arma contundente che aveva causato le gravissime ferite riscontrate sul cadavere del poeta e rimarcando l’impossibilità, per un giovane minuto come il Pelosi, di sopraffare un uomo agile e forte come Pasolini senza presentare né tracce della presunta lotta, né macchie di sangue sulla sua persona o sugli indumenti. Il film Pasolini, un delitto italiano, di Marco Tullio Giordana, uscito nel ventennale del delitto, è sceneggiato come un’inchiesta e arriva alla conclusione che Pelosi non fosse solo. Lo stesso Giordana però ha precisato, in un’intervista al Corriere della Sera, che non intendeva sostenere a tutti i costi la matrice politica nel delitto. Ha dichiarato inoltre di non escludere altre possibilità, per esempio quella di un incontro omosessuale di gruppo degenerato in violenza.Pelosi, dopo aver mantenuto invariata la sua assunzione di colpevolezza per trent’anni, fino al maggio 2005, a sorpresa, nel corso di un’intervista televisiva, ha affermato di non essere l’esecutore materiale del delitto di Pier Paolo Pasolini, e ha dichiarato che l’omicidio era stato commesso da altre tre persone, giunte su un’autovettura targata Catania, che a suo dire parlavano con accento “calabrese o siciliano” e, durante il massacro, avrebbero ripetutamente inveito contro il poeta gridandogli " jarrusu (termine gergale siciliano, utilizzato in senso dispregiativo nei confronti degli omosessuali). E infatti, era giunta a suo tempo alle autorità una lettera anonima in cui si affermava che, la sera della morte di Pasolini, la sua auto era stata seguita da una Fiat 1300 targata Catania di cui erano indicate le prime quattro cifre, ma nessuno si preoccupò mai di effettuare una verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Pelosi ha poi fatto i nomi dei suoi presunti complici solo in un’intervista del 12 settembre 2008 pubblicata sul saggio d’inchiesta di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza “Profondo Nero” (Chiarelettere 2009). Ha aggiunto inoltre di aver celato questa rivelazione per timore di mettere a rischio l’incolumità della propria famiglia ma di sentirsi adesso libero di parlare, dopo la morte dei genitori. A trent’anni dalla morte, assieme alla ritrattazione di Pelosi, è emersa la testimonianza di Sergio Citti, amico e collega di Pasolini, su una sparizione di copie dell’ultimo film Salò e su un eventuale incontro con dei malavitosi per trattare la restituzione. Sergio Citti morì per cause naturali alcune settimane dopo. Un’ipotesi molto più inquietante lo collega invece alla “lotta di potere” che prendeva forma in quegli anni nel settore petrolchimico, tra Eni e Montedison, tra Enrico Mattei e Eugenio Cefis. Pasolini, infatti, si interessò al ruolo svolto da Cefis nella storia e nella politica italiana: facendone uno dei due personaggi “chiave”, assieme a Mattei, di Petrolio, il romanzo-inchiesta (uscito postumo nel 1992) al quale stava lavorando poco prima della morte. Pasolini ipotizzò, basandosi su varie fonti, che Cefis alias Troya (l’alias romanzesco di Petrolio) avesse avuto un qualche ruolo nello stragismo italiano legato al petrolio e alle trame internazionali. Secondo autori recenti fu proprio per questa indagine che Pasolini fu ucciso.Altri collegano la morte di Pasolini alle sue accuse a importanti politici di governo di collusione con le stragi della strategia della tensione. Walter Veltroni il 22 marzo 2010 ha scritto al Ministro della Giustizia Angelino Alfano una lettera aperta, pubblicata sul Corriere della sera, chiedendogli la riapertura del caso sottolineando che Pasolini è morto negli anni settanta, “anni cui si facevano stragi e si ordivano trame”. Nel 2010, l’avvocato Stefano Maccioni e la criminologa Simona Ruffini hanno ricordato che i proprietari della trattoria Biondo Tevere, di cui Pasolini era cliente abituale, furono sentiti pochissime ore dopo l’identificazione del corpo ed entrambi descrissero il giovane con cui Pasolini s’era presentato la sera del delitto come alto almeno 1,70 e forse di più, con capelli lunghi e biondi, pettinati all’indietro, ovvero completamente diverso da Pelosi, che era poco più di 1.60 m., tarchiato e con folti capelli neri e ricci, secondo la moda dell’epoca. Hanno anche raccolto la dichiarazione di un nuovo testimone, cosa che ha aperto ulteriori indagini che però sono state definitivamente archiviate all’inizio del 2015. Le nuove indagini non hanno portato infatti a nulla di nuovo rispetto alla sentenza, se non ad alcune tracce di Dna sui vestiti dello scrittore. Tracce però di impossibile attribuzione e impossibili da collocare temporalmente, se durante il delitto o nei giorni precedenti. Sostenitori della sentenza Molti intellettuali sostengono la verità giudiziaria, o comunque non credono a complotti. Si tratta di scrittori e amici di Pasolini che ritengono inattendibile, per molti motivi, la ritrattazione di Pelosi a distanza di trent’anni. In linea generale, sono gli stessi che rifiutano la lettura politica militante delle opere di Pasolini e l’immagine edulcorata del personaggio che porta a farne “un santo e un martire”. Essi privilegiano, invece, una chiave interpretativa dell’uomo e dell’opera legata alla sua particolare omosessualità, vissuta senza fermarsi di fronte a pratiche estreme e violente, anche con i minori.Sono le basi da cui partono Edoardo Sanguineti (che definisce il suo comportamento “suicidio per delega"), Franco Fortini e il curatore dell’opera omnia Walter Siti per sostenere che in generale la sua scrittura presenta un forte contenuto autobiografico e che in particolare alcune opere sono una sorta di autobiografia originata da una tendenza sadomasochista votata all’autodistruzione.Sono le stesse basi che utilizzano Nico Naldini, cugino di primo grado di Pasolini, anch’egli omosessuale, poeta e scrittore, nonché suo collaboratore in tutti i film, e Marco Belpoliti per dire che con le teorie del complotto si manifesta la resistenza della sinistra e di alcuni amici ad accettare la particolare omosessualità dello scrittore riducendola a una sorta di vizietto, una pratica privata di cui non si deve parlare, mentre costituisce la sostanza su cui egli ha fondato la propria opera e la propria critica della società. Naldini, che definisce le teorie del complotto “bufale che si inseguono e che si divorano l’un l’altra”, e "delirio che continua da molti anni e non è ancora del tutto passato", nel suo libro “Breve vita di Pasolini”, scrive che l’attrazione per quel tipo di ragazzi gli faceva perdere il senso del pericolo. Un senso che avrebbe invece dovuto tenere ben presente, vista anche la sua costituzione fisica minuta (era alto 1,69 m e pesava 59 kg.) che lo portava a essere facile oggetto di lesioni, anche da parte di ragazzi. Per diversi motivi, tra cui il fatto che lo scrittore, da tempo, aveva adottato il sadomasochismo, anche con rituali feticistici (le corde per farsi legare e così immobilizzato in una sorta di scena sacrificale farsi percuotere fino allo svenimento), Naldini ritiene che abbiano ragione coloro che dicono che, suo cugino, in fondo, sia in parte autore del suo stesso destino. La sua morte è spiegata dal fatto che viveva una vita violenta: per questo egli pensa che sia allo stesso tempo tragico e ridicolo volerlo trasformare in una specie di santo laico. Anche per il critico Giancarlo Vigorelli, scopritore di Pier Paolo Pasolini sin da quand’era un poeta adolescente, si tratta di omicidio omosessuale. Egli considerava Pasolini un uomo pieno di contraddizioni non tanto perché cercasse il sesso occasionale, ma per la violenza, “per il modo bestiale in cui si consumava durante nottate di violenza che non comprendevo. Fino alle sette di sera era una persona, dopo era tutt’altra… a me gelava il sangue quando lo vedevo il giorno dopo le sue avventure notturne pieno di graffi e lividi”.Ferdinando Camon, la cui prefazione dei primi libri è stata scritta da Pasolini, afferma che lo scrittore è morto come ha rischiato tante volte di morire. Egli sostiene che le teorie del complotto rispondono al desiderio di alcuni amici di Pasolini di mondarlo dalla morte per omosessualità, vissuta anche comprando minorenni, per consegnarlo alla storia come morto per antifascismo. L’amico pittore Giuseppe Zigaina rievoca le circostanze della scomparsa di Pasolini in un suo saggio. Dal confronto con la simbologia presente in gran parte delle sue opere egli sostiene che Pasolini ha «progettato per quindici anni la sua morte». Sulle stesse posizioni, contro le teorie del complotto, si trovano anche Guido Santato, studioso di Pasolini, e l’italianista Bruno Pischedda il quale aggiunge che queste teorie sono anche un tentativo di preservarne la statura di vate, un modo per custodire un’immagine mitica, consacrata, ponendola fuori e al di sopra di qualsiasi giudizio. Anche se la tendenza a credere nelle teorie del complotto, secondo Pierluigi Battista, prescinde dalla storia personale dello scrittore, e deriva dal fatto che "i gialli sono sempre più avvincenti della piattezza delle trame realistiche".Un altro cronista che non ha mai creduto alla tesi del complotto neofascista è Massimo Fini: nel 2015, in occasione dei quarant’anni dell’omicidio, ricordò che quella teoria fu innescata da Oriana Fallaci (sua collega all’Europeo) dopo aver sfogliato alcune riviste dal parrucchiere e aver raccolto dei boatos in quel senso, e che successivamente fu ripresa dai grossi intellettuali (tra cui Umberto Eco e Alberto Moravia), poiché negli anni settanta «attribuire ogni nefandezza ai fascisti era uno sport nazionale, tanto più facile perché [...] i fascisti erano scomparsi, e tutti, dal sociologo paraculo del Corriere della Sera, al Corriere stesso, ai democristiani, a chi scriveva manuali di cucina, ma, beninteso, sempre in “ottica rivoluzionaria”, all’ultima cocotte erano diventati di sinistra» e poiché non volevano accettare che Pasolini fosse morto «cercando di infilare un bastone nel culo al diciassettenne Pino la rana». Fini aggiunse che Pasolini era solito recarsi in zone periferiche e malfamate, come il quartiere Pigneto, per incontrare i «ragazzi di vita» e comportarsi in maniera sadica con loro dal momento che quella era la sua zona d’ombra, e all’idroscalo Lido di Roma incontrò un ragazzo che si ribellò a una certa richiesta. A prescindere dai fatti e dalle responsabilità che hanno condotto alla sua morte, la fine di Pasolini sembra essere emblematica, al punto che la sua morte è stata paragonata a quella di Caravaggio: Archivi personali Presso la Cineteca di Bologna si trova l’archivio del Centro Studi Pier Paolo Pasolini donato nel 2004 da Laura Betti. Il Gabinetto Vieusseux di Firenze ha un suo consistente fondo comprendente circa 39 anni di epistolario, manoscritti e dattiloscritti delle sue opere, foto personali e foto di scena, rassegna stampa sulle sue attività, opuscoli, locandine ecc. Una raccolta di manoscritti del periodo friulano, tra cui Quaderni rossi (1946-1947) e i Manifesti politici (1949) e una fitta corrispondenza epistolare con gli amici e i parenti sono depositati al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia Opere * Per l’importanza della sua poesia il critico statunitense Harold Bloom ha inserito Pasolini tra gli scrittori che compongono il Canone Occidentale. Poesia * Poesie a Casarsa, Libreria Antiquaria Mario Landi, Bologna, 1942. * Poesie, Stamperia Primon, San Vito al Tagliamento, 1945. * Diarii, Pubblicazioni dell’Academiuta, Casarsa, 1945; ristampa anastatica 1979, con premessa di Nico Naldini. * I pianti, Pubblicazioni dell’Academiuta, Casarsa, 1946. * Dov’è la mia patria, con 13 disegni di G. Zigaina, Edizioni dell’Academiuta, Casarsa, 1949. * Tal còur di un frut, Edizioni di Lingua Friulana, Tricesimo, 1953; nuova edizione a cura di Luigi Ciceri, Forum Julii, Udine, 1974. * Dal diario (1945-47), Sciascia, Caltanissetta, 1954; nuova edizione, 1979, con introduzione di L. Sciascia, illustrazioni di Giuseppe Mazzullo. * La meglio gioventù, Biblioteca di Paragone, Sansoni, Firenze, 1954. * Il canto popolare, Edizioni della Meridiana, Milano, 1954. * Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano, 1957; nuova edizione Einaudi, Torino, 1981, con un saggio critico di Walter Siti). * L’usignolo della Chiesa Cattolica, Longanesi, Milano, 1958; nuova edizione, Einaudi, Torino, 1976. * Roma 1950. Diario, All’insegna del pesce d’oro (Scheiwiller), Milano, 1960. * Sonetto primaverile (1953), Scheiwiller, Milano, 1960. * La religione del mio tempo, Garzanti, Milano, 1961; nuova edizione Einaudi, Torino, 1982. * Poesia in forma di rosa (1961-1964), Garzanti, Milano, 1964. * Poesie dimenticate, a cura di Luigi Ciceri, Società filologica Friulana, Udine, 1965. * Poesie [riunisce una scelta d’autore di 24 poesie da Le ceneri di Gramsci, La religione del mio tempo e Poesia in forma di rosa]; Garzanti, Milano, 1970. * Trasumanar e organizzar, Garzanti, Milano, 1971. * La nuova gioventù. Poesie friulane 1941-1974, Einaudi, Torino, 1975; Collana Gli struzzi n.243, Einaudi, 1981; Collezione di poesia, Einaudi, 2002. * Le poesie [riunisce Le ceneri di Gramsci, La religione del mio tempo, Poesia in forma di rosa, Trasumanar e organizzar e alcune inedite], Garzanti, Milano, 1975. * Poesie e pagine ritrovate, a cura di Andrea Zanzotto e Nico Naldini, con disegni di Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Zigaina, Lato Side 25, Roma, 1980. Bestemmia. Tutte le poesie, 2 voll., a cura di Graziella Chiarcossi e Walter Siti, prefazione di Giovanni Giudici, Garzanti, Milano, 1993, ISBN 978-88-116-3584-0; nuova edizione nella Collana Gli elefanti Poesia, 4 voll., Garzanti, 1995-1996. Poesie scelte, a cura di Nico Naldini e Francesco Zambon, con un’introduzione di F. Zambon, Collana Poeti del nostro tempo, TEA, Milano 1997; Collana Poeti della Fenice, Guanda, Parma, 2015, ISBN 978-88-235-1253-5; Collana Tascabili poesia, Guanda, 2017, ISBN 978-88-235-1747-9. * Tutte le poesie, 2 voll. in cofanetto, a cura e con uno scritto di Walter Siti, saggio introduttivo di Fernando Bandini, Collana I Meridiani, Mondadori, Milano, 2003. Traduzioni poetiche Dal latino Dall’Eneide, in Umberto Todini, Virgilio e Plauto, Pasolini e Zanzotto. Inediti e manoscritti d’autore tra antico e moderno, in Lezioni su Pasolini, a cura di Tullio De Mauro e Francesco Ferri, Sestante, Ascoli Piceno 1997, p. 56. Dal francese * Roger Allard, Storia di Yvonne, in Poesia straniera del Novecento, a cura di A. Bertolucci, Garzanti, Milano 1958, pp. 82–87. * Jean Pellerin, La romanza del ritorno, in Poesia straniera del Novecento, a cura di A. Bertolucci, Garzanti, Milano 1958, pp. 88–93. * André Frénaud, Esortazione ai poveri, in «L’Europa letteraria», dicembre 1960. In friulano * Niccolò Tommaseo, A la so Pissula Patria, «Il Stroligut», n. 1, avost 1945, p. 19. * Giuseppe Ungaretti, Luna, «Il Stroligut», n. 2, avril 1946, p. 19. Dal greco al friulano * Tre frammenti di Saffo, in Massimo Fusillo, La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema, La Nuova Italia, Firenze 1996, pp. 243–244. Narrativa * Ragazzi di vita, Garzanti, Milano 1955 (nuova ed.: Einaudi, Torino 1979, con un’appendice contenente Il metodo di lavoro e I parlanti). * Una vita violenta, Garzanti, Milano 1959 (nuova edizione: Einaudi, Torino 1979). * Donne di Roma. Sette storie di P.P.Pasolini, Introduzione di Alberto Moravia, 104 fotografie di Sam Waagenaar, Collana Specchio del mondo n.8, Milano, Il Saggiatore, 1960. * L’odore dell’India, Longanesi, Milano 1962; Nuova ed., Guanda, Parma 1990, con un’intervista di Renzo Paris ad Alberto Moravia. * Il sogno di una cosa, Garzanti, Milano 1962. * Alì dagli occhi azzurri, Garzanti, Milano 1965. * Teorema, Garzanti, Milano 1968. * La Divina Mimesis, Einaudi, Torino 1975; Nuova ed. con una nota introduttiva di Walter Siti, Einaudi, 1993. * Amado mio preceduto da Atti impuri, con uno scritto di A. Bertolucci, edizione a cura di Concetta D’Angeli, Garzanti, Milano 1982. * Petrolio, a cura di Maria Careri e Graziella Chiarcossi, con una nota filologica di Aurelio Roncaglia, Einaudi, Torino 1992; a cura di Silvia De Laude, Collana Oscar, Mondadori, Milano, 2005. * Un paese di temporali e di primule, a cura di Nico Naldini, Guanda, Parma 1993 [oltre a racconti, contiene saggi di argomento friulano] * Romàns, seguito da Un articolo per il «Progresso» e Operetta marina, a cura di Nico Naldini, Guanda, Parma 1994. * Storie della città di Dio. Racconti e cronache romane (1950-1966), a cura di Walter Siti, Einaudi, Torino 1995. * Romanzi e racconti, 2 voll., a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con due saggi di W. Siti, Mondadori, Milano 1998. Sceneggiature e testi per il cinema * La notte brava, in Filmcritica, novembre-dicembre 1959. * Accattone, prefazione di Carlo Levi, FM, Roma 1961; poi in Accattone, Mamma Roma, Ostia, introduzione di Ugo Casiraghi, Garzanti, Milano 1993, pp. 23–236. * Mamma Roma, Rizzoli, Milano 1962; poi in Accattone, Mamma Roma, Ostia, cit., pp. 239–401. * Il Vangelo secondo Matteo, a cura di Giacomo Gambetti, Garzanti, Milano 1964; poi in Il Vangelo, Edipo, Medea, introduzione di Morando Morandini, Garzanti, Milano 1991, pp. 7–300. * La commare secca, in «Filmcritica», ottobre 1965. * Uccellacci e uccellini, Garzanti, Milano 1966. * Edipo re, Garzanti, Milano 1967, poi in Il Vangelo, Edipo, Medea, cit., pp. 313–454. * Che cosa sono le nuvole?, in Cinema e Film, 1969. * Porcile (soggetto del primo episodio, titolo originario Orgia), in «ABC», 10 gennaio 1969. * Appunti per un poema sul Terzo Mondo (soggetto), in Pier Paolo Pasolini. Corpi e luoghi, a cura di Michele Mancini e Giuseppe Perrella, Theorema, Roma 1981, pp. 35–44. * Ostia, un film di Sergio Citti, sceneggiatura di S. Citti e Pier Paolo Pasolini, Garzanti, Milano 1970; poi in Accattone, Mamma Roma, Ostia, cit., pp. 405–566. * Medea, Garzanti, Milano 1970; poi in Il Vangelo, Edipo, Medea, cit., pp. 475–605. * Storie scellerate, un film di Sergio Citti, soggetto e sceneggiatura di S. Citti e Pier Paolo Pasolini 1973. * Il padre selvaggio (racconto-sceneggiatura scritto nel 1963 per un film mai realizzato), Collana Nuovi Coralli n.114, Einaudi, Torino, I ed. 1975. Trilogia della vita (Il Decameron, I racconti di Canterbury, il Fiore delle Mille e una notte), a cura di Giorgio Gattei, Cappelli, Bologna 1975; nuove edizioni Oscar Mondadori, Milano 1987, e Garzanti, Milano 1995, con introduzione di Gianni Canova. * San Paolo, Collana Supercoralli. Nuova serie, Einaudi, Torino, 1977, ISBN 978-88-060-9878-0; Prefazione di Enzo Bianchi, Collana Elefanti bestseller, Garzanti, Milano, 2017, ISBN 978-88-116-7277-7. * Appunti per un’Orestiade africana, a cura di Antonio Costa, Quaderni del Centro Culturale di Copparo, Copparo (Ferrara) 1983. * Ignoti alla città (commento), in Pier Paolo Pasolini, Il cinema in forma di poesia, a cura di Luciano De Giusti, Cinemazero, Pordenone 1979, pp. 117–18. * La canta delle marane (commento), ibid., pp. 119–20. * Comizi d’amore (scaletta preparatoria), ibid., pp. 123–27. * Storia indiana (soggetto), ibid., pp. 134–35. * Le mura di Sana’a (commento), in «Epoca», 27 marzo 1988. * Porno-Teo-Kolossal, in «Cinecritica», aprile-giugno 1989. * Sant’Infame, ivi. * La Terra vista dalla Luna, sceneggiatura a fumetti, presentazione di Serafino Murri, in «MicroMega», ottobre-novembre 1995. La Nebbiosa, in «Filmcritica», 459/460, novembre-dicembre 1995; edizione integrale secondo le sequenza della prima stesura, a cura di Graziella Chiarcossi, prefazione di Alberto Piccinini, nota al testo di Maria D’Agostini, Biblioteca delle Silerchie, Il Saggiatore, Milano, 2013. * Per il cinema, 2 voll. in cofanetto, a cura di Walter Siti e Franco Zabagli, con due scritti di B. Bertolucci e Mario Martone, saggio introduttivo di Vincenzo Cerami, Collana I Meridiani, Mondadori, Milano, 2001. Teatro * Italie Magique, in Potentissima signora, canzoni e dialoghi scritti per Laura Betti, Longanesi, Milano 1965, pp. 187–203. * Pilade, in «Nuovi Argomenti», luglio-dicembre 1967. * Affabulazione, in «Nuovi Argomenti», luglio-settembre 1969. * Calderón, Garzanti, Milano 1973. * I Turcs tal Friùl (I Turchi in Friuli), a cura di Luigi Ciceri, Forum Julii, Udine 1976 (nuova edizione a cura di Andreina Nicoloso Ciceri, Società filologica friulana, Udine 1995). * Affabulazione-Pilade, presentazione di Attilio Bertolucci, Garzanti, Milano 1977. * Porcile, Orgia, Bestia da stile, con una nota di Aurelio Roncaglia, Garzanti, Milano 1979. * Teatro (Calderón, Affabulazione, Pilade, Porcile, Orgia, Bestia da stile), prefazione di Guido Davico Bonino, Garzanti, Milano 1988. * Affabulazione, con una nota di Guido Davico Bonino, Einaudi, Torino 1992. * La sua gloria (dramma in 3 atti e 4 quadri, 1938), in «Rendiconti», 40, marzo 1996, pp. 43–70. * Teatro, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con due interviste a L. Ronconi e S. Nordey, Mondadori, Milano 2001. * Bestia da stile, a cura di Pasquale Voza, Editrice Palomar, Bari 2005. Traduzioni teatrali Eschilo, Orestiade, a cura dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico per le rappresentazioni classiche nel teatro greco di Siracusa, Urbino 1960; poi Quaderni del Teatro popolare italiano n.2, Einaudi, Torino 1960; con una Lettera del traduttore, Collana Scrittori tradotti da scrittori, Einaudi, 1985. * Plauto, Il vantone, Garzanti, Milano 1963; Prefazione di Umberto Todini, Garzanti, 1994. Saggi * “Paolo Weiss” testo di Pasolini, con 34 tavole del pittore, Edizioni della Piccola Galleria Roma 1946 * Passione e ideologia (1948-1958), Garzanti, Milano 1960 (nuove edizioni Einaudi, Torino 1985, con un saggio introduttivo di C. Segre, e Garzanti, Milano 1994, con prefazione di A. Asor Rosa). * “I parlanti” (1948) estratto da “Botteghe Oscure”, Roma 1951, ripubblicato in appendice all’edizione Einaudi di “Ragazzi di vita”, 1979 * “Donne di Roma” con introduzione di Alberto Moravia, Milano, Il Saggiatore, 1960 * Empirismo eretico, Garzanti, Milano 1972. * Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975 (nuova edizione 1990, con prefazione di A. Berardinelli). * Volgar’eloquio, a cura di Antonio Piromalli e Domenico Scafoglio, Athena, Napoli, 1976 * Lettere luterane, Einaudi, Torino, 1976; con un’introduzione di Alfonso Berardinelli, 2003. Descrizioni di descrizioni, a cura di Graziella Chiarcossi, Collana Gli struzzi n.194, Einaudi, Torino, I ed. 1979; prefazione di Giampaolo Dossena, Garzanti, Milano, 1996; introduzione di Paolo Mauri, Collana Saggi, Garzanti, 2006. [raccoglie le recensioni letterarie apparse sul settimanale «Tempo» tra il 26 novembre 1972 e il 24 gennaio 1975] * Il Portico della Morte, a cura di Cesare Segre, «Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini», Garzanti Milano 1988. * Antologia della lirica pascoliana. Introduzione e commenti, a cura di Marco Antonio Bazzocchi, saggio introduttivo di M. A. Bazzocchi ed Ezio Raimondi, Einaudi, Torino 1993. * I film degli altri, a cura di Tullio Kezich, Guanda, Parma 1996. * Poesia dialettale del Novecento, a cura di Mario dell’Arco e Pier Paolo Pasolini, introduzione di Pasolini, Guanda, Parma 1952 (nuova edizione Einaudi, Torino 1995, con prefazione di Giovanni Tesio). * Canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare, a cura di Pier Paolo Pasolini, Guanda, Parma 1955 (nuova edizione Garzanti, Milano 1972 e 1992). Pier Paolo Pasolini e il setaccio 1942-1943, a cura di Mario Ricci, Cappelli, Bologna 1977, con scritti di Roberto Roversi e Gianni Scalia (contiene i seguenti saggi pasoliniani: «Umori» di Bartolini; Cultura italiana e cultura europea a Weimar; I giovani, l’attesa; Noterelle per una polemica; Mostre e città; Per una morale pura in Ungaretti; Ragionamento sul dolore civile; Fuoco lento.Collezioni letterarie; Filologia e morale; Personalità di Gentilini; «Dino» e «Biografia ad Ebe»; Ultimo discorso sugli intellettuali; Commento a un’antologia di «lirici nuovi»; Giustificazione per De Angelis; Commento allo scritto del Bresson; Una mostra a Udine). * Tutti gli articoli di Pasolini per «Il Setaccio» sono leggibili sul sito della Biblioteca comunale dell’Archiginasio * Nota sull’odierna poesia, «Gioventù italiana del Littorio. Bollettino del Comando federale di Bologna», aprile 1942, p. 6. Stroligut di cà da l’aga (1944)– Il Stroligut (1945-1946)– Quaderno romanzo (1947), riproduzione anastatica delle riviste dell’Academiuta friulana, a cura del Circolo filologico linguistico padovano, Padova, 1983 (contiene i seguenti saggi pasoliniani: Dialet, lenga e stil; Academiuta di Lenga Furlana; Alcune regole empiriche d’ortografia; Volontà poetica ed evoluzione della lingua). * Saggi sulla letteratura e sull’arte, 2 voll., in cofanetto, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con un saggio di Cesare Segre, Collana I Meridiani, Mondadori, Milano, 1999. * Saggi sulla politica e sulla società, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con un saggio di Piergiorgio Bellocchio, Collana I Meridiani, Mondadori, Milano 1999. * I giovani e l’attesa. Tre scritti giovanili (1942-43), Ogni uomo è tutti gli uomini, 2015, ISBN 978-88-96691-93-9. * Il mio cinema, Collana Il cinema ritrovato, Cineteca di Bologna, 2015, ISBN 978-88-99196-13-4. Dialoghi con i lettori Le belle bandiere. Dialoghi 1960-65, a cura di Gian Carlo Ferretti, Collana I David n.19, Roma, Editori Riuniti, 1977. [contiene una scelta dei dialoghi apparsi sul settimanale «Vie Nuove» tra il 4 giugno e il 30 settembre 1965] Il caos, a cura di Gian Carlo Ferretti, Collana I David, Roma, Editori Riuniti, dicembre 1979. [contiene una scelta dei dialoghi apparsi sul settimanale «Tempo», dal 6 agosto 1968 al 24 gennaio 1970]; Collana Saggi, Garzanti, Milano, 2015, ISBN 978-88-11-68501-2; Prefazione di Roberto Saviano, collana Gli elefanti. Saggi, Garzanti, 2017, ISBN 978-65-11-67298-1. * I dialoghi, a cura di Giovanni Falaschi, prefazione di Gian Carlo Ferretti, Collana I Grandi, Roma, Editori Riuniti, 1992, ISBN 978-88-359-3638-1. [comprende tutti i dialoghi apparsi su «Vie Nuove» e su «Tempo»] Epistolari * Lettere agli amici (1941-1945), Collana Biblioteca della Fenice n.3, Parma, Guanda, 1976. * Lettere 1940-1954, Con una cronologia della vita e delle opere, a cura di Nico Naldini, Collana Biblioteca dell’Orsa n.2, Torino, Einaudi, 1986, ISBN 978-88-06-59331-5. * Lettere 1955-1975, a cura di Nico Naldini, Collana Biblioteca dell’Orsa, Torino, Einaudi, 1988, ISBN 978-88-06-59953-9. * Vita attraverso le lettere, A cura di Nico Naldini, Collana ET Scrittori, Torino, Einaudi, 1994, ISBN 978-88-06-13580-5. Interviste Il sogno del centauro, A cura di Jean Duflot. Prefazione di Gian Carlo Ferretti, Collana Universale scienze sociali, Roma, Editori Riuniti, 1983. (lunga intervista concessa in due tempi– 1969 e 1975– apparsa dapprima in francese– nel 1970 e nel 1981– col titolo Les dernières paroles d’un impie); Collana I libelli, Editori Riuniti, II ed. 1993, ISBN 978-88-35-83789-0. * Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday, traduzione di C. Salmaggi, Collana Biblioteca della Fenice, Parma, Guanda, 1992, ISBN 978-88-7746-622-8. * Interviste corsare sulla politica e sulla vita 1955-1975, A cura di Michele Gulinucci, Roma, Liberal Atlantide editoriale, 1995. * Furio Colombo e Gian Carlo Ferretti (a cura di), L’ultima intervista di Pasolini, Collezione Le Coccinelle, Avagliano Editore, 2005, ISBN 978-88-8309-186-5. * Povera Italia. Interviste e interventi, 1949-1975, A cura di Angela Molteni, Kaos Edizioni, 2013, ISBN 978-88-7953-253-2. * Polemica Politica Potere, conversazioni con Gideon Bachmann, A cura di Riccardo Costantini, Collana Reverse, Milano, Chiarelettere, 2015, ISBN 978-88-6190-789-8. Programmi radiofonici * Paesaggi e scrittori: il Friuli, a cura di Pier Paolo Pasolini, sabato 17 agosto 1956, RAI programma nazionale. Filmografia * Accattone (1961) * Mamma Roma (1962) * La ricotta, episodio di Ro.Go.Pa.G. (1963) * La rabbia (1963) co-regia con Giovannino Guareschi * Comizi d’amore (1964) * Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo (1964) * Il Vangelo secondo Matteo (1964) * Uccellacci e uccellini (1966) * La Terra vista dalla Luna, episodio di Le streghe (1967) * Edipo re (1967) * Che cosa sono le nuvole?, episodio di Capriccio all’italiana (1968) * Appunti per un film sull’India (1968) * Teorema (1968) * La sequenza del fiore di carta, episodio di Amore e rabbia (1969) * Porcile (1969) * Medea (1969) * Appunti per un’Orestiade africana (1970) * Il Decameron (1971) * Le mura di Sana’a (1971) * I racconti di Canterbury (1972) * Il fiore delle Mille e una notte (1974) * Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) Discografia Album * 1995: Meditazione Orale (BMG Ricordi, 74321-27043-2) * 1997: Pasolini / Kresnik / Schwertsik– Gastmahl Der Liebe (Volksbühne Recordings) * 2005: Pasolini Rilegge Pasolini (Archinto) * 2006: Pier Paolo Pasolini, Giovanna Marini– Le Ceneri di Gramsci (Block Nota, I Dischi Di Angelica, CD BN 608) Singoli * 1962 Poesia In Forma Di Rosa (7") (RCA Italiana, 17 CL-12) Canzoni scritte da Pier Paolo Pasolini Premi e riconoscimenti cinematografici * Festival di Cannes 1958 al miglior soggetto originale per Giovani mariti di Mauro Bolognini * Nastro d’Argento 1960 al miglior soggetto originale per La notte brava di Mauro Bolognini * Primo premio per la regia al Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary 1962 per Accattone * Mostra internazionale di Venezia– 1964: Leone d’argento– Gran premio della giuria e premio O.C.I.C. (Office Chatolique International du Cinéma) per Il vangelo secondo Matteo * Nastro d’Argento al miglior regista 1965 per Il vangelo secondo Matteo * Nastro d’Argento 1967 al miglior soggetto originale per Uccellacci e uccellini * Mostra internazionale di Venezia– 1968 premio O.C.I.C. (Office Chatolique International du Cinéma) per Teorema * Premio “Amelia” 1969 per la cinematografia * Kinema Junpo Awards 1970: Miglior film straniero per Edipo re * Festival internazionale del cinema di Berlino: Orso d’argento 1971 per Il Decameron * Festival internazionale del cinema di Berlino: Orso d’oro 1972 per I racconti di Canterbury * Festival di Cannes 1974: Grand Prix Speciale della Giuria per Il fiore delle Mille e una notte * Festival di Venezia 2015: Miglior film restaurato per Salò o le 120 giornate di Sodoma Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini


Salvatore Quasimodo (Modica, 20 agosto 1901 – Napoli, 14 giugno 1968) è stato un poeta e traduttore italiano, esponente di rilievo dell’ermetismo. Ha contribuito alla traduzione di vari componimenti dell’età classica, soprattutto liriche greche, ma anche di opere teatrali di Molière e William Shakespeare. È stato vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1959. Biografia I primi anni e gli studi Salvatore Quasimodo nacque il 20 agosto 1901 da Gaetano Quasimodo e Clotilde Ragusa a Modica, dove il padre era stato assegnato come capostazione. A 5 giorni dalla sua nascita, la madre Clotilde, insieme al piccolo Salvatore e il primogenito Vincenzo (1899), si trasferì dai nonni paterni, nella più sicura casa di Roccalumera, luogo d’origine della famiglia Quasimodo. Purtroppo, il padre Gaetano non poté abbandonare il luogo di lavoro per seguirla e, dopo circa due mesi dalla nascita di Salvatore, venne trasferito. Salvatore fu battezzato a Roccalumera, nella Chiesa della Madonna Bambina da Mons. Francesco Maria Di Francia, l’11 settembre 1901. A Roccalumera il poeta trascorrerà tutta la sua infanzia e giovinezza e ci farà ritorno da grande per trovare i genitori e la famiglia (Dopo il conferimento del Premio Nobel fece ritorno a Roccalumera per consegnare l’ambito premio al padre novantenne). Nel 1908 a Gela iniziò a frequentare le scuole elementari. Nel gennaio del 1909 il padre venne incaricato della riorganizzazione del traffico ferroviario nella stazione di Messina colpita da un disastroso terremoto e successivo maremoto il 28 dicembre 1908. In quel periodo vissero in un carro merci parcheggiato su un binario morto della stazione. Quegli anni resteranno impressi nella memoria del poeta, che li evocherà nella poesia Al Padre, inserita nella raccolta La terra impareggiabile, scritta in occasione dei 90 anni del padre e dei 50 anni dal disastroso terremoto di Messina: Nel 1916 si iscrisse all’Istituto Tecnico Matematico-Fisico di Palermo per poi trasferirsi a Messina nel 1917 e continuare gli studi presso l’Istituto “A. M. Jaci”, dove conseguì il diploma nel 1919. Durante la permanenza in questa città conobbe il giurista Salvatore Pugliatti e il futuro sindaco di Firenze Giorgio La Pira, con i quali strinse un’amicizia destinata a durare negli anni. Insieme ad essi fondò nel 1917 il «Nuovo Giornale Letterario», mensile sul quale pubblicò le sue prime poesie. La tabaccheria di uno zio di La Pira, unico rivenditore della rivista, divenne luogo di ritrovo per giovani letterati. Nel 1919 si trasferì a Roma dove pensava di terminare gli studi di ingegneria ma, subentrate precarie condizioni economiche, dovette abbandonarli per impiegarsi in più umili attività: disegnatore tecnico presso un’impresa edile, e in seguito impiegato presso un grande magazzino. Nel frattempo collaborò ad alcuni periodici e iniziò lo studio del greco e del latino con la guida di monsignor Mariano Rampolla del Tindaro, pronipote omonimo del più famoso cardinale Rampolla del Tindaro, Segretario di Stato di Papa Leone XIII. Le precarie condizioni economiche di questo periodo romano terminarono nel 1926, quando venne assunto dal Ministero dei lavori pubblici e assegnato come geometra al Genio Civile di Reggio Calabria. Qui strinse amicizia con i fratelli Enzo Misefari e Bruno Misefari, entrambi esponenti (il primo comunista, il secondo anarchico) del movimento antifascista di Reggio Calabria. Nello stesso anno sposò Bice Donetti, una donna di otto anni più grande, con la quale aveva precedentemente convissuto e a cui dedicherà una poesia dopo la sua morte, avvenuta nel 1946: Nel 1948, due anni dopo la morte della prima moglie, si risposerà con la ballerina Maria Cumani, da cui avrà il figlio Alessandro Quasimodo. Nel periodo di Reggio Calabria nacque la nota lirica Vento a Tindari, dedicata alla storica località presso Patti: Il padre andò in pensione nel 1927 e dopo una breve permanenza a Firenze si ritirò definitivamente nella sua casa di Roccalumera, dove visse con due sorelle che non si erano sposate. Molti anni dopo il poeta emigrato si raffigurerà con questi versi: Nel 1939 divenne il titolare del settimanale Omnibus. Periodo dell’ermetismo (1930– 1942) Risolti i problemi economici poté dedicarsi più assiduamente all’opera letteraria. Fu invitato a Firenze dallo scrittore Elio Vittorini, che nel 1927 aveva sposato la sorella Rosa, che lo introdusse nei locali ambienti letterari permettendogli di conoscere Eugenio Montale, Arturo Loria, Gianna Manzini e Alessandro Bonsanti. Il Bonsanti che in quel tempo dirigeva la rivista Solaria pubblicò nel 1930 tre poesie (Albero, Prima volta, Angeli). Maturò e affinò così il gusto per lo stile ermetico, cominciando a dare consistenza alla sua prima raccolta Acque e terre, che lo stesso anno pubblicò per le edizioni Solaria.Nel 1931 venne trasferito presso il Genio Civile di Imperia e in seguito presso quello di Genova. In questa città conobbe Camillo Sbarbaro e le personalità di spicco che gravitavano intorno alla rivista Circoli, con la quale il poeta iniziò una proficua collaborazione pubblicando, nel 1932, per le edizioni della stessa, la sua seconda raccolta Oboe sommerso nella quale sono raccolte tutte le poesie scritte tra il 1931 e il 1932 e dove comincia a delinearsi con maggior chiarezza la sua adesione all’ermetismo. Dal marzo 1933 alla fine del 1934 lavorò come funzionario all’Ufficio del Genio Civile di Cagliari. Ottenuto il trasferimento a Milano, venne però destinato da un capo-ufficio alla sede di Sondrio. Nel 1938 lasciò il Genio Civile per dedicarsi alla letteratura, iniziò a lavorare per Cesare Zavattini in un’impresa di editoria e soprattutto si dedicò alla collaborazione con Letteratura, una rivista vicina all’ermetismo. Nel 1938 pubblicò a Milano una raccolta antologica intitolata Poesie, e nel 1939 iniziò la traduzione dei lirici greci. Nel 1941 venne nominato professore di Letteratura italiana presso il Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, incarico che mantenne fino alla fine del 1968. Seconda guerra mondiale Nel 1942 entrerà nella collana Lo specchio della Arnoldo Mondadori Editore l’opera Ed è subito sera, che inglobava anche le Nuove poesie scritte tra il 1936 e il 1942. Rapporti con il fascismo Nel 1940, a guerra iniziata e a Patto d’Acciaio consolidato, collaborò con la rivista Primato. Lettere e arti d’Italia dove il ministro Giuseppe Bottai raccolse intellettuali di varia estrazione e orientamento, anche lontani dal regime. Gli sarà rimproverato, in anni recenti, di aver sostenuto l’uso del voi con un intervento su un numero monografico del 1939 della rivista Antieuropa, e di aver inoltrato supplica a Mussolini che gli venisse assegnato un contributo per potere proseguire l’attività di scrittore. Pur professando chiare idee antifasciste, non partecipò attivamente alla Resistenza; in quegli anni si diede alla traduzione del Vangelo secondo Giovanni, di alcuni Canti di Catullo e di episodi dell’Odissea che verranno pubblicati solamente dopo la Liberazione. Periodo della poesia impegnata (1945– 1966) Nel 1945 si iscrisse al PCI e l’anno seguente pubblicò la nuova raccolta dal titolo Con il piede straniero sopra il cuore—ristampata nel 1947 con il nuovo titolo Giorno dopo giorno, testimonianza dell’impegno morale e sociale dell’autore che continuerà, in modo sempre più profondo, nelle successive raccolte, composte fra il 1949 e il 1958, come La vita non è sogno, Il falso e il vero verde e La terra impareggiabile, che si pongono, con il loro tono epico, come esempio di limpida poesia civile. Durante questi anni il poeta continuò a dedicarsi con passione all’opera di traduttore sia di autori classici che moderni, e svolse una continua attività giornalistica per periodici e quotidiani, dando il suo contributo soprattutto con articoli di critica teatrale. Nel 1950 il poeta ottenne il Premio San Babila, nel 1953 condivise il Premio Etna-Taormina con il poeta gallese Dylan Thomas, nel 1958 il premio Viareggio e nel 1959 gli fu assegnato il premio Nobel per la letteratura «per la sua poetica lirica, che con ardente classicità esprime le tragiche esperienze della vita dei nostri tempi» che gli fece raggiungere una definitiva fama. Ad esso seguirono le lauree honoris causa dalla Università di Messina nel 1960 e da quella di Oxford nel 1967. Il poeta trascorse gli ultimi anni di vita compiendo numerosi viaggi in Europa e in America per tenere conferenze e letture pubbliche delle sue liriche che nel frattempo erano state tradotte in diverse lingue. Nel 1965 cura la pubblicazione di Calignarmata, opera di poesia dell’autore Luigi Berti, uscita un anno dopo la morte di quest’ultimo (1964). Del 1966 è la pubblicazione di Dare e avere, sua ultima opera.Il 14 giugno del 1968, mentre il poeta si trovava ad Amalfi, dove doveva presiedere un premio di poesia, venne colpito da un ictus (aveva avuto già un infarto mentre visitava l’Unione Sovietica), che lo condusse alla morte poche ore dopo: il cuore del poeta, infatti. smise di battere sull’auto che lo stava trasportando all’ospedale di Napoli. Il suo corpo fu trasportato a Milano e tumulato nel Famedio del Cimitero Monumentale, luogo che già ospitava le spoglie di Alessandro Manzoni. Quasimodo fu membro della Massoneria. Il poeta e lo scrittore La prima raccolta di Quasimodo, Acque e terre (1930), è incentrata sul tema della sua terra natale, la Sicilia, che l’autore lasciò già nel 1919: l’isola diviene l’emblema di una felicità perduta cui si contrappone l’asprezza della condizione presente, dell’esilio in cui il poeta è costretto a vivere (così in una delle liriche più celebri del libro, Vento a Tindari). Dalla rievocazione del tempo passato emerge spesso un’angoscia esistenziale che, nella forzata lontananza, si fa sentire in tutta la sua pena. Questa condizione di dolore insopprimibile assume particolare rilievo quando il ricordo è legato ad una figura femminile, come nella poesia Antico inverno, oppure a ritmi e motivi più antichi, di origine anche popolare. Se in questa prima raccolta Quasimodo appare legato a modelli abbastanza riconoscibili (soprattutto D’Annunzio, del quale viene ripresa la tendenza all’identificazione con la natura), in Oboe sommerso (1932) ed Erato e Apollion (1936) il poeta raggiunge la piena e personale maturità espressiva. La ricerca della pace interiore è affidata ad un rapporto col divino che è, e resterà successivamente, tormentato, mentre la Sicilia si configura come terra del mito, terra depositaria della cultura greca: non a caso Quasimodo pubblicherà, nel 1940, una notissima traduzione dei Lirici greci. In particolare, nel libro del 1936 vengono celebrati Apollo– il dio del sole ma anche il dio cui sono legate le Muse, e quindi la stessa creazione poetica che è resa dolorosa dalla distanza fisica dell’isola– ed Ulisse, l’esule per eccellenza. È in queste raccolte che si può cogliere appieno la suggestione dell’ermetismo, di un linguaggio che ricorre spesso all’analogia e tende ad abolire i nessi logici tra le parole: importante è in questo senso l’uso frequente dell’articolo indeterminativo e degli spazi bianchi, che, all’interno della lirica, sembrano rimandare continuamente a una serie di significati nascosti che non possono trovare una piena espressione. Nelle Nuove poesie (pubblicate insieme alle raccolte precedenti nel volume Ed è subito sera del 1942 e scritte a partire dal 1936), il ritmo diventa più disteso grazie anche all’uso più frequente dell’endecasillabo o di altri versi lunghi (anche doppi): il ricordo della Sicilia è ancora vivissimo ma si avverte nel poeta un’inquietudine nuova, la voglia di uscire dalla sua solitudine e confrontarsi con i luoghi e le persone della sua vita attuale. In alcune liriche compare infatti il paesaggio lombardo, esemplificato dalla «dolce collina d’Ardenno» che porta all’orecchio del poeta «un fremere di passi umani» (La dolce collina). Questa volontà di dialogo si fa evidente nelle raccolte successive, segnate da un forte impegno civile e politico sollecitato dalla tragedia della guerra; la poesia rarefatta degli anni giovanili lascia il posto ad un linguaggio più comprensibile, dai ritmi più ampi e distesi. Così avviene in Giorno dopo giorno (1947) dove le vicende belliche costituiscono il tema dominante. La voce del poeta, annichilita di fronte alla barbarie («anche le nostre cetre erano appese», afferma in Alle fronde dei salici), non può che contemplare la miseria della città bombardata, o soffermarsi sul dolore dei soldati impegnati al fronte, mentre affiorano alla memoria delicate figure femminili, simboli di un’armonia ormai perduta (S’ode ancora il mare). L’unica speranza di riscatto è allora costituita dalla pietà umana (Forse il cuore). In La vita non è sogno (1949) il Sud è cantato come luogo di ingiustizia e di sofferenza, dove il sangue continua a macchiare le strade (Lamento per il Sud); il rapporto con Dio si configura come un dialogo serrato sul tema del dolore e della solitudine umana. Il poeta sente l’esigenza di confrontarsi con i propri affetti, con la madre che ha lasciato quand’era ancora un ragazzo (e che continua a vivere la sua vita semplice e ignara dell’angoscia del figlio ormai adulto), o col ricordo della prima moglie Bice Donetti. Nella raccolta Il falso e vero verde (1956) dove lo stesso titolo è indicativo di un’estrema incertezza esistenziale, un’intera sezione è dedicata alla Sicilia, ma nel volume trova posto anche una sofferta meditazione sui campi di concentramento che esprime «un no alla morte, morta ad Auschwitz» (Auschwitz). La terra impareggiabile (1958) mostra un linguaggio più vicino alla cronaca, legato alla rappresentazione della Milano simbolo di quella «civiltà dell’atomo» che porta ad una condizione di devastante solitudine e conferma nel poeta la voglia di dialogare con gli altri uomini, fratelli di dolore. L’isola natìa è luogo mitizzato, «terra impareggiabile» appunto, ma è anche memoria di eventi tragici come il terremoto di Messina del 1908 (Al padre). L’ultima raccolta di Quasimodo, Dare e avere, risale al 1966 e costituisce una sorta di bilancio della propria esperienza poetica e umana: accanto ad impressioni di viaggio e riflessioni esistenziali molti testi affrontano, in modo più o meno esplicito, il tema della morte, con accenti di notevole intensità lirica. Opere Raccolte di poesie * Acque e terre, Firenze, sulla rivista Solaria, 1930. * Oboe sommerso, Genova, sulla rivista Circoli, 1932. * Odore di eucalyptus ed altri versi, Firenze, Antico Fattore, 1933. * Erato e Apòllìon, Milano, Scheiwiller, 1936. * Nuove Poesie, Milano, Primi Piani, 1938. * Ed è subito sera, 1947. * La vita non è sogno, Milano, A. Mondadori, 1949. * Il falso e vero verde (1949-1955), Milano, Schwarz, 1956. * La terra impareggiabile, Milano, A. Mondadori, 1958. * Dare e avere. 1959-1965, Milano, A. Mondadori, 1966. Traduzioni * Lirici greci, Milano, Edizioni di Corrente, 1940; maggio 1944, Mondadori. * Virgilio, Il Fiore delle Georgiche, Milano, Edizioni della Conchiglia, 1942.– Milano, Gentile, 1944; Milano, Mondadori, 1957. * Catulli Veronensis, Carmina, Milano, Edizioni di Uomo, 1945.– Milano, Mondadori, 1955. * Omero, Dall’Odissea, Milano, Rosa e Ballo, 1945. * Sofocle, Edipo re, Milano, Bompiani, 1946. * Il Vangelo secondo Giovanni, Milano, Gentile, 1946. * John Ruskin, La Bibbia di Amiens, Milano, Bompiani, 1946. * William Shakespeare, Romeo e Giulietta, Milano, Mondadori, 1948. * Eschilo, Le Coefore, Milano, Bompiani, 1949. * William Shakespeare, Riccardo III, Milano, Edizioni del Piccolo Teatro, 1950.– Milano, Mondadori, 1952. * Pablo Neruda, Poesie, Torino, Einaudi, 1952. * William Shakespeare, Macbeth, Torino, Einaudi, 1952. * Sofocle, Elettra, Milano, Mondadori, 1954. * William Shakespeare, La Tempesta, Torino, Einaudi, 1956. * Molière, Il Tartufo, Milano, Bompiani, 1958. * Fiore dell’Antologia Palatina, Parma, Guanda, 1958. * Edward Estlin Cummings, Poesie scelte, Milano, Scheiwiller, 1958. * Ovidio, Dalle Metamorfosi, Milano, Scheiwiller, 1959. * William Shakespeare, Otello, Collana Lo Specchio, Milano, Mondadori, 1959. * Euripide, Ecuba, Urbino, Armando Argalìa Editore, 1962. * Conrad Aiken, Mutevoli pensieri, Milano, Scheiwiller, 1963. * Euripide, Eracle, Urbino, Armando Argalìa Editore, 1964. * William Shakespeare, Antonio e Cleopatra, Milano, Mondadori, 1966. * Tudor Arghezi, Poesie, Milano, Mondadori, 1966. * Yves Lecomte, Il gioco degli astragali, Edizioni Moneta, 1968. Curatele * Lirici minori del XIII e XIV secolo, a cura di S. Quasimodo e Luciano Anceschi, Milano, Edizioni della Conchiglia, 1941. * Lirica d’amore italiana, dalle origini ai nostri giorni, 1957. * Poesia italiana del dopoguerra, 1958. Altri scritti * Petrarca e il sentimento della solitudine, Milano, Garotto, 1945. * Scritti sul teatro, 1961. * L’amore di Galatea libretto per musica, 1964 * Il poeta e il politico e altri saggi, Milano, Schwarz, 1967. * Leonida di Taranto, Milano, Guido Le Noci ed., 1968; Manduria, Lacaita, 1969. * Lettere d’amore di Quasimodo, post., 1969 * Poesie e discorsi sulla poesia, post., 1971. * Marzabotto parla. Con scritti di Salvatore Quasimodo, Giuseppe Dozza, post., 1976 * A colpo omicida e altri scritti, post., 1977. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Quasimodo
Née le 1er Avril 1845 à Lyon d'une famille protestante, Louisa Siefert est une poétesse française du XIXe siècle qui, décédée trop tôt (le 21 Octobre 1877), aura laissé une poésie empreinte de douleur mais garnie de sensibilité. En 1863, elle fait la connaissance de nombre d'écrivains illustres, par l'entremise Charles Asselineau, ami de Charles Baudelaire, comme Victor Hugo, Edgar Quinet, Émile Deschamps, Théodore de Banville, Charles-Marie Leconte de Lisle, Sainte-Beuve, Michelet ou encore le peintre Paul Chenavard. Son premier recueil de poésie, "Rayons perdus" paraît 1868 et connait déjà un succès important ; succès d'autant plus appuyé par la lettre que Victor Hugo va lui soumettre, dans laquelle le géant la félicite de son écriture. Œuvres : - Rayons perdus, Paris, Lemerre, 1868 - L’Année républicaine, Paris, Lemerre, 1869 - Les Stoïques, Paris, Lemerre, 1870 - Les Saintes Colères, Paris, Lemerre, 1871 - Comédies romanesques, Paris, Lemerre, 1872 - Souvenirs rassemblés par sa mère et poésies inédites, Paris, Fischbacher, 1881.

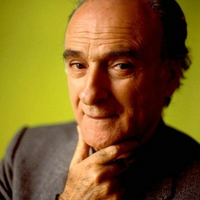
Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo, 10 ottobre 1921 – Conegliano, 18 ottobre 2011) è stato un poeta italiano tra i più significativi della seconda metà del Novecento. Biografia Andrea Zanzotto nacque nel 1921 a Pieve di Soligo da Giovanni e Carmela Bernardi. Durante i primi due anni di vita, visse in un vicolo vicino a via Sartori, ma due anni dopo, nel 1922, la famiglia si trasferì nella contrada di Cal Santa, dove il padre, che lavorava come miniatore, decoratore e ritrattista, aveva acquistato casa: saranno questi i luoghi più volte descritti dal poeta e la casa, come egli stesso scrive nell’Autoritratto del 1977, sarà, fin dall’inizio, il centro del suo mondo. La formazione scolastica Nel 1923 nacquero le due sorelle gemelle Angela e Marina e, nel 1924, Zanzotto iniziò a frequentare la scuola materna, gestita da suore che seguivano il metodo Montessori. Nel 1925 nacque la sorella Maria. Nel frattempo il padre, che aveva espresso apertamente le lodi di Giacomo Matteotti, venne accusato di antifascismo e, con l’andare del tempo, la sua opposizione al regime gli rese difficile ogni tipo di lavoro, tanto da decidere nel 1925 di rifugiarsi a Parigi e poi a Annœullin, nei pressi di Lilla, dove lavorò presso degli amici. Ritornò poi per un breve periodo in patria, ma nel 1926 fu costretto a ritornare in Francia, a Royan, dove rimase fino al dicembre dello stesso anno. La scuola elementare Quando nel 1927 iniziò la scuola elementare, grazie alla maestra Marcellina Dalto, Zanzotto aveva già imparato a scrivere: fu così inserito nella seconda classe. Come racconta il poeta stesso nel suo Autoritratto, egli già sentiva il piacere della musicalità delle parole: “provavo qualcosa di infinitamente dolce ascoltando cantilene, filastrocche, strofette (anche quelle del ”Corriere dei Piccoli") non in quanto cantate, ma in quanto pronunciate o anche semplicemente dette, in relazione a un’armonia legata proprio al funzionamento stesso del linguaggio, al suo canto interno".Nel 1928 il padre ottenne un impiego come insegnante presso una scuola in Cadore e decise di trasferirsi con la famiglia a Santo Stefano, dove Zanzotto avrebbe terminato la seconda classe. Alla fine dell’estate però Giovanni, resosi conto della sofferenza che il distacco dalla madre causava alla moglie, decise di far rientrare la famiglia a Pieve. Nel 1929 morì una delle sue sorelle, Marina, evento che rimase impresso, insieme ad altri episodi dolorosi, nella sua giovane mente. In quello stesso anno, infatti, il padre Giovanni si mise in luce con una chiara e decisa propaganda per il “No” al plebiscito fascista: fu così costretto a prolungare il suo esilio, riuscendo comunque a lavorare alla decorazione della chiesa di Costalissoio. Zanzotto, che frequentava ormai la terza elementare, lo raggiunse durante il periodo delle vacanze estive, pur soffrendo per la nostalgia di casa. Nel 1930 nacque un altro fratello, Ettore. Intanto, la fuga di un cassiere con i fondi della società che garantiva il sostegno familiare a Giovanni, obbligò lo stesso, insieme ad altri garanti (si trattava di un’associazione tra mutilati di guerra che aveva preso la forma di una cooperativa di lavoro), a contrarre debiti imponendo all’intera famiglia notevoli ristrettezze economiche. In questo periodo Zanzotto si affezionò ancor più alla nonna paterna e alla zia Maria, la quale, come scriverà in “Uno sguardo dalla periferia”, gli faceva ascoltare “frammenti di latino maccheronico” e lo coinvolse nell’attività del teatrino delle suore, presso cui lei aveva funzione di drammaturgo, capocomico, regista e attrice. A scuola si dimostrava un alunno vivace e non sempre disciplinato, ricevendo spesso i rimproveri del padre. Un punto debole in cui il giovinetto risultava piuttosto impacciato era il disegno, arte perfezionata invece magistralmente dal padre, il quale insisté allora perché prendesse lezioni di musica, arte molto amata dagli abitanti di Pieve per la fama del famoso soprano conterraneo Toti Dal Monte, che verrà ricordato da Zanzotto all’inizio della sua opera Idioma. La scuola media Terminata la scuola elementare nel 1931 come allievo esterno al Collegio Balbi-Valier, dopo l’esame pubblico a Vittorio Veneto, Zanzotto iniziò la scuola media, maturando intanto la decisione di studiare per l’istituto magistrale, spinto soprattutto dalle precarie condizioni economiche familiari. Il padre Giovanni lavorava nel frattempo a Santo Stefano, ma nel 1932 fu costretto, causa la riduzione degli stipendi, a ritornare ad Annœullin dove rimase fino al novembre. Rientrò a Pieve nel 1933 e, anche se per lui rimase il divieto di insegnare, riuscì a dare un aiuto alla famiglia grazie ad un incarico presso la scuola media del collegio Balbi-Valier e a vari lavori occasionali. Rendendosi inoltre conto della sua grande responsabilità nei confronti della famiglia, evitò ogni scontro diretto con gli avversari politici. L’istituto magistrale Per Zanzotto intanto, con il passaggio all’istituto magistrale che frequentò a Treviso facendo il pendolare, iniziarono anche i primi forti interessi letterari che cercherà di nutrire al momento consultando l’enciclopedia di Giacomo Prampolini, la Storia Universale della Letteratura, che riportava esempi di poesia di autori di tutto il mondo. Risale al 1936 il suo primo amore e l’ispirazione dei primi versi che, con la complicità della nonna e delle zie, riuscì a pubblicare su un’antologia per la quale aveva versato un piccolo contributo. I versi non avevano ancora uno stile personale e risentivano dell’influenza pascoliana dato che un nipote di Giovanni Pascoli che lavorava nella banca locale, conoscendo la sua passione per la poesia, gli aveva regalato alcuni volumi del poeta in edizione originale. Il passaggio al liceo classico Nel 1937 morì di tifo la sorella Angela: al dolore per il grave lutto, che lo turbò profondamente, si aggiunse la fatica della pendolarità con Treviso, oltre alla stanchezza accumulata con l’intensificarsi dello studio, poiché, volendo rendere più brevi i tempi del diploma, si era presentato all’esame nell’ottobre precedente, portando tutte le materie del penultimo anno, riuscendo a superarlo con successo; aveva inoltre iniziato lo studio del greco, al fine di superare l’esame di ammissione al liceo classico. Si ripresentarono così con maggior forza episodi allergici e asmatici già apparsi in precedenza, che egli visse, insieme agli altri motivi di malessere, con un sentimento di esclusione e precarietà: "[...] credo che abbia male influito sulla mia infanzia e sulla mia adolescenza l’infiltrarsi progressivo in me di un’idea certo aberrante: quella dell’impossibilità di partecipare attivamente al gioco della vita in quanto io ne sarei stato presto escluso. Io soffrivo di varie forme di allergia e a quei tempi la diagnosi poteva essere abbastanza confusa, dubbia. L’asma, la pollinosi che mi tormentavano fin da piccolo erano talvolta interpretate come fatti che potevano aggravarsi, in teoria, anche a breve scadenza". Conseguito il diploma magistrale, il direttore del collegio Balbi-Valler gli affidò alcuni scolari per ripetizioni, mentre ottenne dal parroco, monsignor Martin, duemila lire come “debito d’onore” per continuare gli studi.Zanzotto intanto superava l’esame di ammissione conseguendo la maturità classica come privatista al liceo ginnasio statale Antonio Canova di Treviso. L’Università Nel 1938 si iscrisse alla facoltà di lettere dell’Università di Padova, dove ebbe come insegnanti, tra gli altri, Diego Valeri e il latinista Concetto Marchesi. Sotto la spinta di Valeri, approfondì la lettura di Baudelaire e scoprì Rimbaud, mentre, grazie a Luigi Stefanini, lesse per la prima volta Hölderlin, nella traduzione di Vincenzo Errante. Iniziò intanto ad apprendere la lingua tedesca giungendo così a leggere in lingua originale i grandi poeti della letteratura tedesca: Hölderlin, Goethe e Heine. Nel 1940 ottenne la sua prima supplenza a Valdobbiadene. Scoprì intanto che, all’interno del regime e soprattutto nelle associazioni giovanili, vi erano molti iscritti che agivano nella pratica in modo autonomo o in contrasto con esso, come venne a sapere dal suo amico e maestro Ettore Luccini, organizzatore culturale e docente al liceo classico, nonché legato all’ambiente padovano della rivista anticonformista Il Bò, alla quale Zanzotto collaborò; negli stessi anni intervenne anche sul foglio universitario trevigiano Signum (a cui collaboravano anche Luzi, Strehler e Mario Tobino) che mantiene solo di facciata l’adesione al regime. Lo scoppio della seconda guerra mondiale fu accolto nel paese con grande costernazione, la crisi economica si fece maggiormente sentire e la sua famiglia fu costretta a vendere metà della casa di Cal Santa. Nel 1941 la supplenza a Valdobbiadene non gli fu rinnovata, ma riuscì ad ottenerne una a Treviso presso una scuola media come laureando. Presso il GUF di Treviso, all’interno del quale erano presenti personaggi che praticavano l’antifascismo, Zanzotto tenne, nel 1942, una “presentazione” di Montale dove interpretò il pessimismo dell’autore in chiave politica ed etica con la lettura degli Ossi di seppia. Il 30 ottobre 1942, con una tesi dal titolo “L’arte di Grazia Deledda”, Zanzotto si laureò in letteratura italiana presso l’Università di Padova, avendo come relatore il professor Natale Busetto. Un’edizione anastatica della sua tesi è stata edita dalla Padova University Press. Il periodo bellico Chiamato alla visita militare, venne dichiarato rivedibile per insufficienza toracica e per la forte asma allergica, rimanendo così esonerato alla chiamata alle armi della classe 1921 protagonista delle tragica campagna in Russia e in Grecia. Rifiutò in seguito di rispondere al reclutamento di volontari organizzati dal Fascio. Pubblicò nel nº 10 di Signum una prosa intitolata Adagio e risalgono a quell’anno i primi abbozzi di narrazione tra la prosa e il lirismo che formano il nucleo più antico del volume Sull’Altopiano, pubblicato nel 1964. Si profilava intanto la possibilità di pubblicare, nella collana di poesia che affiancava la rivista fiorentina Rivoluzione, inaugurata da Mario Tobino con Veleno e amore, una breve raccolta di scritti dell’autore ma, a causa degli eventi bellici, il periodico fu costretto a chiudere. La chiamata alle armi Intanto ai primi di febbraio del 1943 Zanzotto ricevette la chiamata alle armi con la leva del '22 e fu inviato ad Ascoli Piceno per frequentare il corso AUC. Tra i libri che portò con sé ci sono i versi di Vittorio Sereni: "quando ancora non lo conoscevo e restavo quasi a bocca aperta, stordito dai rispecchiamenti, dalle fioriture, dal candore, dai misteri della sua Frontiera (e pensavo: ma allora lui ha già detto tutto, di me, di noi, proprio di questi giorni e attimi...) mentre la leggevo portandola con me in treno sotto le armi" (Per Vittorio Sereni 1991). Zanzotto non rimase molto tempo ad Ascoli perché, con l’avanzare della stagione, si era manifestata in tutta la sua virulenza l’allergia che lo costrinse all’Ospedale Militare di Chieti dove gli fu riscontrata una forte compromissione bronchiale con ectasia. Sospeso dall’addestramento come allievo ufficiale, venne inviato al deposito del 49º Fanteria di Ascoli e, non avendo terminato il periodo del CAR, in attesa di nuova visita, assegnato ai servizi non armati. Il periodo di Ascoli Il periodo trascorso ad Ascoli fu caratterizzato dall’inasprimento della malattia, parzialmente risolte solo dopo il '52 alla comparsa dei primi antistaminici, e a una forte depressione caratterizzata da una grave insonnia. Assolto intanto dall’incarico di piantone e affidatogli quello di scritturale, riuscì a trovare un po’ di tempo, soprattutto quando ritornava dalle scarse licenze che lo aiutavano a rinnovare il legame con la sua terra, per dedicarsi alla scrittura di poesie, alcune delle quali faranno parte in seguito delle raccolte Dietro il paesaggio e Vocativo. L’8 settembre e il rientro a Pieve di Soligo L’8 settembre Zanzotto si trovava in libera uscita quando giunse, tra urla e grida, la notizia dell’armistizio. Dopo essere riuscito ad ottenere notizie dalla madre sulla famiglia, rientra alle Casermette, dove venivano addestrati gli allievi ufficiali, ma un battaglione di soldati tedeschi cerca di passare con l’intenzione di attraversare Ascoli. Gli italiani, radunate le forze, vogliono fare opposizione e anche Zanzotto marcia in una colonna di rinforzo che ha l’ordine di combattere. Compreso però che l’avanzare delle truppe tedesche non si può arrestare con le poche forze a disposizione, le retrovie ricevono l’invito a fuggire. Zanzotto, procuratosi un abito borghese, raggiunse San Benedetto del Tronto per tentare la via del ritorno a casa. Alla stazione di Ferrara, pur presidiata dalla Wehrmacht, riesce a salire su un treno che lo porta a Padova dove alcuni amici, presto rintracciati, lo informano dell’intenzione dei fascisti di organizzare un nuovo governo. Appurato che la corriera per Pieve di Soligo compie servizio regolare Zanzotto si reca al suo paese, ma nello stesso giorno vengono affissi ai muri i Befehle con l’ordine per tutti i soldati dell’esercito italiano di trovarsi radunati entro quarantotto ore. In seguito a febbrile colloquio notturno viene presa la decisione di non presentarsi e così, dopo aver fatto rifornimenti di viveri e vestiario, in attesa di una normalizzazione, viene presa la decisione di rifugiarsi sulle colline. Quando i controlli sembrano essersi allentati, Zanzotto ritorna a Soligo e cerca di aiutare finanziariamente la famiglia dando lezioni private nel collegio Balbi-Valier che continua a distinguersi come centro dell’antifascismo locale. L’attività nella Resistenza Nell’inverno del '43– '44 presero forma le prime brigate della Resistenza e Zanzotto iniziò ad aderire ad esse partecipando così alla Resistenza veneta nelle Brigate Giustizia e Libertà occupandosi della stampa e della propaganda del movimento, avendo come punto di riferimento la figura di Antonio Adami, detto Toni, intellettuale antifascista e partigiano non violento ucciso il 26 marzo 1945 dai nazi-fascisti al quale il poeta dedicherà nel 1954 la poesia Martire, primavera. Intanto le speranze di una conclusione degli eventi bellici va allontanandosi e all’interno dell’organizzazione della resistenza la situazione diventa difficile per mancanza di concordia tra le varie associazioni. Viene così a formarsi nella zona una Brigata Mazzini che, pur essendo sotto il controllo del Partito Comunista, accoglie altre differenti forze antifasciste. Zanzotto, che come Adami mantiene la decisione di non far uso delle armi, vi aderisce e viene impiegato nella propaganda partecipando così alla realizzazione di manifesti e fogli informativi. In seguito allo sbarco degli alleati in Francia le organizzazioni partigiane della zona occuparono il Quartier di Piave, territorio strategicamente difficile per le molte vie di accesso e per la presenza del comando nemico di Belluno, formando una vera repubblica partigiana che, all’inasprirsi della pressione tedesca, dovrà prendere atto della sua debolezza. Il 10 agosto del '44 scoppia la prima rappresaglia e il paese è sottoposto a sparatorie e incendi. Molte furono le vittime, tra le quali Gino Dalla Bortola caro amico del poeta. Vennero catturati anche molti ostaggi tra i quali il fratello Ettore che, essendo solo quattordicenne, non sarà deportato a Belsen come gli altri del gruppo ma presto rilasciato. Zanzotto riesce a raggiungere la zona di Mariech e Salvedella dove era situato l’ufficio stampa per deciderne lo spostamento. Il 31 agosto inizia il grande rastrellamento e a portarne notizia sarà il comandante Nardo (Lino Masin) e Toni Adami. Più di duecento abitazioni di Pieve di Soligo, Soligo e Solighetto erano state date alle fiamme. Zanzotto, con i compagni, cercherà di discendere la montagna sapendo che tedeschi e fascisti stavano preparandosi a risalirla. Il giorno dopo Zanzotto riuscirà, con altri, a sfuggire dall’accerchiamento. Ci saranno giorni di violenza e verranno catturati altri partigiani poi deportati. Giunta intanto la notizia del massacro di Soligo Zanzotto si dà alla macchia fino a metà settembre quando finalmente riesce a mettersi in contatto con i familiari. Il paese era nel frattempo diventato una specie di campo di concentramento e con l’arrivo dell’inverno Zanzotto verrà reclutato a forza e mandato al lavoro coatto ma riuscirà, con un certificato medico attestante il peggioramento della malattia, ad essere esonerato dai lavori più pesanti, ma non dalla corvée. Alla fine dell’inverno, e siamo ormai nell’anno 1945, Zanzotto riprese l’attività partigiana e ritornò sulle colline a continuare il lavoro di propaganda. Tranne uno scritto in ricordo dell’amico Toni Adami che diffonde, in questo periodo egli scriverà solamente qualche pagina di diario e una lirica che sarà offerta più tardi per un memoriale della Brigata Piave, dedicata ai morti fucilati in paese. Dopo un mese di continui scontri gli alleati libereranno la zona ma nei giorni successivi il 30 aprile accaddero altri atti di violenza e di rappresaglia a Valdobbiadene e Oderzo. "Un cospicuo materiale documentario sulle vicende di questo periodo sarà raccolto in seguito da Lino Masin nel memoriale La lotta di liberazione nel Quartier del Piave e la Brigata Mazzini 1943-45 (Treviso 1989) al quale Zanzotto contribuirà con la nota Una attiva testimonianza". In questo periodo raccoglierà in un fascicolo le poesie scritte nel '41– '42 che verranno pubblicate nel 1970 con il titolo A che valse? e alcuni componimenti che faranno poi parte di Dietro il paesaggio. Ripresi intanto i contatti con gli amici di Padova ritornerà a frequentare i gruppi attivi legati a "Comunità" e al Partito Comunista. Invitato da Aldo Camerino Zanzotto parteciperà a Venezia ad una importante mostra di poesia recandosi poi, nei mesi successivi, numerose volte a Milano dove, nel giugno, accompagnato l’amico scultore Carlo Conte in casa di Alfonso Gatto incontrerà Vittorio Sereni da poco ritornato dall’Algeria. Nel 1946 il referendum per scegliere il nuovo governo mobiliterà l’intero paese e Zanzotto sosterrà il voto in favore della repubblica. L’emigrazione in Svizzera Intanto Zanzotto, in attesa del termine dell’anno scolastico 1945– 1946 dove aveva ottenuto una supplenza nel collegio del Balbi-Valier, decise di emigrare avendo saputo da amici di Treviso che in Svizzera era più facile trovare un lavoro. Nel mese di settembre ottenne un posto da insegnante presso un collegio di Villars-sur-Ollon, nel Canton Vaud. Costretto prima della fine dell’anno scolastico a rientrare in Italia per essere operato di appendicite, ritornerà in Svizzera dopo il mese di convalescenza ma deciderà di lasciare l’incarico al collegio per recarsi a Losanna dove si stabilirà. Per guadagnare farà il barista e il cameriere riuscendo così, grazie ai turni, ad avere mezza giornata libera che dedicherà a gite in Francia. A Losanna avrà occasione di frequentare i seguaci del medium svedese Swedenborg avendo così la possibilità di conoscere i libri introvabili di questo personaggio che influenzerà Balzac e i Surrealisti. Partecipa ad un premio bandito da Neri Pozza, che sarà vinto da Vittorio Gassman, con un frammento narrativo intitolato Luca e i numeri e inizierà a scrivere in francese il Cahier Vaudois che lascerà incompiuto e inedito. Il rientro in Italia Verso la fine del 1947, quando sembravano riaperte le prospettive d’insegnamento, Andrea farà ritorno in Italia. Partecipò in questo periodo al Premio Libera Stampa di Lugano dove venne segnalato dalla giuria e dove ebbe modo di conoscere molti letterati e critici tra i quali Carlo Bo e Luciano Anceschi e rivedrà Vittorio Sereni con il quale instaurerà un lungo rapporto di amicizia. Tra gli autori segnalati per il Premio Libera Stampa ci sarà anche Pier Paolo Pasolini e Maria Corti. Si recherà spesso a Milano dove alloggerà in un piccolo albergo vicino alla stazione e a poca distanza dalla casa di Sereni e conoscerà molti dei letterati noti in questo periodo come Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo. Continuerà inoltre a dedicarsi alla preparazione di diverse prove di concorso e allo studio per la laurea in filosofia ma, completati gli esami necessari, al momento della tesi incentrata su Kafka, si fermò a causa dell’insufficiente conoscenza del tedesco. Ottenne nel frattempo l’abilitazione in italiano, latino, greco, storia e geografia e nell’anno scolastico 1949-'50 ottenne l’insegnamento al Liceo Flaminio di Vittorio Veneto. I primi componimenti poetici, l’insegnamento e i primi scritti critici Nel 1950 concorse al Premio San Babila per la sezione inediti: la giuria era composta da Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Leonardo Sinisgalli, Vittorio Sereni e gli venne attribuito il primo premio per un gruppo di poesie, composte tra il 1940 e il 1948, che sarà poi pubblicato nel 1951 con il titolo Dietro il paesaggio. Trascorso un periodo di crisi depressive si mise in contatto con Cesare Musatti che lo aiuterà, in parte, a fronteggiare e ad uscire dalla situazione di disagio psichico in cui si trovava. Si susseguiranno in questi anni i vari incarichi di insegnamento e a Motta di Livenza incontrerà Giuseppe Bevilacqua che gli farà scoprire la poesia tedesca contemporanea e le opere di Paul Celan. Con il nuovo anno scolastico Zanzotto lascerà la sede di Motta di Livenza per passare a Treviso e nuovamente al Liceo di Vittorio Veneto. Nel 1954, con un intervallo di soli tre anni da Dietro il paesaggio, usciranno nella collana Mondadori diretta da Sereni, Elegia e altri versi con la prefazione di Giuliano Gramigna. Nel frattempo affiancò all’attività di insegnante e poeta quella di critico letterario, collaborando dal 1953 al 1957 a La Fiera Letteraria, dal 1958 al 1965 a Comunità oltre che a Il Mondo e al Il Popolo di Milano. Nello stesso anno Zanzotto ottenne la cattedra nella scuola media di Conegliano come insegnante di ruolo e partecipò ad un incontro letterario a San Pellegrino dove venne presentato da Ungaretti. Il discorso pronunciato da quest’ultimo fu molto lusinghiero e comparirà su “L’Approdo”: «[...] Caro Zanzotto, eccoLa entrato in una storia illustre, e Le auguro, e ora verrà il più difficile, che in essa Ella riesca a portare a conclusione la Sua storia. Coraggio»A Padova conobbe il letterato feltrino Silvio Guarnieri con il quale strinse un forte legame d’amicizia che andò a consolidarsi nel corso del 1955. Dopo la sua morte avvenuta nel 1992, sono state rinvenute 101 lettere e cartoline di Zanzotto, oggi depositate presso il Fondo manoscritti di autori moderni e contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia. In questo periodo si andò intanto delineando un nuovo libro di poesie che prenderà forma definitiva nel 1956 e verrà dato alla stampa presso Mondadori nel 1957 con il titolo di Vocativo. Le nuove amicizie e il matrimonio Il 1958 sarà segnato dal riapparire delle forme ansiose delle quali aveva sofferto in passato ma troverà un forte sostegno da un gruppo solidale di amici che si ritrovano a Treviso o nei paesi situati in collina; tra questi vi è spesso l’amico Giovanni Comisso, affiancato dal poeta Giocondo Pillonetto. Di questo periodo è la comparsa della figura di Nino (Angelo Mura), agricoltore e proprietario di terreni, nella cui abitazione si terranno convegni dedicati all’arte e alla cucina ai quali partecipano noti artisti e studiosi veneti. Sarà di questo anno la collaborazione con la rivista Comunità, che si protrarrà fino al 1965, e gli incontri frequenti con Marisa Michieli che sposerà nel luglio del 1959. Nello stesso anno vinse il Premio Cino Del Duca con alcuni racconti e iniziò la riflessione sulla sua poesia con la pubblicazione di Una poesia ostinata a sperare. Il 4 maggio del 1960 morì il padre di ictus e il 20 maggio nacque il suo primo figlio, che venne battezzato con il nome del nonno Giovanni. Collaborò in quell’anno alla rivista Il Caffè che riuniva i migliori nomi del panorama letterario del momento, come Calvino, Ceronetti, Manganelli e Volponi. La rivista ospitò in quell’anno un suo scritto, Michaux, il buon combattente, che trattava dell’effetto delle droghe, argomento che, anche se ancora lontano dalla cronaca quotidiana, si stava affacciando nel dibattito culturale. Nel 1961 nacque il secondo figlio, Fabio, e nello stesso anno Zanzotto rinunciò ad un trasferimento che aveva già ottenuto come professore presso l’Università di Padova. Accettò pertanto di organizzare a Col San Martino, una frazione di Farra di Soligo, la scuola media inferiore dove svolse per due anni mansioni di preside e di insegnante. Le distanze da I Novissimi Nel 1962 Mondadori pubblicò il suo volume di versi IX Egloghe e sulla rivista Comunità apparve un articolo nel quale il poeta prendeva decisamente le distanze dai motivi che inserivano la raccolta in un’antologia, con il titolo I Novissimi, delle poesie di Nanni Balestrini, Elio Pagliarani, Edoardo Sanguineti, Alfredo Giuliani e Antonio Porta, sostenendo l’idea di una poesia intesa come esperienza “individuale”. L’articolo, tuttavia, non incrinò il suo rapporto con Luciano Anceschi, direttore della rivista Il Verri e principale promotore dell’antologia. La collaborazione alle riviste Dal 1963 la sua presenza di critico su riviste e quotidiani si intensificò: scrisse per Questo e altro, L’Approdo letterario, Paragone, Nuovi Argomenti, Il Giorno, l’Avanti!, il Corriere della Sera. Scrisse anche numerosi saggi critici, soprattutto su autori a lui contemporanei come (Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Vittorio Sereni). Ottenne in questo anno il trasferimento definitivo nella scuola media di Pieve di Soligo dove insegnerà fino al 1971. Altre esperienze Nel 1964 incontrò ad Asolo il filosofo tedesco Ernst Bloch e ne rimase conquistato: veniva intanto pubblicato il suo primo libro di prose creative, Sull’altopiano. La giuria presieduta da Diego Valeri e composta, tra gli altri, da Carlo Bo, Carlo Betocchi e Giacomo Debenedetti, gli assegnò in quello stesso anno il “Premio Teramo” per un racconto inedito. Sempre del '64 è l’esperienza teatrale Il povero soldato, tratta da un montaggio di brani presi dal Ruzante. Nel 1965 partecipò agli incontri italo-iugoslavi di Abbazia insieme a Bandini, Giudici, Segre Dobrica Ćosić che in quel momento era il rappresentante appartenente all’ala liberale del partito comunista al potere. Nel 1966 tradusse per Mondadori dal francese Età d’uomo. Notti senza notte e alcuni giorni senza giorno di Michel Leiris. Intanto, con la conferenza di Jacques Lacan all’Istituto di cultura di Milano in occasione dell’uscita degli Écrits, si inaugurava anche in Italia il fortunato periodo dello strutturalismo e Zanzotto partecipò all’evento insieme ai maggiori rappresentanti dell’arte e della cultura. In questo periodo iniziò a scrivere sull’Avanti! e partecipò a Milano alla presentazione del libro di Ottieri L’irrealtà quotidiana, che egli considerava una tra le più importanti opere del secondo Novecento. Risale al 1967 un suo viaggio a Praga dove partecipò con Sereni, Fortini e Giudici ad una cerimonia di presentazione di un’antologia della poesia italiana ricevendo, insieme agli altri poeti italiani, una calorosa accoglienza. È di questo periodo il suo avvicinamento alle posizioni politiche di Fortini e dei Quaderni Piacentini di Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi con la quale manterrà sempre rapporti di amicizia. I primi importanti volumi in versi "La Beltà" Nel 1968 uscì il volume in versi La Beltà (tuttora considerata la raccolta fondamentale della sua opera) presentato a Roma da Pier Paolo Pasolini e a Milano da Franco Fortini, mentre il 1º giugno uscì su Il Corriere della sera una recensione scritta da Eugenio Montale sulla poesia di Zanzotto che, avendo già potuto conoscere alcuni versi del nuovo poeta, aveva scritto: "Zanzotto non descrive, circoscrive, avvolge, prende, poi lascia. Non è proprio che cerchi se stesso e nemmeno che tenti di fuggire alla sua realtà; è piuttosto che la sua mobilità è insieme fisica e metafisica, e che l’inserimento del poeta nel mondo resta altamente problematico e non è nemmeno desiderato[...] È una poesia coltissima, la sua, un vero tuffo in quella pre-espressione che precede la parola articolata e che poi si accontenta di sinonimi in filastrocca, di parole che si raggruppano per sole affinità foniche, di balbettamenti, interiezioni e soprattutto iterazioni. È un poeta percussivo ma non rumoroso: il suo metronomo è forse il batticuore[...] Una poesia inventariale che suggestiona potentemente e agisce come una droga sull’intelletto giudicante del lettore. “Gli sguardi i fatti e senhal” Nel 1969 pubblicò Gli sguardi, i fatti e senhal, scritto subito dopo lo sbarco sulla luna effettuato dall’astronauta statunitense Neil Armstrong il 21 luglio, dimostrando ancora una volta quanto egli fosse attento al pulsargli della vita intorno, agli eventi e al loro concatenarsi. In questo anno gli viene assegnato in Mestre il prestigioso premio della “Tavola all’Amelia” di Dino Boscarato. Nel 1970 fu finalista al Premio Firenze con Ted Hughes e Paul Celan, tradusse il Nietzsche di Georges Bataille e pubblicò con l’editore Vanni Scheiwiller un volumetto di quattordici liriche come omaggio agli amici intitolato A che valse?(Versi 1938-1942), fuori commercio e a tiratura limitata. Si appassionò in questo periodo alla lettura di Le geste et la parole dell’etnologo e paleontologo francese André Leroi-Gourhan che gli diede modo di riflettere sul linguaggio e l’espressione umana. Nella primavera del 1973 intraprese, con Augusto Murer, un viaggio in Romania, dove alcune sue poesie erano già state tradotte, ma fu costretto a rientrare in patria per l’aggravarsi delle condizioni di salute della madre. Zanzotto rientrò da Bucarest, attraverso l’Ungheria e la Jugoslavia, in treno per timore dell’aereo, che non utilizzò mai come mezzo di trasporto. Pochi giorni dopo il suo rientro la madre morì, lasciandolo enormemente addolorato. Ripreso comunque il suo lavoro di scrittore tradusse La letteratura e il male di Georges Bataille per l’editore Rizzoli e, sempre nel 1973, pubblicò un nuovo volume di versi, intitolato Pasque. Esce nello stesso anno anche l’antologia Poesie (1938-1972) negli Oscar Mondadori, a cura di Stefano Agosti. Nel 1974 il n. 8-9 di Studi novecenteschi, dal titolo Dedicato a Zanzotto, raccoglieva gli interventi di numerosi poeti e studiosi sulla sua opera tra i quali Armando Balduino, Fernando Bandini, Amedeo Giacomini, Luigi Milone e Gino Tellini. Nel 1975 e nel 1976 il poeta partecipò ai corsi estivi dell’Università di Urbino tenendo numerose conferenze e brevi seminari sulla letteratura contemporanea. Strinse in questo periodo amicizia con il romanziere Wolfgang Hildesheimer, interprete durante i processi di Norimberga e intensificò la collaborazione con il Corriere della sera scrivendo recensioni su Leonardo Sinisgalli, Enrico Solmi, Ronald Laing, Alexandros Panagulis. Uscì in questo periodo un’antologia poetica in lingua inglese, “Selected Poetry of Andrea Zanzotto”, per le edizioni dell’Università di Princeton nel New Jersey alla quale si interessarono sia Cesare Segre che Sergio Perosa e venne pubblicata da Garzanti la traduzione di La ricerca dell’assoluto di Honoré de Balzac. Nel corso dell’anno iniziò la stesura dei sonetti che comporranno la sezione Ipersonetto di Il Galateo in Bosco. L’incontro con Fellini e il poemetto "Filò" Nell’estate del '76 il poeta, per la segnalazione di Nico Naldini, iniziò a collaborare al Casanova di Fellini, da lui incontrato per la prima volta nel 1970 alla presentazione del film I clowns. Nello stesso anno viene pubblicata l’opera Filò dalle edizioni Ruzzante di Venezia che comprende la lettera di Fellini, dove dichiara le sue aspettative, i versi per il film Casanova, quelli sul dialetto e una lunga nota, oltre a cinque disegni di Fellini e alla trascrizione in italiano delle parti in dialetto dello studioso veneziano Tiziano Rizzo. Venne pubblicata in questo periodo anche la traduzione dal francese di Studi di sociologia dell’arte di Pierre Francastel per la casa editrice Rizzoli che poco tempo prima lo aveva invitato a partecipare ad un comitato di lettura al quale parteciparono anche Claudio Magris, Carlo Bo, Giacinto Spagnoletti e Giorgio Caproni. Nel 1977 tradusse dal francese Il medico di campagna di Honoré de Balzac che venne pubblicato da Garzanti e nel medesimo anno vinse il Premio internazionale Etna-Taormina per la sua produzione letteraria. Il galateo in bosco e il Premio Viareggio Nel dicembre 1978, viene pubblicato nella collana Lo Specchio, di Mondadori Il Galateo in Bosco con prefazione di Gianfranco Contini. Nell’introduzione Contini lo definisce “pur difficile affabile poeta” un che scava con le mani le profondità sotterranee del suo bosco. Il Galateo in Bosco costituisce il primo volume di una trilogia che riceverà il Premio Viareggio nel 1979. Ancora per Fellini, “Fosfeni” e il Premio Librex Montale Nel 1980 scrisse alcuni dialoghi e stralci di sceneggiatura del film La città delle donne di Fellini, che incontrò più volte in Veneto con la moglie Giulietta Masina, che sarebbe divenuta la madrina del Premio Comisso di Treviso. Nello stesso anno, in marzo, il poeta partecipò, presso le scuole secondarie di Parma, ad alcune significative testimonianze alle quali contribuiscono anche Attilio Bertolucci, Vittorio Sereni, Giuseppe Conte e Maurizio Cucchi le cui testimonianze verranno pubblicate nel 1981 dalla casa editrice Pratica con il titolo Sulla poesia. Conversazioni nelle scuole. Venne intanto pubblicata presso una piccola casa editrice di Teramo la trascrizione di una storia popolare per bambini, “La storia dello zio Tonto”. Mostrando interesse per la poesia giapponese dello haiku provò dei tentativi di scrittura di questo genere. Nel 1982, il 9 marzo, gli verrà attribuita la laurea ad honorem dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e continuerà la collaborazione per incisioni e cartelle insieme ad artisti di orientamenti diversi, come Armando Pizzinato, Guido Guidi, Antonio Zancanaro, Giuseppe Zigania, Augusto Murer e poi anche Emilio Vedova. Nel 1983 scrisse per il film di Fellini E la nave va i Cori che verranno pubblicati nello stesso anno da Longanesi insieme alla sceneggiatura e uscì Fosfeni, secondo libro della trilogia, con il quale ottenne il Premio Librex Montale. La depressione In questo periodo si acuì l’insonnia di cui soffriva da tempo, tanto da costringerlo a farsi ricoverare. Continuò a tenere un diario sul quale annotare gli avvenimenti in modo sistematico, quasi una terapia per la sua nevrosi. Nella primavera-estate 1984, i mesi più scuri della depressione, iniziò a scrivere in modo sistematico una serie di (pseudo) haiku in inglese, che sottotitolò For a season. Zanzotto nel corso del tempo tradusse poi egli stesso in italiano gli haiku originariamente scritti in inglese, in quel che alla fine divenne un esperimento di poesia bilingue. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna gli haiku in inglese e italiano sono stati pubblicati nel 2012 in Haiku for a season (The University of Chicago Press, a cura di Anna Secco e Patrick Barron), l’ultimo volume di versi licenziato dal poeta. Nella tarda primavera dell’84, segno di un miglioramento, compì un viaggio a Parigi per recarsi ad una serata in suo onore al Théâtre de Chaillot. “Idioma” e il Premio Feltrinelli Nel 1986 uscì, presso Mondadori, il terzo volume della trilogia intitolato Idioma e la casa editrice Arcane 17 di Nantes stampò la traduzione francese della trilogia “Le Galaté au Bois”. Il 1987 fu l’anno della completa riabilitazione fisica. Il n. 37-38 della rivista L’immaginazione fu dedicato al poeta con numerosi interventi di nomi famosi, tra i quali, Fortini, Prete, Rigoni Stern e in primavera uscì il primo numero della rivista Vocativo in gran parte dedicato a Zanzotto. Nello stesso anno ricevette il premio Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei. La prima traduzione della sua opera Nell’estate del 1988 si recò a Berlino per un incontro internazionale di poesia e nel 1990 uscì, tradotta in lingua tedesca, una nuova selezione delle sue poesie con il titolo Lorna, Kleinod der Hügel (Lorna, gemma delle colline) e la raccolta Racconti e prose. I volumi contenenti gli interventi critici Nel 1991 uscì presso Mondadori il primo volume degli interventi critici del poeta usciti su riviste e giornali a partire dai primi anni cinquanta con il titolo di Fantasie e avvicinamento. Il 1992 fu l’anno dei congressi e delle celebrazioni con numerose richieste di intervento su giornali e riviste. Nel 1993 Zanzotto si recò a Münster, in Germania, per ricevere il premio per la poesia europea e nel 1994 uscì, sempre presso Mondadori, la seconda raccolta di scritti critici con il titolo Aure e disincanti nel Novecento. Apparve intanto nella sezione europea della collezione “opere rappresentative” dell’Unesco la traduzione in francese di un’antologia con la sua opera poetica, Du Paysage à l’Idiome, a cura di Philippe Di Meo e il poeta venne festeggiato al Beaubourg di Parigi. Sempre in questo periodo verrà composta da Mirco De Stefani un’opera musicale sul testo di Il Galateo in Bosco, incisa poi su compact disc, che si eseguirà a Treviso. Le altre due parti della trilogia, Fosfeni e Idioma, verranno interpretate, sempre in chiave musicale, nel 1995 la prima e nel 1997 la seconda che verrà eseguita a Venezia presso la Fondazione Cini. Le sue ultime opere: da Meteo a Conglomerati Nel 1995 l’Università di Trento gli attribuì la laurea honoris causa. Nel 1996, dieci anni dopo la pubblicazione di Idioma, venne pubblicato dalla casa editrice Donzelli Poesia un piccolo volume intitolato Meteo con venti disegni di Giosetta Fioroni e una Nota finale in cui il poeta scrive: Nel 1996 va via di testa per una minorenne presentatagli da un amico: per lei, che poco lo corrisponde preferendogli l’amico, compone versi inequivocabili e pudicamente inediti. Nel 2000 ricevette il Premio Bagutta per le Poesie e prose scelte e, il 6 ottobre, la laurea honoris causa in lettere dall’Università di Torino. Del 2001 è il libro composito intitolato Sovrimpressioni, che si concentra intorno al tema della distruzione del paesaggio. L’anno successivo ricevette il premio “Dino Campana”. Su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia, l’Università di Bologna gli concesse la laurea ad honorem l’8 marzo 2004.Scrisse anche alcune storie per bambini in lingua veneta, come La storia dello Zio Tonto, libera elaborazione dal folclore trevigiano e La storia del Barba Zhucon con immagini di Marco Nereo Rotelli che ha avuto la seconda ristampa nel gennaio del 2004. Il 3 aprile 2005 vide le stampe un nuovo libro dello scrittore dal titolo Colloqui con Nino nel quale Zanzotto, con l’aiuto della moglie Marisa, mise insieme un magnifico florilegio che vuol essere esplorazione antropologica, ricerca sentimentale e viaggio nel passato. Il 26 maggio 2008 riceve il premio “IIC Lifetime Achievement Award” «per una vita dedicata alla poesia».In questi anni – dopo avergli riservato numerose pagine saggistiche (tra cui un corposo studio di Al tràgol jért. L’erta strada da strascino apparso su «Il Belli» già nel 1992) e affettive come la postuma Outcasts (Prosa poetica su Cecchinel) – ha in più occasioni designato quale «erede» poetico suo e della grande tradizione del Novecento veneto Luciano Cecchinel, poeta ammirato anche da Cesare Segre come «grande artista, ma anche grande artefice». Nel 2008 Zanzotto è protagonista di un dialogo dal taglio intimista col coetaneo poeta e regista Nelo Risi, da cui è nato il film Possibili rapporti. Due poeti, due voci. Nel febbraio 2009 uscì In questo progresso scorsoio: una conversazione col giornalista coneglianese Marzio Breda, nella quale Zanzotto esprime l’angoscia delle riflessioni sul tempo presente e il suo lucido pensiero di ottantasettenne. Nello stesso anno, in occasione del suo ottantottesimo compleanno, il poeta pubblica Conglomerati, la nuova raccolta poetica di scritti composti tra il 2000 e il 2009, edita nella collana Lo Specchio della Mondadori; in questo libro Zanzotto si confronta ancora con una realtà in continuo mutamento culturale e antropologico, secondo la poetica dell’intervista con Breda. Per il suo novantesimo compleanno (con molti festeggiamenti, dalla Regione Veneto all’Università Cattolica di Milano) sono usciti molti libri, tra cui due con inediti: Ascoltando dal prato. Divagazioni e ricordi, a cura di Giovanna Ioli da Interlinea e il numero 46 della rivista “Autografo” dal titolo I novanta di Zanzotto. Studi, incontri, lettere, immagini. Il poeta muore la mattina del 18 ottobre 2011 presso l’ospedale di Conegliano a causa di complicazioni respiratorie, una settimana dopo aver compiuto 90 anni. Il funerale è stato celebrato il 21 ottobre al duomo di Pieve di Soligo da monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto; dopo la celebrazione gli hanno reso omaggio tre orazioni del giornalista Marzio Breda e dei critici Stefano Dal Bianco (con una laudatio funebre) e Stefano Agosti. Eventi dedicati ad Andrea Zanzotto La Regione del Veneto e CINIT– Cineforum Italiano presentano “Omaggio ad Andrea Zanzotto” un ciclo di appuntamenti curati da Neda Furlan e dedicati al grande poeta veneto. Tra gli eventi della rassegna: Ritratti. Andrea Zanzotto, di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini. Convegno “Omaggio ad Andrea Zanzotto”, 25-26 ottobre 2012, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Convegno “Andrea Zanzotto, la natura, l’idioma”, 10-12 ottobre 2014, Pieve di Soligo. Convegno "Nel «melograno di lingue», Plurilinguismo e traduzione in Andrea Zanzotto", novembre 2014, Nancy. = Maggio 2007 = La rivista bimestrale di letteratura “l’immaginazione” diretta da Anna Grazia D’Oria ha dedicato il n. 230 interamente ad Andrea Zanzotto. Il fascicolo monografico raccoglie i seguenti testi: La poetica La poetica di Andrea Zanzotto si può ricostruire attraverso la lettura delle sue opere che segnano le tappe di un percorso espressivo praticato all’interno dell’esperienza di una poesia difficile e tuttora in fieri, esulante dai classici protocolli interpretativi e dalla normale divisione in periodi. Come dice il critico Stefano Agosti, nel saggio introduttivo all’opera complessiva delle Poesie di Andrea Zanzotto avvenuta in prima edizione nel settembre del 1999 e in seconda edizione nel 2003 da parte di Mondadori ne “I Meridiani”: il punto non si può fare proprio perché l’oggetto– nelle sue configurazioni cronologicamente più prossime, ed esemplificabili perciò in Meteo (1996) e negli specimini di un nuovo volume tuttora in fieri, qui presentati sotto la titolazione provvisoria e generica di Inediti, sembra volto ad attestare una nuova posizione dell’operatore nei riguardi di quella che, molto comprensivamente e tuttora centralmente, possiamo denominare la sua esperienza di linguaggio. La formazione La formazione di Zanzotto non è facile da individuare perché diversa rispetto alle correnti e ai gruppi che hanno caratterizzato il nostro Novecento. La sua vera scuola furono soprattutto le numerose, intense e disparate letture: da Hölderlin a Rimbaud, da Lorca a Éluard, da Ungaretti ai surrealisti e agli ermetici, per non dimenticare Virgilio ed Orazio, Dante e Petrarca, Molière e Leopardi, Carducci e D’Annunzio, Husserl e la logica matematica. Nel libro-intervista di Marzio Breda, Zanzotto indica come letture fondamentali, negli anni della guerra, Sereni e Rilke, precisamente “Frontiera” del primo e i “Sonetti ad Orfeo” del secondo, nella versione di Giaime Pintor. Egli poi assorbì una infinità di elementi: dall’economia ai mass media, dalla sociologia alla fantascienza, dalla semiologia alla psicanalisi (più Lacan che Freud) e il tutto rimescolato a volte in un linguaggio disteso e piano e altre volte crittografico. Poesia anticorrente Quando furono pubblicati i suoi primi libri (Dietro il paesaggio nel 1951; Vocativo nel 1957), Andrea Zanzotto venne accolto come il più prestigioso della sua generazione e considerato il continuatore della linea ungarettiano-ermetica e inoltre con qualche eco raccolta dal surrealismo francese e dalla poesia spagnola degli anni venti e trenta. Una poesia dunque fortemente anticorrente. Ma in seguito, con gli sviluppi che ebbe la sua produzione, pur confermando la forte propensione verso la piena forma lirica e la dolcezza elegiaca, si è resa insufficiente la precedente collocazione. Poesia della nuova avanguardia Con le IX Egloghe (1962) il suo discorso si modifica e si allarga sia a livello psicologico (viene introdotto un io autobiografico pieno di ansie e interrogativi sul proprio rapporto con la realtà), sia a livello della forma, con un totale ripensamento dei propri mezzi comunicativi. Il linguaggio si sviluppa seguendo procedimenti parzialmente simili al sogno e all’inconscio. Ed è in questo periodo che la poesia di Zanzotto rivela affinità con le esperienze contemporanee della neoavanguardia. La ricerca poetica degli anni sessanta Una ulteriore svolta e accelerazione della poesia di Zanzotto avviene con l’opera La beltà, (1968) dove ogni cosa appare abbandonata a sé stessa e galleggiante in una non-atmosfera. Se nelle IX Egloghe il poeta era ancora dentro al suo paesaggio, ora i suoi oggetti (alberi, fiumi, gregge, luna, neve) sono, se pur presenti, appiattiti e immobili. Il suo linguaggio diventa rarefatto, un ammasso di puri fonemi, balbettii, petèl (il primo linguaggio dei bambini, linguaggio che si ferma ad uno stadio di semincoscienza). Questa rarefazione è dovuta ad un passaggio fondamentale nel percorso poetico di Zanzotto, quello ad una ricerca di conoscenza poetica che non si indirizza più sulla realtà esterna (sul paesaggio) come referente misterioso ma positivo e salvifico in quanto familiare. Davanti alla distruzione dell’autenticità di questa realtà da parte della civiltà dei consumi la ricerca di conoscenza e salvezza per il soggetto si sposta sulla lingua stessa, una lingua ormai irrelata, ma alla quale soltanto il poeta può fare appello, poiché la realtà ormai si riduce ad essa. La posizione più avanzata Sottoelencando alcune tappe intermedie come il monologo-lascito in lingua veneta di Filò (1976), nell’affrontare i testi che documentano la posizione più avanzata di Zanzotto si osserva nella trilogia composta da Il galateo in bosco (1978), Fosfeni (1983) e Idioma (1986) la completa lacerazione fra la natura e la storia e pertanto anche la fine dell’elegia e dell’idillio, tra il paesaggio e il retro del paesaggio. La catastrofe è descritta in tre momenti: nel Galateo vengono analizzati gli eventi esterni (dal “grande macello” della guerra '15-'18 sino alla discontinuità della tradizione metrica), in Fosfeni viene “vissuta” nella lingua e nel linguaggio, in Idioma è raccontata attraverso le testimonianze sulle conseguenze psicologiche e di costume. La funzione del linguaggio La struttura poetica di Zanzotto è basata sulle scelte lessicali, sull’innovazione e deformazione ma soprattutto sulla costruzione del discorso. La sua poesia è prevalentemente autobiografica e cosparsa di profonde riflessioni filosofiche-esistenziali. Il lessico utilizza sia la lingua infantile, sia gli inserti poliglotti creando in molti casi difficoltà di lettura e di decifrazione che generano a volte vera e propria incomunicabilità. La lingua, secondo Zanzotto, è incapace di render conto dei gradi del vissuto, pertanto il poeta deve trovare una linea che divida la coscienza dall’incoscienza. Da qui nasce il tentativo di trovare un’autentica ed originaria dimensione, sia del dire che dell’essere, partendo da un “massiccio patrimonio linguistico” in uno stato di “regressione afasica”. Avviene così che l’opposizione tra afasia e verbalizzazione venga rappresentata o dal vociferare babelico o, ad un altro estremo, dal silenzio. Zanzotto, come scrive in un bel saggio Franco Fortini, non usa strutture metriche codificate, se non quando vuole esibirsi stilisticamente. Più che altro le sue sono pastiche di carattere formale dove prevale il gusto dell’esercizio tecnico. Onorificenze e riconoscimenti Opere In volume * Luoghi e paesaggi, a cura di M. Giancotti, Milano, Bompiani, 2013. Traduzioni a cura di Andrea Zanzotto * Georges Bataille, La letteratura e il male, Milano, Rizzoli, 1973; Milano, SE, 1987 * Georges Bataille, Su Nietzsche, Bologna, Cappelli, 1980; Milano, SE, 1994 Traduzioni straniere delle opere di Andrea Zanzotto * Selected Poetry and Prose of Andrea Zanzotto, edited and translated by Patrick Barron et. al., University of Chicago Press, Chicago (Illinois) 2007 * Selected Poetry of Andrea Zanzotto, edited and translated by Ruth Feldman-Brian Swann, Princeton University Press, Princeton (New Jersey) 1975 * Le Galaté au Bois, traduit de l’italien par Philippe Di Meo, Arcane 17 ("L’Hippogrife"), Nantes, 1986 * Lichtbrechung, mit einem Kommentar von Stefano Agosti, Übersetzung Donatella Capaldi, Ludwig Paulmichi, Peter Waterhouse, Verlag Droschl, Wien-Graz 1987 * Lorna, Kleinod der Hügel. “Lorna, gemma delle colline”, übersetzt und herausgegeben von Helga Böhmer und Gio Batta Bucciol, mit Zeichnungen von Hans Joachim Madaus, Narr ("Italienische Bibliothek, 4"), Tübingen 1990 * Poems by Andrea Zanzotto, Translated from the Italian by Antony Barnett, A-B, Lewes (Canada) 1993 Du Paysage à l’idiome. Anthologie poétique 1951-1986, édition bilingue– edizione bilingue, traduction de l’italien et présentation par Philippe Di Meo, Maurice Nadeau– Unesco ("Collection Unesco d’œuvres représentatives. Série européenne"), 1994 (in quarta copertina passo antologico di Pier Paolo Pasolini) * La Veillée pour le Casanova de Fellini, avec une lettre et quatre dessins de Federico Fellini, Texte français et posface de Philippe Di Meo, Éditions Comp’Act (Collection “Le bois des mots”), Chambéry 1994 Del Paisaje al Idioma. Antología poética, con un “Autorretrato” del autor, seleccion y prólogo de Ernesto Hernández Busto, Universítad Iberoamericana– Artes de México ("Colectión Poesía y Poética"), Colonia Lomas de Santa Fe– Colonia Roma 1996 * Peasant’s Wake for Fellini’s “Casanova” and Other Poems, Edited and Translated by John P. Welle and Ruth Feldman, Drawings by Federico Fellini and Augusto Murer, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 1997 * Hääl ja tema vari. La voce e la sua ombra, Itaalia keelest tõlkinud Maarja Kangro. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2005. Bibliografia della critica Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Zanzotto


Franco Buffoni (Gallarate, 3 marzo 1948) è un poeta, traduttore e accademico italiano. Biografia Dal 1989 è direttore della rivista sulla teoria e pratica della traduzione poetica «Testo a fronte» e dal 1991 è curatore dei Quaderni italiani di poesia contemporanea, pubblicati ogni due anni. È stato professore ordinario di Letteratura anglo-americana e Letterature Comparate presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie, saggi e romanzi. Le sue opere sono state incluse in varie antologie di poesia italiana contemporanea. Ha tradotto tra gli altri John Keats, Donald Barthelme, Robert Fergusson, George Gordon Byron, Samuel Taylor Coleridge, Rudyard Kipling, Oscar Wilde, Séamus Heaney e William Butler Yeats. Già vincitore in passato di una edizione, dal 2010 presiede la giuria del premio letterario Giuseppe Tirinnanzi. A partire dagli anni Duemila si è impegnato attivamente per i diritti civili LGBT. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Buffoni