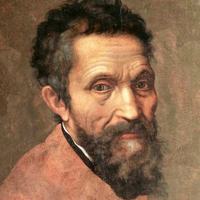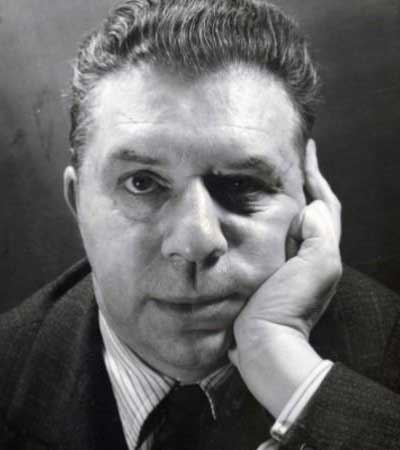


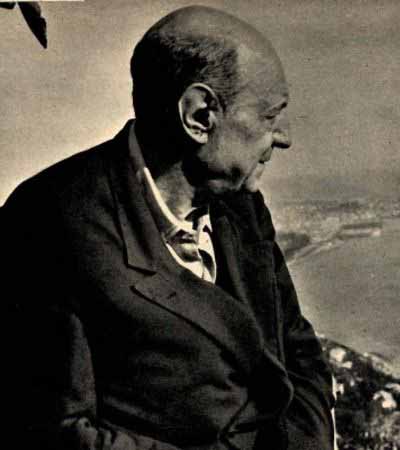

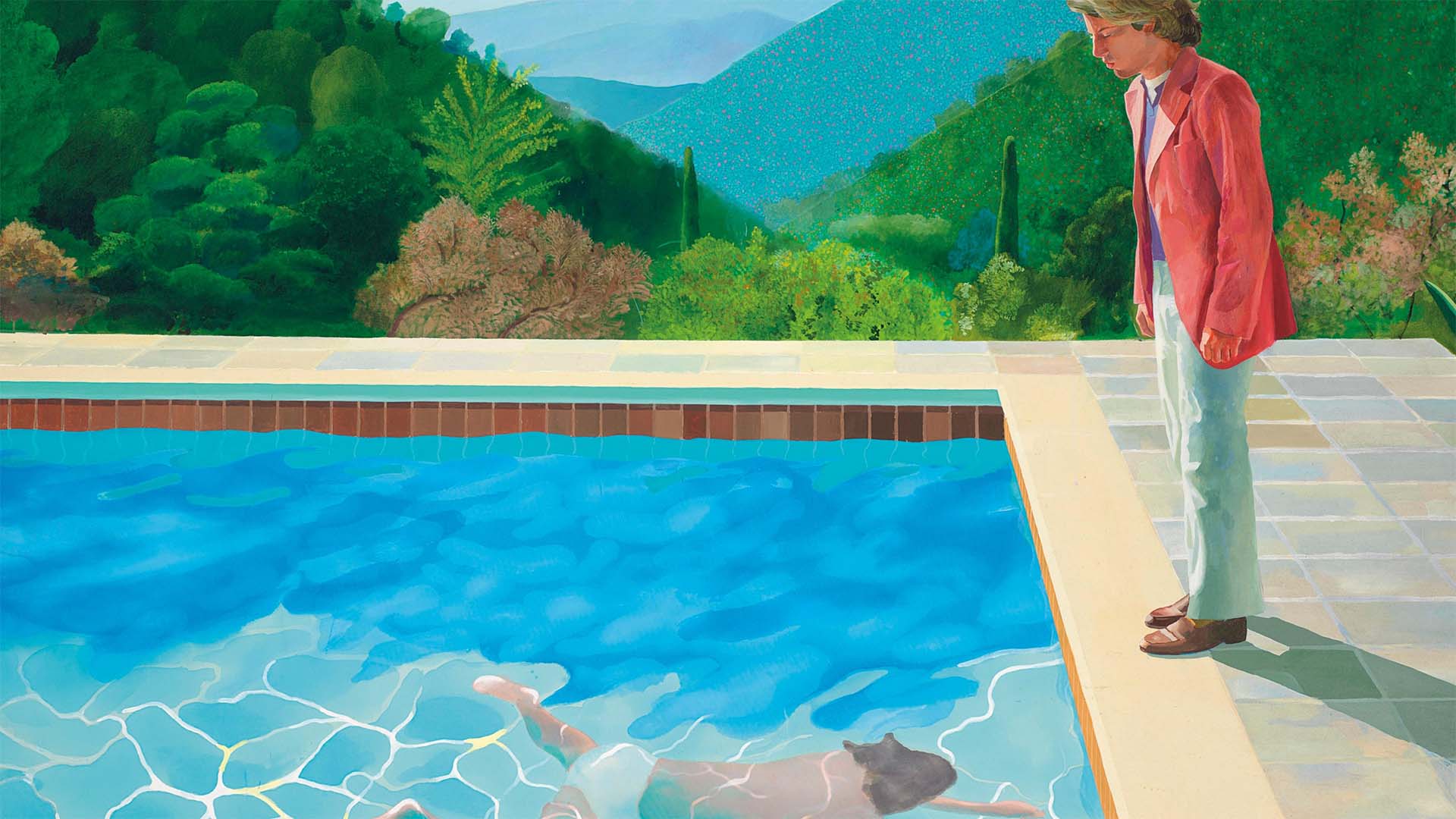
Crea belle pagine per il tuo profilo e le tue poesie, ognuno con la propria foto di copertina.
Condividi la tua poesia su Facebook, X e ovunque.
Appartenere a una comunità di scrittori. Interagisci con i tuoi colleghi poeti attraverso commenti o messaggi privati..
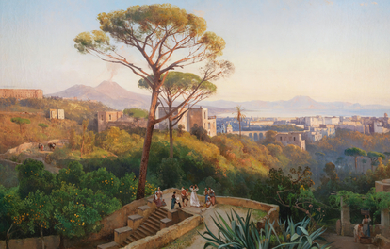

Il conte Giacomo Leopardi (al battesimo Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi; Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837) è stato un poeta, filosofo, scrittore, filologo e glottologo italiano. È ritenuto il maggior poeta dell’Ottocento italiano e una delle più importanti figure della letteratura mondiale, nonché una delle principali del romanticismo letterario; la profondità della sua riflessione sull’esistenza e sulla condizione umana – di ispirazione sensista e materialista – ne fa anche un filosofo di spessore. La straordinaria qualità lirica della sua poesia lo ha reso un protagonista centrale nel panorama letterario e culturale europeo e internazionale, con ricadute che vanno molto oltre la sua epoca. «Questo io conosco e sento, Che degli eterni giri, Che dell'esser mio frale, Qualche bene o contento Avrà fors'altri; a me la vita è male»
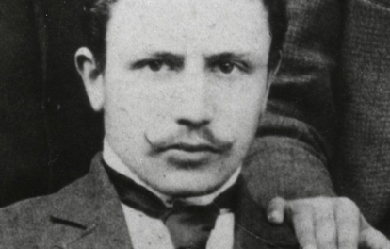
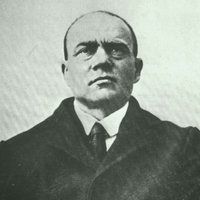
Dino Carlo Giuseppe Campana (Marradi, 20 agosto 1885 – Scandicci, 1º marzo 1932) è stato un poeta italiano. Biografia Dino Campana nacque a Marradi, un piccolo paese tosco-romagnolo sito nella provincia di Firenze, il 20 agosto del 1885, figlio di Giovanni Campana, insegnante di scuola elementare, poi direttore didattico, descritto come un uomo per bene ma di carattere debole e remissivo, e di Francesca Luti, detta Fanny, una donna severa e compulsiva, affetta da mania deambulatoria e fervente credente cattolica. La madre era attaccata in modo morboso al figlio Manlio, più giovane di due anni di Dino. Trascorre l’infanzia in modo apparentemente sereno nel paese natìo, ma intorno all’età dei quindici anni gli vengono diagnosticati i primi disturbi nervosi, che – nonostante tutto – non gli impediranno comunque di frequentare i vari cicli di scuola. Frequenta le elementari a Marradi, poi frequenta la terza, quarta e quinta ginnasio presso il collegio dei Salesiani di Faenza. Intraprende gli studi liceali dapprima presso il Liceo Torricelli della stessa città, ed in seguito a Carmagnola (in provincia di Torino), presso il regio liceo Baldessano, dove consegue la maturità nel luglio del 1903. Quando rientra a Marradi, le crisi nervose si acutizzano, come pure i frequenti sbalzi di umore, sintomi dei difficili rapporti con la famiglia (soprattutto con la madre) ed il paese natío. Per ovviare alla monotonia delle serate marradesi, specie nella stagione invernale, Dino era solito recarsi a Gerbarola, una località poco distante dal borgo, dove con gli abitanti del luogo trascorreva qualche ora mangiando le caldarroste (la castagna è infatti il frutto tipico di Marradi), comunemente appellate con il nome di bruciati. Questo tipo di svago sembrava avere effetti positivi sui suoi disturbi psichici. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, Dino, all’età di diciotto anni, si iscrive, nell’autunno del 1903, presso l’Università di Bologna, al corso di laurea in Chimica pura, e nel gennaio dell’anno successivo entra far parte della scuola per gli ufficiali di complemento di Ravenna. Non riesce, però a superare l’esame per diventare sergente, e viene quindi prosciolto dal servizio ed in seguito congedato. Nel 1905 passa alla Facoltà di Chimica farmaceutica presso l’Università di Firenze, ma dopo pochi mesi il suo trasferimento in Toscana, Campana decide di trasferirsi nuovamente a Bologna. Il poeta espresse il suo “male oscuro” con un irrefrenabile bisogno di fuggire e dedicarsi ad una vita errabonda: la prima reazione della famiglia, del paese e successivamente anche dell’autorità pubblica, fu quella di considerare le stranezze di Campana come segni lampanti della sua pazzia. Ad ogni sua fuga, che si realizzava con viaggi in paesi stranieri, dove si dedicava ai mestieri più disparati per sostentarsi, seguiva, da parte della polizia (in conformità con il sistema psichiatrico del tempo, così come per le incertezze dei familiari) il ricovero in manicomio. Inoltre, veniva visto con sospetto per i tratti somatici che venivano giudicati “germanici” e per l’impeto con cui discuteva di poesia e filosofia. Internato per la prima volta nel manicomio di Imola (in provincia di Bologna), nel settembre del 1905, ne tenta una fuga già tra il maggio ed il luglio del 1906, per raggiungere la Svizzera e da lì la Francia. Verrà arrestato a Bardonecchia (in provincia di Torino) e di nuovo ricoverato ad Imola. Ne uscirà nel 1907, per l’interessamento della famiglia a cui viene affidato. Risale intorno al 1907 un suo viaggio in Argentina, presso una famiglia di lontani parenti emigrati, caldeggiato dagli stessi genitori per liberarlo dal tanto odiato paese natìo, e probabilmente perché il conflitto con la madre si era fatto ormai insanabile. Con molta certezza, Dino Campana accetta di partire per lasciarsi soprattutto alle spalle l’esperienza del manicomio, e perché si sentiva attratto per la nuova meta. Il viaggio in Sudamerica rappresenta comunque un punto particolarmente oscuro della biografia del poeta marradese: se alcuni infatti arrivarono a chiamarlo come “il poeta dei due mondi”, c’è anche chi, come per esempio Ungaretti, sostiene invece che in Argentina Campana non ci andò neppure. Regna una certa confusione anche sulle varie versioni intorno alla datazione e alle modalità del viaggio e sul tragitto del ritorno. Tra le varie ipotesi, quella più accreditata vede la sua partenza nell’autunno del 1907 da Genova, ed abbia vagabondato per l’Argentina fino alla primavera del 1909, quando ricompare a Marradi, dove viene arrestato. Dopo un breve internamento al San Salvi di Firenze, riparte per un viaggio in Belgio, ma viene nuovamente arrestato a Bruxelles, venendo quindi internato presso la maison de santé di Tournay all’inizio del 1910. A questo punto, si rivolge in cerca di aiuto alla famiglia e viene rimandato in Italia, a Marradi: vive un periodo più tranquillo; tra il 1912 ed il 1913, infatti, si immatricola per la seconda volta presso l’ateneo bolognese, ma soltanto dopo due mesi, chiede il trasferimento per Genova. Durante il soggiorno universitario nel capoluogo emiliano ha però modo di frequentare i gruppi di goliardi, con i quali riesce a stringere dei solidi rapporti d’amicizia, e degli appassionati di letteratura della sua età. Proprio sui fogli pubblicati dai goliardi bolognesi, infatti, escono le sue prime prove poetiche, alcune delle quali verranno in seguito incluse nell’opera maggiore di Campana, i Canti Orfici. I Canti Orfici Nel 1913 Campana si reca a Firenze, presentandosi alla redazione della rivista Lacerba di Giovanni Papini e Ardengo Soffici, suo lontano parente, a cui consegna il suo manoscritto dal titolo Il più lungo giorno. Non viene però preso in considerazione ed il manoscritto va ben presto perduto (sarà ritrovato solamente sessant’anni dopo, nel 1971, dopo la morte di Soffici, tra le sue carte nella casa di Poggio a Caiano, probabilmente nello stesso posto in cui era stato riposto e subito dimenticato).Dopo qualche mese di attesa irrisposta, Campana scende da Marradi a Firenze per riprendersi il manoscritto. Papini non lo possiede più e lo indirizza da Soffici, che però sostiene di non esserne mai entrato in possesso. Il giovane, la cui mente è già labile, si arrabbia e si dispera, poiché aveva consegnato, ingenuamente, l’unica copia esistente dell’opera. Scrive ed implora insistentemente senza altro risultato che il disprezzo e l’indifferenza di tutto l’ambiente culturale che gravita intorno alle “Giubbe Rosse”. Infine, esasperato, minaccia di venire con il coltello per farsi giustizia dell’"infame" Soffici e dei suoi soci, che definisce “sciacalli”. A proposito del dissidio tra Campana e l’ambiente letterario fiorentino si leggano le parole che Campana scrisse a Papini in una lettera del maggio del 1913: "(...) E se di arte non capite più niente cavatevi da quel focolaio di càncheri che è Firenze e venite qua a Genova: e se siete un uomo d’azione la vita ve lo dirà e se siete artista il mare ve lo dirà. Ma se voi avete un qualsiasi bisogno di creazione non sentite che monta attorno a voi l’energia primordiale di cui inossare i vostri fantasmi? Accademia della Crusca. Accademia dei Lincei. Accademia del mantellaccio: sì, voi siete l’accademia del Mantellaccio; con questo nome ora vi dico in confidenza, io vi chiamo se non rispettate di più l’arte. Mandate via quella redazione che a me sembrano tutti cialtroni. Essi sono ignari del «numero che governa i bei pensieri». La vostra speranza sia fondare l’alta coltura italiana. Fondarla sul violento groviglio delle forze nelle città elettriche sul groviglio delle selvagge anime del popolo, del vero popolo, non di una massa di lecchini, finocchi, camerieri, cantastorie, saltimbanchi, giornalisti e filosofi come siete a Firenze. Sapete, essendo voi filosofo sono in diritto di dire tutto: del resto vi sarete accorto che sono un’intelligenza superiore alla media. Per finire, il vostro giornale è monotono, molto monotono: l’immancabile Palazzeschi, il fatale Soffici: come novità: Le cose che fanno la Primavera. In verità vi dico tutte queste cose non fanno la Primavera ma l’inverno. Ma scrivete un po’ a Marinetti che è un ingegno superiore, scrivetegli che vi mandi qualche cosa di buono: e finitela colla critica” Nell’inverno del 1914, persa ormai ogni speranza di recuperare il manoscritto, Campana decide di riscrivere tutto affidandosi alla memoria e alle sue sparse bozze; in pochi mesi, lavorando anche di notte ed a costo di un enorme sforzo mentale, riesce a riscrivere il libro, con numerose modifiche ed aggiunte. Nella primavera dello stesso anno, Campana riesce finalmente a pubblicare, a proprie spese, la raccolta con il nuovo titolo, appunto, di Canti Orfici, in riferimento alla figura mitologica di Orfeo, il primo dei “poeti-musicisti”. Nel 1915 una recensione ai Canti da parte di Renato Fondi, sul Fanfulla della domenica, gli restituisce "il senso della realtà": trascorre quindi l’anno viaggiando senza una meta fissa tra Torino, Domodossola, ancora Firenze. Scoppia la Grande Guerra: Campana viene esonerato dal servizio militare, ufficialmente per problemi di salute fisica, in realtà perché segnalato ormai come malato psichiatrico grave. Nel 1916 ricerca inutilmente un impiego. Scrive a Emilio Cecchi (che sarà, insieme a Giovanni Boine —che comprese da subito l’importanza di Campana, recensendo i Canti Orfici nel 1914 su Plausi e Botte– e a Giuseppe De Robertis, uno dei suoi pochi estimatori) ed inizia con lo scrittore una breve corrispondenza. A Livorno si scontra con il giornalista Athos Gastone Banti, che scrive su di lui un articolo denigratorio sul quotidiano Il Telegrafo: si arriva quasi al duello.Nello stesso anno conosce la scrittrice Sibilla Aleramo, autrice del romanzo Una donna, con la quale instaura un’intensa quanto tumultuosa relazione, che si interromperà all’inizio del 1917, a seguito di un breve incontro nel Natale del 1916, a Marradi. Esistono testimonianze della relazione avvenuta tra Dino e Sibilla nel carteggio pubblicato da Feltrinelli nel 2000: Un viaggio chiamato amore– Lettere 1916-1918. Il carteggio ha inizio con una lettera della Aleramo, datata 10 giugno 1916, nella quale l’autrice esprime la sua ammirazione per i Canti Orfici, dichiarando di esserne stata “incantata e abbagliata insieme”. Sibilla era allora in vacanza nella Villa La Topaia a Borgo San Lorenzo, mentre Campana era in una stazione climatica presso Firenzuola per rimettersi in salute dopo essere stato colpito da una leggera paresi al lato destro del corpo. Ultimi anni e morte Nel 1918, Campana viene internato presso l’ospedale psichiatrico di Villa di Castelpulci, nei pressi di Scandicci (in provincia di Firenze). Lo psichiatra Carlo Pariani lo va a trovare per intervistarlo e conferma l’inappellabile diagnosi: ebefrenia, una forma estremamente grave ed incurabile di psicosi schizofrenica; tuttavia il poeta sembra essere a suo agio nel manicomio, vivendo una vita tranquilla e, finalmente, sedentaria.Dino Campana muore in ospedale, sembra per una forma di setticemia, causata dal ferimento con un filo spinato nella zona dello scroto, durante un tentativo di fuga, il 1º marzo del 1932. Il 2 marzo, la salma di Campana viene inumata nel cimitero di San Colombano, a Badia a Settimo, nel territorio di Scandicci, ma nel 1942, su diretto interessamento di Piero Bargellini, viene data alle spoglie del poeta una sepoltura più dignitosa e la salma trova riposo nella cappella sottostante il campanile della chiesa di San Salvatore. Durante la seconda guerra mondiale, il 4 agosto del 1944, i tedeschi, in ritirata, fanno saltare con una carica esplosiva il campanile, distruggendo nel contempo anche la cappella. Nel 1946 le ossa del poeta, in seguito ad una cerimonia alla quale partecipano numerosi intellettuali dell’epoca, tra i quali Eugenio Montale, Alfonso Gatto, Carlo Bo, Ottone Rosai, Pratolini ed altri, vengono collocate all’interno della chiesa di San Salvatore a Badia a Settimo, raggiungendo così la loro dimora attuale. La poetica La poesia di Campana è una poesia nuova nella quale si amalgamano i suoni, i colori e la musica in potenti bagliori. Il verso è indefinito, l’articolazione espressiva in un certo senso monotona ma nel contempo ricca di immagini molto forti di annientamento e purezza. Il titolo allude agli inni orfici, genere letterario attestato nell’antica Grecia tra il II e il III secolo d.C. e caratterizzato da una diversa teogonia rispetto a quella classica. Inoltre le preghiere agli dei (in particolare al dio Protogono) sono caratterizzate dagli scongiuri dal male e dalle sciagure. I temi fondamentali Uno dei temi maggiori di Campana, che si trova già all’inizio dei “Canti Orfici” nelle prime parti in prosa– La notte e Il viaggio e il ritorno– è quello dell’oscurità tra il sogno e la veglia. Gli aggettivi e gli avverbi ritornano con una ripetitiva insistenza come di chi detta durante un sogno, sogno però interrotto da forti trasalimenti (si veda la poesia “l’invetriata”, mirabile spleen baudelairiano). Nella seconda parte– nel notturno di “Genova”, ritornano tutti i miti fondamentali che saranno del Campana successivo: le città portuali, la matrona barbarica, le enormi prostitute, le pianure ventose, la schiava adolescente. Già nella prosa si nota l’uso dell’iterazione, l’uso drammatico dei superlativi, l’effetto d’eco nelle preposizioni, il ricorrere alle parole chiave che creano una forte scenografia. Del Serra ha esaminato le figure ricorrenti in Campana: anastrofi, adnominationes, tmesi anacolutiche e chiasmiche, catacresi, anastrofe con aprosdoketon. L’interpretazione della poesia Nel quindicennio che va dalla sua morte alla fine della seconda guerra mondiale (1932-1945) ed anche in seguito, nel periodo dell’espressionismo e del futurismo, l’interpretazione della poesia di Campana si focalizza sullo spessore della parola apparentemente incontrollata, nascosta in una zona psichica di allucinazione e di rovina. Nei suoi versi, dove vi sono elementi deboli di controllo e di approssimativa scrittura, si avverte – a parere di molti critici – il vitalismo delle avanguardie del primo decennio del XX secolo; dai suoi versi, per la verità, hanno attinto poeti molto differenti tra di loro, come Mario Luzi, Pier Paolo Pasolini, Andrea Zanzotto. Campana e Rimbaud Il destino di Campana è stato avvicinato a quello di Rimbaud. Ma, secondo alcuni, tra Campana e il poeta maledetto il punto di contatto (il bisogno di fuggire, l’idea del viaggio, l’abbandono di un mondo civile estraneo) è affrontato in modo molto diverso. Dove Rimbaud abbandona la letteratura per fuggire in Africa e prestarsi a mestieri avventurosi ed alternativi, come il trafficante d’armi, Campana alla fine dei suoi viaggi, senza una vera meta, trova solamente la follia. E se Rimbaud aveva fatto una scelta, Campana non scelse ma fu sopraffatto dagli eventi che attraversarono la sua vita diventandone una vittima: senza però mai disertare la poesia, come, differentemente, aveva fatto il poeta francese. Campana, fino al suo internamento a Castel Pulci, lotterà per la sua poesia e per una vita che non era mai riuscita a donargli nulla in termini di serenità e pace; e anche la strada dell’amore, il suo incontro con Sibilla Aleramo, si trasformerà in una sconfitta. Come scrive Carlo Bo nel saggio “La nuova poesia: Storia della letteratura italiana– il Novecento” (Garzanti, 2001): Eugenio Montale fu tra i primi estimatori ufficiali, il più autorevole ad oggi, delle composizioni di Dino Campana, tanto da dedicargli una poesia o meglio un omaggio a chi meglio di lui aveva saputo piegare le parole fino a renderle ancora più oscure. Sebbene i canti di Dino Campana affondino ben oltre il simbolismo francese, direttamente nelle radici della nostra terra toscana, Campana guarda al Trecento dantesco, al Cavalcanti al Dante della commedia fino ad arrivare ai canti del Foscolo (Giacomo Leopardi ancora non era stato molto diffuso), ed è toccante l’allusione dantesca con cui Eugenio Montale chiude questa struggente lirica di stampo prettamente biografico (di Dino Campana si evitava di citare per motivi piccoli borghesi la sua vita e i suoi amori travagliati nonché il suo pacifismo antinterventista) e proprio per questo ancor più provocatoria: “fino a quando riverso a terra cadde!”. Dino Campana e l’arte La critica ha spesso indagato e continua ad interrogarsi su quanto vi è di figurativo nell’opera del poeta di Marradi, conosciuto dall’immaginario come il poeta folle e visionario. Nel 1937 Gianfranco Contini scriveva «Campana non è un veggente o un visionario: è un visivo, che è quasi la cosa inversa». Nei Canti Orfici sussistono infatti elementi sia visivi che visionari con numerosi riferimenti alla pittura. Analizzando la funzione che questi aspetti hanno all’interno dell’opera si nota con evidenza come al lato visionario, con riferimento a Leonardo, a De Chirico e all’arte toscana, sia affiancato in perfetta coesione quello visivo che trova le sue allusioni nel futurismo. Pasolini, che aveva riletto con molta attenzione l’opera di Campana, aveva scritto «Particolarmente precisa era la sua cultura pittorica: gli apporti nella sua lingua del gusto cubista e di quello del futurismo figurativo sono impeccabili. Alcune sue brevi poesie-nature morte sono tra le più riuscite e se sono alla "manière de" lo sono con un gusto critico di alta qualità». A proposito poi delle conoscenze leonardesche dell’autore si può leggere, in una lettera del 12 maggio 1914 scritta da Campana a Soffici da Ginevra «Ho trovato alcuni studi, purtroppo tedeschi, di psicoanalisi sessuale di Segantini, Leonardo e altri (in particolare “Sesso e carattere” di Otto Weininger) che contengono cose in Italia inaudite: potrei fargliene un riassunto per Lacerba». La critica Dopo la pubblicazione dei “Canti Orfici” inizia subito la critica con tre articoli che, se pur differenti, danno origine al mito Campana: sulla rivista “La Voce” appare, verso la fine del 1914, l’articolo di Giuseppe De Robertis, sulla “Tribuna” quello di Emilio Cecchi e sulla “Riviera Ligure” quello di Giovanni Boine entrambi del 1915. Il ritrovamento del manoscritto de Il più lungo giorno tra le carte di Soffici fu annunciato sul Corriere della Sera del 17 giugno 1971 da Mario Luzi e ha consentito nuove forme di indagini sul complesso degli scritti campaniani. Citazioni e dediche a Dino Campana CinemaA Dino Campana sono stati dedicati quattro film: Dino Campana, 1974, regia di Marco Moretti Inganni, 1985, regia di Luigi Faccini Il più lungo giorno, 1997, regia di Roberto Riviello Un viaggio chiamato amore, 2002, regia di Michele Placido. La Scomparsa, 2016, regia di Maria Luisa CarrettoRomanziAl viaggio di Dino Campana in Uruguay e in Argentina è dedicato il romanzo di Laura Pariani Questo viaggio chiamavamo amore (Einaudi 2015).PoesiaAlla storia di amore fra Campana a la Aleramo è dedicata la poesia Sibilla del poeta Riccardo Savini, inclusa nella raccolta Nero oro ero (2010). Alla relazione tra Dino Campana e Sibilla Aleramo è dedicata la poesia di Daniele Miglio Dino e Sibilla pubblicata nella raccolta intitolata proprio Dino e Sibilla uscita nel 2011 per Edizioni il Papavero. Nell’opera vi sono più riferimenti alla poetica e al pensiero del Campana.TeatroAlla vicenda di Campana sono stati dedicati la pièce teatrale Quasi un uomo dello scrittore argentino Gabriel Cacho Millet (curatore anche dell’epistolario di Campana dal titolo Le mie lettere sono fatte per essere bruciate), la pièce teatrale “ Dino Campana poeta ” (testo di Andrea Manzi) per la regia di Lorenzo Cicero che debuttò a Marradi in occasione del primo centenario della nascita; il racconto di Antonio Tabucchi Vagabondaggio ne Il gioco del rovescio nell’edizione del 1988 e quattro film: il primo, “Dino Campana”, girato nel 1974 in formato S.8 dal giovane Marco Moretti (vincitore del Premio Nazionale "Dal S.8 al 35mm"), incentrato sulle connessioni tra vita e poesia; l’ultimo è quello di Michele Placido Un viaggio chiamato amore (2002), con Stefano Accorsi nei panni di Campana e Laura Morante in quelli di Sibilla Aleramo. A Dino Campana è stato dedicato lo spettacolo “Nottecampana” con Carlo Monni, Arlo Bigazzi, Orio Odori e Giampiero Bigazzi, da cui sono stati tratti il cd omonimo (2009, Materiali Sonori) e il libro “Nottecampana– Storie di Dino Campana o dell’urgenza della poesia” (2010, Editrice Zona). La vicenda biografica e poetica di Dino Campana viene narrata nella pièce teatrale "La più lunga ora, ricordi di Dino Campana, Poeta, Pazzo" scritta e diretta da Vinicio Marchioni, (2008) con Vinicio Marchioni, Milena Mancini, Ruben Rigillo.MusicaAlla vita di Campana è dedicata la canzone di Massimo Bubola dal titolo “Dino Campana” uscita nel 1997 all’interno del disco Mon trésor. Campana è citato nella Canzone per Alda Merini (1999) di Roberto Vecchioni. Il compositore italiano Lorenzo Signorini ha scritto due brani per voce recitante, arpa e percussioni ispirate ai Canti Orfici di Campana: Le Stelle le Pallide Notturne (2003) e La sera di fiera (2004). Il cantautore fiorentino Massimiliano Larocca ha musicato la poesia di Campana “La petite promenade du poete”, pubblicata nel suo album La breve estate del 2008. Nel 2016 Massimiliano Larocca pubblica il disco “Un mistero di sogni avverati”, nel quale compaiono 13 poesie di Dino Campana musicate integralmente dal cantautore fiorentino. All’album partecipano Riccardo Tesi, Nada, Sacri Cuori, Hugo Race e Cesare Basile “Da lontano un ubriaco canta amore alle persiane” è citato nel brano del 1998 “Ubriaco canta amore” della BandabardòCinemaI versi Fabbricare fabbricare fabbricare / preferisco il rumore del mare / che dice fabbricare fare e disfare hanno ispirato il titolo del film Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti. Nel 2016 è stato realizzato il cortometraggio “L’alluvione ha sommerso”. Il film breve racconta in modo originale la genesi dei Canti Orfici e si lega alla poesia “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili” di Eugenio Montale, in cui l’autore ricorda la tragica alluvione di Firenze del 1966 durante la quale, tra le tante cose, l’acqua del fiume Arno gli portò via anche una copia del volume campaniano. La regia del film, prodotto da Esecutivi per lo Spettacolo con il supporto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, di Luca Dal Canto, già autore di un cortometraggio tratto da una poesia di Giorgio Caproni ("Il cappotto di lana", 2012, 53 selezioni e 16 premi) e di un altro film breve ispirato alla figura di Amedeo Modigliani ("Due giorni d’estate", 2014, 29 selezioni e 5 premi). “L’alluvione ha sommerso” è stato scritto da Dino Castrovilli e Giuseppe Giachi. Dino Campana è interpretato dall’attore e performer turco Murat Onol. Opere di Campana Opera Canti Orfici, Tip. Ravagli, Marradi, 1914 Canti Orfici ed altre liriche. Opera completa, prefazione di B. Binazzi, Vallecchi, Firenze, 1928, pp. 166 Canti Orfici, a cura di Enrico Falqui, terza ed., Vallecchi, Firenze, 1941, pp. 210 Canti Orfici e altri scritti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1952, 1960, 1962 Canti Orfici e altri scritti, nota biografica a cura di E. Falqui, nota critica e commento di Silvio Ramat, Vallecchi, Firenze, 1966, pp. 362 Canti Orfici e altri scritti, a cura di Arrigo Bongiorno, introduzione di Carlo Bo, Mondadori, Milano, 1972, pp. 168 Opere e contributi, a cura di E. Falqui, prefazione di Mario Luzi, note di Domenico De Robertis e S. Ramat, 1972 Carteggio con Sibilla Aleramo, a cura di N. Gallo, Vallecchi, Firenze, 1973 Canti Orfici, introduzione e commento e Fiorenza Ceragioli, Vallecchi, Firenze, 1985, pp. 350 Canti Orfici e altre poesie, introduzione e note di N. Bonifazi, Garzanti, Milano, 1989 Canti Orfici, a cura di M. Lunetta, Newton Compton, Roma, 1989 Opere. Canti Orfici. Versi e scritti sparsi pubblicati in vita. Inediti, a cura di S. Vassalli e C. Fini, TEA, Milano, 1989 Canti Orfici, edizione critica a cura di G. Grillo, Vallecchi, Firenze, 1990 Canti Orfici, commento di M. Caronna, Rubbettino, Messina, 1993 Canti Orfici, a cura di R. Ridolfi, introduzione di P. L. Ladron de Guevara, Libreria Chiari, Firenze, 1994 (ristampa anastatica dell’edizione di Marradi, 1914) Canti Orfici, a cura di C. Bene, Bompiani, Milano, 1999 (con Compact disc) ISBN 88-452-4072-X Canti Orfici e altre poesie, a cura di Renato Martinoni, Einaudi, Torino, 2003 Canti Orfici, edizione anastatica a cura di Fabio Barricalla e Andrea Lanzola, con un apocrifo di Marco Ercolani, una nota di Veronica Pesce e un 'plauso’ di Giovanni Boine, Matisklo edizioni, Savona, 2016 Altro Inediti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1942 Taccuino, a cura di Matacotta, Edizioni Amici della Poesia, Fermo, 1949 (poi in Taccuini, edizione critica e commento di F.Ceragioli, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1990) Taccuinetto faentino, a cura di D. De Robertis, Vallecchi, Firenze, 1960 Fascicolo marradese inedito del poeta dei “Canti Orfici”, a cura di F. Ravagli, Giunti-Bemporad Marzocco, Firenze, 1972 Il più lungo giorno. I. Riproduzione anastatica del manoscritto ritrovato dei Canti Orfici, II: Il testo critico, a cura di D. De Robertis, prefazione di E. Falqui, Archivi di Arte e Cultura Dell’Età Moderna– Vallecchi, Roma-Firenze, 1973 (Poi su CD-ROM: Vallecchi, Firenze, 2002 Epistolari D. Campana, Le mie lettere sono fatte per essere bruciate, G. S. All’insegna del pesce d’oro, Milano, 1978 Souvenir d’un pendu. Carteggio 1910-1931, a cura di G. Cacho Millet, Napoli, 1985 D. Campana– Sibilla Aleramo, Un viaggio chiamato amore, Feltrinelli, Milano, 2003 Dino Campana-Sibilla Aleramo, a cura di Bruna Conti, Feltrinelli, 2000. Da questo carteggio è stato tratto il film Un viaggio chiamato amore (di Michele Placido, 2002) con Stefano Accorsi nel ruolo di Campana e Laura Morante nel ruolo di Sibilla Aleramo. D. Campana, Un po’ del mio sangue– Canti Orfici, Poesie sparse, Canto proletario italo-francese, lettere (1910- 1931), a cura di S. Vassalli, BUR, Milano, 2005 D. Campana, Lettere di un povero diavolo, Carteggio (1903-1931) Con altre testimonianze epistolari su Dino Campana (1903-1998) a cura di Gabriel Cacho Millet. In copertina una foto inedita di Dino, Polistampa, 2011. Traduzioni Dino Campana. Cantos órficos/Canti orfici. Tradução de Gleiton Lentz. Desterro: Edições Nephelibata, 2004. Dino Campana. Chants orphiques. Traduction: Christophe Mileschi. Editeur: Éditions L’Âge d’Homme.février 1997. ISBN 2-8251-0849-9 Fumetti Dino Campana. A jornada de um neurastênico/La giornata di un nevrastenico. Fumetti di Aline Daka e traduzione di Gleiton Lentz. (n.t.) Revista Literária em Tradução, n. 7, set. 2013, pp. 337–348. ISSN 2177-5141 Simone Lucciola, Rocco Lombardi, Campana, contributi di G. Cacho Millet, P. Pianigiani, G. Neri, Guida, 2014, ISBN 978-88-97980-17-9 Pablo Echaurren, Vita disegnata di Dino Campana, Editori del Grifo, Montepulciano 1994. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Campana


Gabriele D’Annunzio, all’anagrafe Gabriele d’Annunz (io (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del Decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito del titolo di “principe di Montenevoso”.
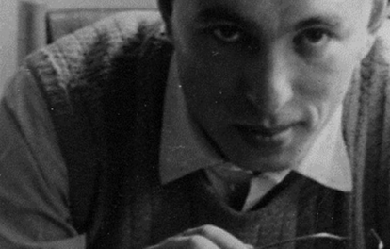
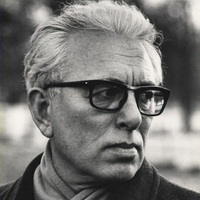
Franco Fortini, nato Franco Lattes (Firenze, 10 settembre 1917 – Milano, 28 novembre 1994), è stato un poeta, critico letterario, saggista e intellettuale italiano. Figura controversa, è annoverato da alcuni tra le personalità più interessanti del panorama culturale del Novecento. Biografia Franco Fortini nasce da Dino Lattes, avvocato livornese di origine ebraica, ed Emma Fortini del Giglio, cattolica non praticante. La fanciullezza I primi anni di vita di Fortini lasciarono nello scrittore ricordi dolorosi che riappariranno nei suoi scritti e nelle sue poesie. Il padre aveva partecipato come volontario alla guerra del '15-'18 e aveva sposato Emma l’anno precedente al rientro dal fronte di Asiago. In seguito si era iscritto al Partito repubblicano e aveva partecipato attivamente alla vita politica, ma il rifiuto ad iscriversi al Partito fascista gli aveva precluso la carriera professionale. Uomo colto, appassionato di musica, collaboratore di fogli satirici e del quotidiano fiorentino il “Fieramosca”, frequentava artisti e letterati e la sua biblioteca era ricca di testi eterogenei: Jahier, Lucini, Barbusse, la Commedia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo, I doveri dell’uomo di Mazzini. La madre era un’appassionata lettrice di romanzi che prendeva in prestito dalla Biblioteca Circolante del Gabinetto Vieusseux insieme ai libri per il figlio. Franco ricorda di aver letto, tra il 1924 e il 1926, nella casa dei cugini materni, Gli esempi di bello scrivere del Fornaciari, un’antologia scolastica tra le più diffuse dell’Ottocento, le poesie del Giusti, le Novelle della nonna che egli chiamerà la sua “letizia infantile”, Jules Verne, De Amicis e più tardi Pinocchio. Nonostante la diversa estrazione religiosa, i coniugi Lattes non erano praticanti e Franco crebbe in un ambiente laico. Della sua casa non riporta precisi ricordi, perché la famiglia Lattes cambia spesso abitazione, passando da pensioni ad appartamenti ammobiliati, subendo anche dei pignoramenti. La casa che ricorda è quella di via Rondinelli, vicino al Duomo, dalle cui finestre egli assiste al passaggio in auto di Mussolini. Nel periodo dell’infanzia, Franco assiste numerose volte ad episodi di violenza che gli rimangono impressi nella memoria, come il pestaggio a cui accennerà nella poesia Milano 1971 dopo le cariche della polizia alla Facoltà di Architettura di Milano: «Avevo cinque anni quando vidi i fascisti picchiare / uno che non aveva salutato la bandiera». Nel luglio del 1925 nasce la sorella Valeria e nello stesso anno il padre viene arrestato con l’accusa di aver collaborato con il gruppo “Non mollare” di Salvemini e dei fratelli Rosselli e da allora sarà sempre sospettato di attività contro il regime. Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre vi è una sanguinosa sparatoria innescata da fascisti vicino al mercato di San Lorenzo (descritta da Vasco Pratolini nel suo romanzo Cronache di poveri amanti): l’avvocato Console, che condivideva lo studio con il padre di Franco, viene ucciso insieme alla moglie. Dino Lattes riesce a fuggire e per quindici giorni la famiglia non saprà nulla di lui. La formazione scolastica e letteraria Nel 1926 Franco viene iscritto al ginnasio Galileo dove impara il francese da una zia di origine svizzero-francese di nome Binder. Risalgono al 1927 le letture dei Fratelli Karamazov, quella di Martin Eden e della Bibbia protestante, che il padre aveva portato a casa di ritorno da una Fiera del libro a Firenze. Franco ricorda che il romanzo di Jack London lo aveva appassionato al punto di condurlo ad identificarsi con l’umile personaggio, mentre il romanzo di Dostoevskij e la Bibbia costituiranno letture fondamentali, dal punto di vista morale e letterario, della sua formazione di scrittore. Tra i dodici e i tredici anni egli legge moltissimo e scrive intensamente riempiendo quaderni di prose e di versi, nel 1930 viene iscritto al Liceo Ginnasio Dante che frequenterà con buon profitto. Risale a questo periodo la scoperta della passione per la pittura e il disegno. Gli anni del Liceo Fra la seconda e la terza liceo, con i risparmi ottenuti dal guadagno delle lezioni private, è in grado di comprarsi molti libri che leggerà avidamente. Tra i contemporanei le letture che lo colpiscono maggiormente sono: Un uomo finito di Papini, Ragazzo di Jahier, Il mio Carso di Slataper e Foglie d’erba di Whitman che confesserà di aver letto, sottobanco, durante le lezioni di matematica. In questi anni il giovane Franco frequenta un gruppo di amici (Giorgio Spini, Giampiero Carrocci, Franco Calamandrei, Piero Santi, Alessandro Parronchi, Valentino Bucchi, Giancarlo Salimbeni, Geno Pampaloni e altri), con i quali potrà discutere di arte, di teatro e di musica. Costoro hanno in comune la passione per il cinema francese, soprattutto per Duvivier e René Clair tanto da assumere come parola d’ordine quelle della canzone La liberté c’est toute l’existence cantata nel film À nous la liberté. Gli anni universitari: 1935-1940 Nel 1935 viene selezionato per la sessione di Arte ai Littoriali di Roma dove ha occasione di rivedere, in piazza della Sapienza, Mussolini e di conoscere Cassola, con il quale condividerà la passione per il Dedalus e Gente di Dublino di Joyce. Nello stesso anno consegue la maturità e per volontà paterna viene iscritto alla facoltà di giurisprudenza ma frequenterà anche Lettere, sostenendo gli esami complementari che gli verranno riconosciuti in seguito per la seconda laurea. Nel 1936 diventa assiduo frequentatore della Biblioteca Marucelliana dove trascorre i pomeriggi liberi dalle lezioni a studiare e a leggere. Escono in questo periodo i suoi primi testi, una prosa e una poesia: Colline colorate e Paesaggi su Anno XIII, e su Lo squillo un Riassunto della Quadriennale. Durante questo periodo la sua passione per l’arte e quella per la letteratura hanno il medesimo peso, tanto che lo stesso Fortini dirà: «...ho continuato fino a diciotto, diciannove anni a non sapere se la mia vocazione fosse quella del pittore piuttosto che quella dello scrittore». Pubblica in questo stesso anno una serie di prose e versi sulla Gazzetta quotidiano fascista della Calabria e della Sicilia e, visto in una cartoleria “Il giuoco del Barone”, variante del “Giuoco dell’oca”, decide con l’amico Valentino Bucchi di farne un libretto. Alessandro Parronchi scrive il testo e l’opera che verrà rappresentata al teatro sperimentale di via Laura nel 1939 segnando il debutto di Bucchi come musicista. Durante i giorni di festa Franco approfitta per scoprire, da solo o con gli amici dell’università tutti caratterizzati da ideologie antifasciste, le opere d’arte di varie città: Ferrara, Venezia, le città dell’Umbria e i centri minori della Toscana. Nel 1937 viene selezionato ai pre-littoriali di Firenze per il convegno di arti figurative di Napoli e avrà modo di incontrare Attilio Momigliano, suo futuro professore di Letteratura italiana. Durante i Littoriali di Napoli, prese parte al dibattito sull’arte e l’architettura con una decisa posizione contro il nazionalismo e l’arte della "romanità", suscitando motivo di scandalo. In questo periodo continua a scrivere sui fogli giovanili fascisti, come Il Bò e Goliardia Fascista", ma collabora anche alla rivista cattolica Gioventù Cristiana. L’amicizia con Giorgio Spini, valdese, lo mette in contatto con l’ambiente protestante fiorentino. Risale a questo periodo la lettura di Kierkegaard, Barth e Cromwell. Si dedica anche alla lettura de La Metamorfosi di Kafka, che nel 1990 tradurrà egli stesso, e dei romanzi di Döblin, Mann, Lawrence e Huxley. Nel 1938 mentre si trova a Forte dei Marmi insieme agli amici Bucchi e Carrocci gli giunge la notizia della morte di D’Annunzio e improvvisa dei versi di commemorazione piuttosto irriverenti nei confronti del poeta. Si consolida intanto l’amicizia con Giacomo Noventa che aveva fondato a Firenze nel 1936 La Riforma Letteraria, rivista fortemente polemica contro la cultura italiana del tempo. In questo periodo Fortini collabora ad essa, come pure alla rivista Letteratura diretta da Alessandro Bonsanti, con poesie, racconti e articoli critici. Dopo aver partecipato ai Littoriali del Gruppo Universitario Fascista (GUF), questa volta anche per la letteratura, parte per Palermo dove, come era già successo a Napoli, il Convegno prenderà una piega sgradita alle autorità fasciste che dovranno intervenire per sedare il tumulto creato dai suoi interventi e da quelli di Antonello Trombadori, Alberto Graziani e Bruno Zevi. I littoriali palermitani, malgrado le polemiche suscitate, segneranno per Franco una svolta decisiva. L’incontro con coetanei che non aveva mai conosciuto prima, ma ai quali si sente accomunato dalla vocazione antifascista e dalla maturazione intellettuale, lo aiuteranno a schiarirsi le idee: «Avevo ventuno anni e le cose mi si chiarirono una volta per tutte». Il soggiorno in Sicilia gli ispira un racconto, scritto al ritorno dall’isola, dal titolo La morte del cherubino di stucco, pubblicato da La Ruota nel 1941 come omaggio allo scultore siciliano Giacomo Serpotta. Rientrato a Firenze riesce ad evitare, con un certificato medico, di essere arruolato nella “milizia universitaria” che, in vista della imminente visita di Hitler, voleva giovani per assolvere a compiti di ordine pubblico. Legge in questo periodo Resurrezione e Anna Karenina di Tolstoj e a casa di un’amica ebrea finlandese assiste ad una esibizione di Montale. A dicembre una circolare del Ministero dell’educazione nazionale sulla dispensa dal servizio del “personale di razza ebraica” esonera dall’insegnamento Momigliano, al quale Franco aveva chiesto la tesi. Al Momigliano, nella cattedra di letteratura italiana, subentra Giuseppe De Robertis con il quale Fortini entra subito in contrasto. Nel 1939 l’espulsione dal GUF a causa delle leggi razziali rende più acuta la sua crisi religiosa tanto che, per sua consapevole scelta, vorrà ricevere il battesimo per diventare valdese. Continua intanto a dipingere e a pubblicare sulla Riforma versi e racconti, scrive varie tesine, segue con qualche interesse le lezioni di Giorgio La Pira e nello stesso anno si laurea in legge, con una tesi in filosofia del diritto su “Lo spirito antimachiavellico della Riforma nell’opera di don Valeriano Castiglione”, ottenendo come punteggio: 100/110. Nel 1940 ottiene un incarico di supplente in un Istituto Tecnico di Porto Civitanova nelle Marche e ritornato a Firenze darà lezioni private riprendendo a frequentare i corsi della Facoltà di Lettere. A Mario Solmi chiede la tesi in storia dell’arte su Rosso Fiorentino e per vedere le opere del Rosso e dei manieristi visiterà la Toscana progettando di continuare, dopo la laurea, le ricerche in Francia. Nello stesso anno il padre viene arrestato come “ebreo pericoloso” e condotto alle Murate ed egli si recherà con la madre a trovarlo con una certa frequenza. Il 25 giugno ottiene la laurea in Lettere ma deve subito sostituire il padre, che nel frattempo era stato trasferito ad Urbisaglia in un campo di ebrei internati, nello studio legale. Il mese successivo scrive al capo della polizia chiedendo indulgenza per il padre. Ad agosto l’internamento sarà revocato ma Dino non potrà, se non clandestinamente, svolgere la sua attività professionale. Per evitare il servizio militare Franco si iscrive ad un corso di perfezionamento in storia della lingua italiana e su indicazione di Luigi Russo e Bruno Migliorini lavora ad un progetto per una edizione di Galeazzo di Tarsia. Aveva letto in questo periodo gli scrittori del Cinquecento e tra i romanzi contemporanei era rimasto colpito da Conservatorio di Santa Teresa di Romano Bilenchi che recensirà sulla rivista Ansedonia firmandosi per la prima volta Fortini. Dal 1941 al 1945: il periodo bellico La chiamata alle armi, che era giunta nel luglio del 1941, viene accolta da Franco come una liberazione perché entrare nell’esercito voleva dire uscire dall’insopportabile situazione determinata dalle leggi razziali e rientrare nella normalità. Nell’estate del 1941 viene richiamato alle armi e assegnato come soldato semplice alla caserma romana di viale delle Milizie dove rimane per tre mesi e ha modo, durante le libere uscite, di entrare in contatto con i gruppi antifascisti. In seguito viene trasferito a Civita Castellana, dove conosce Pietro Ingrao, con il grado di sergente ad un corso per sottufficiali e vi rimane per tutto l’inverno tra il '41 e il '42. In seguito viene inviato a Spoleto per tre mesi ad un corso di allievi ufficiali e infine vicino a Sanremo con il compito di sostenere psicologicamente i soldati, reclute del 1923. Viene intanto pubblicata la sua prima traduzione dal francese dalle Edizioni di Leggere d’oggi, la rivista che continuava Ansedonia, di Un cuore semplice di Flaubert. A novembre si trova a Genova pochi giorni dopo il bombardamento navale inglese e scrive in questa occasione i versi Italia 1942 che saranno in seguito raccolti in Foglio di via. Trasferito all’inizio del '43 a Costigliole Saluzzo, in Piemonte, è tra coloro che sono incaricati di accogliere i reduci dalla Russia. Viene trasferito a Casino di Terra presso Cecina e verso il 20 luglio si trova in licenza a Firenze per un concorso a cattedra nella scuola media. Il 27 partecipa ad una riunione del Partito d’Azione che gli affida dei manifestini da diffondere a Pisa durante il viaggio di rientro al reggimento. Parte con il suo battaglione e nelle settimane precedenti all’armistizio si trova a Milano come sottotenente di fanteria e qui ritrova l’amico Ingrao disertore da un anno e in clandestinità. All’indomani dei primi bombardamenti di agosto conosce Elio Vittorini con il quale era stato in corrispondenza per una traduzione da Voltaire. Il 21 agosto, recandosi a Roma per partecipare ad un concorso per l’insegnamento e di passaggio per Firenze, ha modo di rivedere i familiari. Rientrato a Milano l’8 settembre riceve da un attendente la notizia dell’armistizio. Rifugiatosi in Svizzera, dopo un tentativo fallito di armare i soldati della propria caserma contro i tedeschi, passa alla resistenza e partecipa alla Repubblica Partigiana dell’Ossola, prendendo parte alla ritirata e alla fine di quella repubblica, esperienze fondamentali per la sua formazione di uomo e di scrittore. Raggiunta Lugano, Franco sarà condotto a Bellinzona, sede del comando territoriale della Polizia dell’esercito e di alcuni campi di raccolta dei profughi, dove rimane fino al 18 settembre. Classificato come profugo “civile” perché ebreo ma anche “politico” per le sue idee, viene messo in quarantena al campo di Adliswil, nel cantone di Zurigo, uno dei più grandi della Svizzera tedesca. Il 23 viene autorizzato a lasciare il campo e destinato a Zurigo dove sarà ospite dei Fuhrmann e avrà l’obbligo di presentarsi una volta alla settimana alla polizia. Sarà questo uno dei più intensi periodi per la sua esperienza intellettuale e politica. Il suo garante, Alberto Fuhrmann studente in teologia e poi pastore valdese per riformati di lingua italiana, lo inserisce in un mondo che Fortini considererà sempre la sua seconda università. Nella casa di Alberto egli incontra pittori, musicisti, studenti universitari e intellettuali provenienti da tutta l’Europa e ritrova Adriano Olivetti che aveva conosciuto nel 1938 a Milano. Sono di questo periodo le molte letture e la composizione di quei versi che confluiranno in Fogli di via. Egli trascorre le giornate recandosi spesso all’università, frequentando il caffè "Sèlect", dove vengono proiettati film d’avanguardia e dove conosce Luigi Comencini. Al ristorante “International” incontra Diego Valeri, Ignazio Silone e giovani militanti del Partito d’Azione con i quali stringe amicizia. Nel 1944 a causa di una mancanza di prospettiva socialista all’interno del Partito d’Azione, si iscrive al PSIUP, che diventerà in seguito PSI ricevendo da Silone la tessera del partito che manterrà fino al 1958. Inizia a collaborare con il periodico della federazione socialista in Svizzera: L’Avvenire dei lavoratori. Tra i primi testi pubblicati sul periodico vi sono alcune poesie e articoli dedicati a Benedetto Croce e a Giovanni Gentile. Collabora in questo periodo anche alla Rivista della Svizzera italiana che sarà pubblicata a Locarno. Il giorno dello sbarco in Normandia, alla fine di giugno, si trova con Olivetti a Zurigo quando giunge l’ordine di raggiungere un campo di lavoro agricolo a Birmensdorf. Alla fine di agosto, Franco chiede di poter tornare a Zurigo e il permesso gli arriverà in ottobre da Berna. Giungono intanto sempre più numerose le notizie di oltre confine facendo aumentare tra gli esuli il desiderio di poter ritornare in Italia. All’inizio di ottobre egli decide di partire con altri amici e viene accompagnato alla stazione da Ruth Leiser che aveva conosciuto ad una festa di internati. Raggiunta Locarno da Lugano prosegue in auto per Camedo ma, fermato dalla polizia svizzera a Ponte Ribellasca, viene consegnato ai partigiani. Passato il confine il 9 ottobre a Domodossola viene subito assegnato all’ufficio stampa della giunta provvisoria di governo, dove incontra Gianfranco Contini, Giansiro Ferrata, Umberto Terracini, Mario Bonfantini. L’11 ottobre, alla notizia dell’avanzata dei tedeschi e della disfatta della repubblica partigiana, Franco parte in treno per Briga diretto in Svizzera e ad Iselle trascorre la notte in casa di un ferroviere. Al mattino riparte per Domodossola e dopo essersi presentato al comandante della brigata Matteotti, continua la fuga verso le montagne. Chiede intanto di unirsi ad un reparto che deve muovere contro i fascisti ma i partigiani, ritirandosi, fanno saltare i ponti lungo la valle. Franco è costretto a risalire la val Devero marciando nella neve alta e, arrivato in Svizzera, ritrova altri profughi della Valdossola. Rimane per un po’ di tempo nel campo di raccolta di Briga e poi a Pully e Tour Haldimand in un campo per ebrei ortodossi e in seguito in un carcere preventivo per detenuti comuni, al Bois Mermet di Losanna, sotto l’accusa da parte della polizia elvetica di non aver rispettato le procedure durante un’assenza dal campo. A Zurigo il 14 dicembre del 1944 viene rappresentato con successo il suo atto unico Il soldato. Dimesso da Losanna il 25 gennaio del '45 Franco è destinato a Spiez dove farà il lavapiatti in un albergo requisito. In questo periodo si dedica alla traduzione del Romeo e Giulietta al villaggio di Gottfried Keller. Ritornato a Zurigo per alcune licenze trova alloggio presso Regina Kägi-Fuchsmann che gli farà da garante. Riprende a collaborare con L’Avvenire dei lavoratori e a pubblicare sul periodico del Partito socialista ticinese Libera stampa diretto da Alberto Vigevani e Luigi Comencini e sulla rivista Arte, letteratura e lavoro. La notizia della liberazione lo coglie a Spiez il 25 aprile e finalmente l’11 maggio può tornare in patria. Il ritorno in patria Al ritorno in patria Fortini inizia subito a scrivere articoli che vengono pubblicati sull’Avanti! e alla fine di giugno decide di trasferirsi a Milano dove viene a sapere di aver vinto la cattedra nel concorso del 1943 ma, senza molti ripensamenti, decide di rinunciare all’insegnamento. La collaborazione alle riviste Per tutto il 1945 la collaborazione alle riviste l’Avanti!, La lettura e Italia libera, sarà intensa e il 1º agosto diventa redattore praticante di “Milano sera”, periodico curato dapprima da Bonfantini, poi da Vittorini e in seguito da Alfonso Gatto. Consegna in questo periodo a Vittorini il dattiloscritto Fogli di via che viene trasmesso da quest’ultimo all’Einaudi. Prepara intanto con Vittorini ed Albe Steiner Il Politecnico e corregge gli articoli dei collaboratori rivedendone le traduzioni. Dal 1946 al 1950: il suo esordio letterario Intramezzando il lavoro al Il Politecnico con la collaborazione alla Lettura, è ospite assiduo della Casa della Cultura e il 7 aprile 1946 si sposa con Ruth Leiser nel Municipio di Milano. Il suo primo libro di versi: Foglio di via Il 30 aprile dello stesso anno viene pubblicato, nella collana di poesia di Einaudi, il primo libro di versi, Foglio di via con un suo disegno in copertina e una dedica al padre. Il primo a recensire il libro sarà Italo Calvino sull’Unità. Trasformatosi “Il Politecnico” da settimanale a mensile Franco, pur continuando la collaborazione con esso, diventa anche collaboratore dell’Avanti!. Conosce intanto, nella sede dell’Einaudi romana, Cesare Pavese e nel luglio dello stesso anno ha occasione di conoscere e intervistare per il “Politecnico” Jean-Paul Sartre che si trovava a Milano con Simone de Beauvoir per una conferenza. Nei giorni seguenti Sartre e Fortini, a casa di Vittorini, lavoreranno alla stesura del programma di un numero dedicato all’Italia di Les Temps Modernes, la rivista fondata nel 1945 da Sartre. Essa uscirà nel 1947 con i contributi di Sergio Solmi, Giacomo Debenedetti, Vasco Pratolini, Alberto Moravia, Ignazio Silone e lo stesso Fortini. Si intensificano nel frattempo le letture e le traduzioni dalla letteratura straniera; Alfred Jarry, Guillaume Apollinaire, Pierre Reverdy, George Orwell, Stephen Spender, Antonio Machado, Federico García Lorca. Sulla “Gazzetta del Nord” di Noventa viene pubblicata in dicembre “Una conversazione in Valdossola” che costituirà la prima serie delle Sere in Valdossola del 1963. Non smette nel frattempo di tradurre (Ramuz per le Edizioni di Comunità e Éluard per Einaudi) e di collaborare alla rivista Omnibus con brevi articoli di costume, firmandosi con lo pseudonimo di “Minko”. Impiegato all’Olivetti Nell’agosto del 1947 intervista Thomas Mann che si trovava nella villa dei Mondadori sul lago Maggiore e l’intervista viene pubblicata sull’"Avanti!". Costretto dalle necessità economiche ad accettare l’offerta di Olivetti per un impiego negli uffici della pubblicità si trasferisce ad Ivrea e il 1º agosto viene assunto. Nel 1947 si chiude intanto l’esperienza del “Politecnico” sul quale Fortini aveva pubblicato oltre cinquanta testi tra articoli e poesie. Al gennaio del 1948 risale la recensione per l’"Avanti!" del libro di Ruggero Zangrandi, Il lungo viaggio, che farà nascere una forte polemica all’interno del partito. Insieme alla moglie Ruth traduce Timore e tremore di Kierkegaard e scrive nel frattempo il racconto Agonia di Natale che verrà pubblicato da Einaudi nella primavera dello stesso anno. Continua a dedicarsi alla prosa e scrive il racconto La cena delle ceneri che verrà pubblicato solamente nel 1988 e L’interdetto che rimarrà inedito. Il 14 luglio, in seguito dell’attentato a Togliatti, si era intanto creato ad Ivrea, tra gli operai, un clima di grande tensione ed egli è tra i sostenitori della rivolta. L’amico Adriano Olivetti lo comprende e, invece di licenziarlo, lo trasferisce nella sede di Milano alla pubblicità. Il lavoro all’Olivetti lo mette a contatto con i grafici, specialmente con Giovanni Pintori, ma anche con diversi poeti come Giovanni Giudici con i quali preparerà gli slogan per la pubblicità. Traduzioni, recensioni e viaggio in Germania Dopo la sconfitta delle sinistre del 1948 il clima politico era mutato profondamente ed era iniziato il periodo che Fortini chiamerà più tardi con il titolo del suo libro: “dei dieci inverni”. Risale alla fine di gennaio la recensione di Ladri di biciclette di Vittorio De Sica e la traduzione, in collaborazione con la moglie Ruth, di Alfred Döblin e André Gide che verrà pubblicata l’anno successivo dall’Einaudi. Viene intanto invitato da un ufficiale inglese a prendere contatto con un centro di rieducazione di giovani hitleriani presso Hannover e alla fine dell’estate si reca in Germania con Ruth. Tutti i resoconti del viaggio sono pubblicati sul “Nuovo corriere”, “Milano sera” e “Il mondo” e verranno raccolti l’anno successivo in "Comunità" con il titolo Diario tedesco pubblicato come libro dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1991. Convegni, saggi e viaggio a Londra Nel 1950 continua la collaborazione con l’"Avanti!" e nel frattempo diventa più intensa la sua attività di critico per "Comunità" dove, nella rubrica “Bibliografia letteraria”, recensisce le novità del momento. Si deve a questo periodo la lettura approfondita di Lukács. Interviene all’inizio di aprile al “Convegno del Movimento per la Riforma religiosa” che si tiene a Bergamo e il 16 giugno, in occasione del maggio musicale, vengono messi in musica i suoi versi tratti da “Foglio di via” da Valentino Bucchi. In occasione di una serata per Carlo Levi, che si tiene durante la settimana Einaudi, ritrova Pavese che aveva appena ricevuto il Premio Strega e scrive un commento ad un suo saggio intitolato Sul mito. Dopo il suicidio di Pavese, avvenuto poco dopo quell’incontro, Fortini scrive sull’"Avanti!" l’articolo Pavese si è ucciso. Risale a questo periodo un viaggio a Londra dove ha modo di conoscere Eliot. Il periodo dal 1951 al 1954: intensa attività di traduttore e di critico Si intensifica intanto l’attività di traduttore che diventerà prevalente negli anni tra la fine del 1940 a tutto il 1950. Molte le versioni dal tedesco compiute con la consulenza di Cesare Cases e in collaborazione con la moglie. Risalgono a questo periodo le traduzioni di Bertold Brecht, delle poesie di Villon, di Marcel Proust, di Simone Weil e Fortini sembra aver accantonato la poesia. Conosce in questo periodo un gruppo di giovani che alla letteratura preferivano l’economia e la filosofia e che avevano stampato in proprio una piccola rivista intitolata Discussioni. Questa rivista veniva data in distribuzione ad una cerchia di amici e conoscenti e tra gli argomenti che trattava vi erano quelli sul significato della guerra in Spagna, sull’uso della violenza, sulla politica dell’Unione Sovietica e sul pensiero di Gramsci. Nel 1951 invia a Montale una cinquantina di poesie per averne un giudizio e ne riceve un parere severo ma penetrante che Fortini definirà “tanto sconvolgente quanto deprimente”. Nel 1952 viene invitato da Calvino a collaborare al Notiziario Einaudi con una nota su Pavese. Continua a prestare saltuariamente consulenza editoriale per l’Einaudi analizzando L’uomo senza qualità di Musil e la biografia di Büchner a opera di Handis Mayer oltre a curare i testi teatrali di Brecht. Nel luglio dello stesso anno compie un altro viaggio a Londra con Ruth e, di passaggio a Parigi, assiste alla prima teatrale di En attendant Godot di Samuel Beckett. Muore il 18 novembre Paul Eluard e al necrologio che Montale fa sul Corriere della Sera, “La morte di Paul Eluard”, Fortini risponde con una lettera in cui esprime il suo disappunto per il taglio che Montale ha dato all’articolo, tacciandolo di "malignità civettuole e cattivo gusto". Continuando intanto le numerose recensioni su Comunità, la collaborazione con l’Avanti! e con il Notiziario Einaudi. In questo periodo pubblica su Botteghe Oscure Sere in Valdossola. Inizia nel 1953 la collaborazione a Nuovi Argomenti e su Botteghe oscure appaiono alcune poesie, di cui cinque sotto il titolo Versi per Ruth e una dal titolo Sestina per Firenze. Le poesie dedicate a Ruth vengono raccolte nello stesso anno in una plaquette fuori commercio dal titolo Sei poesie per Ruth e per me. Nel 1954 traduce per le Edizioni Comunità L’enraciment di Simone Weil e grazie a Vittorio Sereni pubblica nella edizione della Meridiana Una facile allegoria. Esce lo stesso anno da Einaudi Minima moralia di Adorno che accende all’interno del gruppo di “Discussione” appassionati dibattiti al quale Fortini partecipa attivamente. Nel marzo scrive su Nuovi Argomenti un articolo intitolato Appunti su “Comunismo e Occidente” e riceve “una misura disciplinare” dalla Federazione socialista milanese. In aprile ha inizio la sua collaborazione a Il contemporaneo sul quale tiene la rubrica “lettere francesi”. A giugno scrive su Lo spettatore d’oggi la recensione di Le degré zéro de l’écriture di Roland Barthes e alla fine di ottobre diventa consulente della collana dei Saggi dell’Einaudi. Il periodo dal 1955 al 1957: grande impegno politico Nel 1955 Fortini si dedica all’approfondimento del lavoro per Discussioni e Officina e si trova a contatto con Pasolini, Leonetti, Roversi e Romanò. Nello stesso anno l’ex gruppo di “Discussioni”, formato da Armanda Guiducci, Roberto Guiducci, Luigi Amodio, Stefania Caproglio, si riunisce per decidere di stampare “Ragionamenti” con l’intento di farne una rivista “di critica e di informazione sui maggiori temi del pensiero marxista contemporaneo, in una prospettiva antistalinista ma non riformista, e per una riunione nel ”blocco storico" delle sinistre “con l’intenzione di rivolgersi soprattutto agli intellettuali e ai quadri dei movimenti di sinistra”. La rivista, che avrà vita fino al 1957, esce con tiratura limitata e sostenuta finanziariamente solamente dai redattori e dagli abbonamenti e viene accolta con indifferenza dai socialisti e con ostilità dai comunisti, ad eccezione di Della Volpe. In marzo Pasolini scrive a Fortini una lettera con la quale lo invita a collaborare a Officina e in risposta Fortini gli invia quattro poesie e in seguito, su richiesta dello stesso Pasolini, aggiungerà un Allegato con il titolo L’altezza della situazione, o perché si scrivono poesie che appariranno sul fascicolo di settembre. A luglio si reca ad Helsinki come “osservatore” al “Congresso della pace” ed incontra letterati famosi tra i quali Nazım Hikmet che intervista per “Il contemporaneo”. Grazie ai contatti con Hikmet, che lo introduce ad Alexei Surkov, poeta, segretario dell’Unione degli Scrittori sovietici, Fortini si reca per la prima volta in Urss, per quindici giorni. A ottobre si reca in Cina in visita ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese con la prima delegazione italiana formata, tra gli altri, da Piero Calamandrei, Norberto Bobbio, Enrico Treccani e Cesare Musatti. Il viaggio durerà un mese e il diario della visita verrà pubblicato l’anno seguente in Asia Maggiore dedicato a Carlo Cassola suo compagno di viaggio che, a sua volta, gli dedicherà Viaggio in Cina. Di ritorno dalla Cina inizia a collaborare all’Enciclopedia A/Z della Zanichelli curandone diverse voci e affida a Sereni un fascicolo di circa ottanta poesie per vedere se c’è la possibilità di pubblicare una nuova raccolta. Traduce una vasta scelta di versi di Éluard con una ricca introduzione, pubblica la plaquette In una strada di Firenze e sul primo numero di Ragionamenti di settembre-ottobre scrive un saggio su Leo Spitzer dal titolo Critica stilistica e storia del linguaggio. Legge intanto gli scritti di Auerbach, Maurice Merleau-Ponty e Lucien Goldmann del quale tradurrà, nel 1961, “Le dieu caché”, continua a tradurre Brecht e scrive i versi A Boris Pasternak. Il 2 gennaio del 1956 scrive a Pasolini, che era stato accusato di "oscenità" per il romanzo Ragazzi di vita, offrendo la sua testimonianza di critico. Sempre nel mese di gennaio inizia il XX Congresso del Partito Comunista dell’Unione Sovietica e le notizie che pervengono creano forti emozioni:"Ricordo – egli scrive – che quando da non so quale oratore è stato fatto il nome di Antonov-Ovseenko, cioè della persona che aveva ricevuto nelle sue mani la capitolazione del governo provvisorio al momento della presa del Palazzo d’Inverno, e che poi era stato una delle vittime di Stalin, noi abbiamo capito (...) che qualcosa di straordinario stava avvenendo". In febbraio Fortini incontra Brecht a Milano in occasione della rappresentazione dell’Opera da tre soldi al Piccolo Teatro di Milano con la regia di Giorgio Strehler e a marzo viene aperta su “Il contemporaneo” un’inchiesta sulla cultura di sinistra che suscita una forte polemica coinvolgendo intellettuali e politici e nella quale egli interviene con un articolo intitolato I politici intellettuali. A settembre viene pubblicato in un supplemento di Ragionamenti il testo di Fortini e Guiducci, Proposte per una organizzazione della cultura marxista in Italia che riprende l’argomento rivelato dalla polemica e cioè la richiesta di “autonomia” degli uomini di cultura dalle direzioni culturali dei partiti, la loro auto-organizzazione all’interno del “blocco storico” delle sinistre e il loro controllo degli strumenti di espressione culturale. Il libro Asia Maggiore che esce in aprile viene recensito su “Rinascita” con una critica negativa e Fortini viene accusato di essere “nemico del popolo cinese”. Il dattiloscritto Dieci inverni, che consegna a Gianni Bosio gli verrà restituito senza nemmeno essere sfogliato. Fortini intanto ha dato le dimissioni dalla Casa della Cultura. La conoscenza e l’amicizia con Edgar Morin e Roland Barthes gli permettono di avviare, parallelamente a Ragionamenti e con una comune redazione, la rivista parigina Arguments. Il 19 ottobre del 1956 ha inizio la crisi polacca e il 23 dello stesso mese la rivolta a Budapest che viene seguita ora per ora dall’Unità. Il 31 dello stesso mese vi è l’intervento anglo-francese a Suez e il 4 novembre giunge la notizia dell’intervento sovietico. Risale a questo periodo la poesia 4 novembre 1956: "Il ramo secco bruciò in un attimo/Ma il ramo verde non vuol morire./Dunque era vera la verità./ Soldato russo, ragazzo ungherese,/ non v’ammazzate dentro di me./ Da quel giorno ho saputo chi siete:/e il nemico chi è". Tra la fine del 1956 e l’inizio del 1957 prosegue la collaborazione con Officina e l’intenso rapporto con Pasolini nell’ipotesi di un lavoro comune. Viene attaccato dal Contemporaneo per un intervento fatto su Mondo operaio dal titolo “Organizzazione della cultura. Interpretazioni della ”intellighentsia ungherese" e in seguito verrà più volte censurato dall’"Unità". Nell’aprile dello stesso anno recensisce sull’Avanti! Mythologies di Barthes e pubblica su Ragionamenti la traduzione della Poesia agli adulti di Adams Wazyk. Per l’editore Schwarz pubblica la traduzione di Idee e opinioni di Albert Einstein avvalendosi di Camillo Losurdo per la parte scientifica e un’edizione numerata di Sestina a Firenze con litografie di Ottone Rosai. Nell’ottobre raccoglie una selezione degli scritti di un decennio di attività legato alla vita culturale e politica del paese che vanno dal periodo 1947-1957 che saranno pubblicati da Feltrinelli con il titolo Dieci inverni. Contributo ad un discorso socialista. Sull’Avanti! esce il 10 dicembre una recensione dell’opera firmata da Luciano Della Mea nella quale Fortini viene accusato di aver compiuto un errore di fondo nel parlare di divisione, all’interno del socialismo scientifico, del potere tra la politica e la cultura e tra i politici e gli intellettuali.Roberto Guiducci interviene sullo stesso giornale in difesa del libro ma la recensione e il silenzio della dirigenza del Partito socialista fanno riflettere Fortini che decide di uscire dal PSI. Alla fine dell’anno restituirà la tessera del partito a Pietro Nenni. Il periodo dal 1957 al 1962: un periodo di riflessione Con la chiusura di Ragionamenti e l’interruzione alla collaborazione con l’Avanti!, ha inizio per Fortini un periodo di profonda riflessione che lo allontanerà dall’impegno militante e lo avvicinerà maggiormente a quello letterario. Scrive su Officina una serie di poesie e alcuni importanti saggi come quello sulla metrica e su Hugo Friedrich mentre “La situazione” e "Il Caffè" pubblicano alcuni suoi testi poetici. Insieme ad un gruppo di giovani musicisti torinesi, tra i quali Sergio Liberovici, Fausto Amodei, Emilio Jona e Michele Straniero, partecipa al rinnovamento della “canzonetta” e scrive testi per musica leggera tra i quali Tutti amori che viene musicata da Liberovici e che farà parte del repertorio del gruppo, nominatosi I Cantacronache, insieme alla versione di Fillette di Quenéau e Campane di Roma che, a causa della censura per i versi "lungo un divano/ del Vaticano/ seder vorrei/ con te, mio amor...", non sarà mai eseguita. Cura insieme a Libero Bigiaretti Olivetti 1908-1958, un volume che illustra i cinquant’anni dell’attività dell’Olivetti mentre nel lavoro di traduzione ha la prevalenza l’opera di Brecht del quale esce, nel 1958, la versione del “Romanzo da tre soldi” e l’anno seguente “Storie da calendario” e l’antologia “Poesie e canzoni” con una sua introduzione. Sempre nel '58 continua con fervore l’opera di traduttore e le sue letture abbracciano ambiti diversi. Traduce opere di György Lukács e di Adorno, i saggi di Edmund Wilson, quelli di Francis Otto Matthiessen e del suo “Rinascimento americano”, del quale Pavese aveva voluto la traduzione, e in seguito si dedica ai formalisti russi, a Lévi-Strauss e Saussure oltre ai saggi di carattere storico di Needham sulla Cina e di Deutscher su Trockij. Il secondo libro di versi: Poesia e errore Nel 1959 Giorgio Bassani, allora direttore della “Biblioteca di letteratura” di Feltrinelli lo consiglia nella strutturazione dell’antologia che raccoglie la sua produzione letteraria dal 1937 al 1957 e che uscirà con il titolo Poesia e errore da Feltrinelli; nel frattempo cura per Garzanti l’antologia Il movimento surrealista. Si guasta intanto il rapporto con Officina e Fortini, in una lunga lettera, si confiderà con l’amico Pasolini scrivendo: "C’è in me qualcosa che allontana la gente e mi impedisce l’amicizia. La cosa si ripete negli anni con tanta regolarità che non posso imputare gli altri. Ma riuscissi a capire cos’è ed a emendarmi". Il 31 maggio, dopo una correzione e un taglio senza essere avvisato di un suo articolo su Lukács, decide di lasciare Officina che con il numero del maggio-giugno chiuderà le pubblicazioni. Riprende la sua collaborazione all’Avanti! con una serie di riflessioni dal titolo Cronache della vita breve, scrive l’introduzione ad un’antologia di poesie di Mao Tse-Tung e, sempre nel 1959, assume la direzione della collana “Piccola Biblioteca Einaudi” dedicata alle opere scientifiche, storiche e sociologiche. Alla fine del gennaio del 1960 la canzone di maggior successo di Fortini, Quella cosa in Lombardia, viene cantata in un recital al teatro Gerolamo da Laura Betti. Nello stesso anno muore Olivetti, che Fortini ricorderà in un breve articolo sull’Avanti!, e Noventa al quale dedicherà la poesia Per Noventa: "Più d’ogni parola a me maestro/ per disperato orgoglio a falsi òmeni,/ vecchio, fingevi d’arrenderti. Io / ero lontano da te, coi tuoi versi". Nel luglio dello stesso anno, dopo la manifestazione in piazza contro il governo Tambroni, parte con la moglie Ruth per l’URSS e il viaggio, compiuto in macchina, durerà un mese. Di ritorno dal viaggio, su sollecitazione di Vittorini, pubblica un saggio su Le poesie italiane di questi anni, traduce Zazie nel metrò di Queneau e scrive il testo per il documentario All’armi siam fascisti! di Cecilia Mangini, Lina Dal Fra e Lino Micciché. Nel 1961 Fortini continua le traduzioni da Brecht e pubblica, sul secondo numero di Rendiconti, una serie di poesie tra cui La gronda. Sarà di questo anno la sua partecipazione alla prima “Marcia della pace” da Perugia ad Assisi, insieme a Solmi, Calvino, Capitini e Fausto Amodei, con il quale nell’occasione compose la canzone che nella versione discografica prenderà il nome di La marcia della pace. Termina intanto l’esperienza della “PBE” e Fortini rimane consulente dell’Einaudi ma senza uno specifico incarico editoriale. Nel novembre, in seguito alla repressione da parte della polizia parigina di una manifestazione a favore dell’indipendenza algerina, rimprovera Barthes e altri intellettuali di aver assunto un atteggiamento distaccato rispetto agli avvenimenti e proprio con Barthes avrà un duro scambio epistolare. In questi anni di “occultamento politico” Fortini inizia un diverso ciclo di collaborazioni entrando in contatto con gruppi eterogenei di intellettuali, coloro che nel corso degli anni sessanta e settanta contribuiranno al rinnovamento della cultura italiana. Inizia a frequentare il gruppo di “Quaderni rossi” e inizia la collaborazione alla rivista Quaderni Piacentini alla quale fornirà l’indirizzo per i primi numeri. Prosegue intanto la sua attività di recensore e di saggista sulla rivista Il Menabò e su quella di Vittorio Sereni, “Questo e altro” dove continua la serie delle “Cronache della vita breve”. Il 26 gennaio del 1962 muore il padre. Nei mesi che seguono la sua scomparsa, Fortini riprende la Poesia delle rose, un poemetto di 144 versi originariamente scritto nel 1956, per pubblicarlo con la Libreria Antiquaria Palmaverde di Bologna di Roversi. Scrive intanto il testo, su richiesta di Paolo e Carla Gobetti, per il documentario “Scioperi a Torino” che otterrà forti proteste sindacali oltre che il giudizio negativo di Italo Calvino che dissentiva da quello che gli sembrava un attacco da sinistra alle posizioni sindacali. Dal 1963 al 1987: una nuova svolta Nel 1963, ottenuta la riammissione nei ruoli della Pubblica Istruzione, Fortini inizia la carriera d’insegnante. Ottiene i primi incarichi di Lettere italiane e Storia dapprima in alcuni istituti tecnici di Lecco e di Monza per poi approdare, nel 1966 a Milano. Il '63 è anche un anno importante per la storia dello scrittore, infatti la casa editrice Mondadori, grazie a Sereni che ne è il direttore editoriale, pubblica la sua terza raccolta di versi Una volta per sempre che ottiene una buona attenzione da parte della critica. Ancora grazie a Sereni viene accolta nella collana “Il tornasole” Sere in Valdossola e le edizioni Avanti! pubblicano Tre testi per film che comprendono “All’armi siam fascisti”, “Scioperi a Torino” e “La statua di Stalin”. Sempre nel 1963 viene tradotta in tedesco per Suhrkamp un’antologia dei versi da “Poesia ed errore” e “Una volta per sempre” da Hans Magnus Enzensberger. Nel novembre termina il rapporto con Einaudi dopo varie proposte e controproposte di Giulio Bollati e di Giulio Einaudi riguardo alla sua funzione all’interno della casa editrice. Con l’arrivo dell’estate del 1964 Fortini si trasferisce nella nuova casa di Bavognano di Ameglia che sarà da quel momento il luogo delle sue vacanze e quello che farà da sfondo a molte sue poesie, disegni e pitture. Traduce con Ruth per Feltrinelli Poesie per chi non legge poesia di Enzensberger e collabora a Le muse. Enciclopedia di tutte le arti di De Agostini. Pubblica su Quaderni piacentini e Giovane critica alcuni saggi e l’11 settembre inizia la traduzione del Faust di Goethe con la consulenza del germanista Cases. Nel 1965 esce Verifica dei poteri dal Saggiatore e l’antologia Profezie e realtà del nostro secolo da Laterza, entrambi discussi e recensiti su molti periodici e quotidiani. Continua a ritmo intenso le letture più disparate e rimane colpito dal libro “Gli strumenti umani” di Sereni, di cui scrive, nel marzo 1966 un’ampia recensione su “I quaderni piacentini”. È di questo anno la polemica con le neoavanguardie che accusa di usare il sarcasmo come “destrutturazione verbale dei miti borghesi”. Nel dicembre dello stesso anno viene sequestrato il disco Le canzoni del no di Maria Monti, che contiene “La marcia della pace”, scritta in collaborazione con il cantautore torinese Fausto Amodei, e lo scrittore subisce un processo dal quale verrà però presto assolto. Nel 1966 pubblica L’ospite ingrato. Testi e note per versi ironici e all’inizio del 1967 pubblica la nuova edizione di Foglio di via. A Pasqua si reca a Praga con Zanzotto, Giudici e Sereni. Il 23 aprile partecipa ad una manifestazione per il Vietnam e viene criticato dagli organi di stampa del Partito comunista. Nell’estate, in seguito alla Guerra dei sei giorni, scrive I cani del Sinai che uscirà in autunno procurandogli “isolamento e odi tenaci”. Nel 1968 Fortini, pur continuando ad insegnare e a tradurre il Faust, è presente alle varie manifestazioni studentesche e nel momento di maggiore forza del Movimento studentesco pubblica su Quaderni piacentini il saggio Il dissenso e l’autorità. Sarà di questo periodo e proprio a causa delle lotte degli studenti e del loro scontro con la polizia la rottura definitiva con Pasolini alla fine di maggio. Alla tavola rotonda che si teneva a Roma organizzata da L’Espresso per l’intervento dello scrittore intitolato “Il PCI ai giovani!!”, Fortini legge privatamente all’amico il testo che aveva preparato per l’occasione nel quale affermava:"Presente e futuro dei movimenti studenteschi. Tema troppo serio per parlarne qui. Non sono qualificato per farlo (...). Qui si deve discutere invece di una carta scritta da uno dei maggiori scrittori del nostro paese.//Il mio giudizio è di tristezza e di rifiuto". In Attraverso Pasolini Fortini scrive: "...Ero davvero esasperato dal suo atteggiamento; ben più che per il testo a favore dei poliziotti, quel che trovavo insopportabile era di accettare lo sfruttamento pubblicitario, e la inevitabile trasformazione in volgare propaganda, di quel suo scritto". Dopo gli scontri di Parigi tra poliziotti e studenti, dove c’è il primo morto, Fortini insiste con Pasolini per persuaderlo a non far registrare il suo intervento su L’Espresso, ma all’indomani il testo viene comunque pubblicato e Fortini interviene sullo stesso quotidiano, il 23 giugno, con un articolo contro Pasolini dal titolo È come una carta acchiappamosche. Nel dicembre dello stesso anno pubblica Ventiquattro voci per un dizionario di lettere. Breve guida ad un buon uso dell’alfabeto e nello stesso mese, dopo la strage di Piazza Fontana, su richiesta degli studenti del liceo milanese tiene una lezione sull’Uomo a una dimensione di Marcuse. Partecipa ai funerali di Pinelli a Musocco il 20 dicembre e il racconto di quell’evento comparirà nella seconda edizione dell’Ospite ingrato. Nel gennaio del 1969 viene pubblicato da Mondadori nella collezione dello “Specchio” Poesia ed errore e contemporaneamente esce alle stampe la plaquette Venticinque poesie 1961-1968. In collaborazione con Augusto Vegezzi realizza un’antologia destinata al biennio delle scuole superiori intitolata Gli argomenti umani. In questo periodo collabora poco alle riviste e dedica la maggior parte del tempo alla traduzione del Faust terminandone la versione nel 1970. Il 21 gennaio 1970 Fortini partecipa ad una manifestazione indetta dal Movimento studentesco e dopo aver assistito in prima fila all’andamento degli scontri tra la polizia e gli studenti scrive per la Questura una Testimonianza dettagliata degli avvenimenti. A maggio Bucchi presenta, nel maggio Musicale di Firenze, la sua opera Il coccodrillo di cui fa parte la Canzone della coesistenza e Fortini scrive per l’autore la filastrocca Il Pero e il però. Alla fine del 1970 verrà pubblicata da l’Universidad de Venezuela di Caracas, l’edizione in lingua spagnola di Verifica dei poteri: Los poderes culturales. Nel 1971 Fortini ottiene il premio "Città di Monselice" per la traduzione letteraria del Faust e all’inizio di novembre tiene una lezione su Montale a Canterbury, all’Università del Kent. Nel corso dell’anno ottiene la libera docenza e da metà novembre inizia ad insegnare alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università di Siena, Storia della critica letteraria che inaugura con un corso monografico sulla poesia di Manzoni. Risalgono al maggio del 1972 i versi Per Serantini scritti per un giovane anarchico che era stato ucciso a Pisa dalla polizia durante una manifestazione: "A quelli che lo hanno ucciso/ il governo ha benedette le mani con un sorriso". Accetta in seguito di essere iscritto come indipendente nella lista elettorale del Manifesto, al quale collabora dall’anno precedente, per le elezioni legislative. Il capolista è Pietro Valpreda, l’anarchico accusato della strage di Piazza Fontana. Il quarto libro di versi: Questo muro In agosto si reca per la seconda volta in Cina e al rientro viene a sapere dall’amico Sereni che la raccolta Questo muro uscirà presto nello “Specchio” di Mondadori. Tiene intanto all’università il corso dedicato a "La poesia italiana degli anni 1910-1925 nella critica letteraria del periodo 1950-1970". Nel giugno del 1973 esce la raccolta Questo muro che comprende i versi composti dal 1962 al 1972 e a luglio viene pubblicato, nella collana monografica Il castoro della Nuova Italia, il primo studio approfondito sull’opera fortiniana dal titolo Franco Fortini di Alfonso Berardinelli. Si intensifica intanto la collaborazione a il manifesto e nell’estate del 1974 escono Saggi italiani e l’antologia Poesie scelte (1938-1973) curata da Pier Vincenzo Mengaldo. All’università tiene il corso dedicato a “Simbolismo europeo e simbolismo italiano nella critica dello scorso trentennio”, collabora alla rivista aut aut mentre interrompe la presenza su Quaderni piacentini. Muore a novembre del 1975 Pier Paolo Pasolini e Fortini partecipa ai funerali amareggiato, come scriverà in seguito, per non essere riuscito a risolvere le loro ostilità e vincere il silenzio degli ultimi sei anni. Con il 1976 inizia un periodo di intensa collaborazione al Corriere della Sera mentre ritorna a tradurre Brecht. Nell’estate di quello stesso anno viene girato il film di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet Fortini/cani, dai Cani del Sinai. All’università tiene un interessante corso biennale su "L’ordine e il disordine. Esempi di critica e di letteratura, in Italia e in Europa, nel periodo 1915-1925", nel quale analizza i testi di Croce, Gobetti, Gramsci, Ungaretti, Rebora, Onofri, Montale, Valéry, Šklovskij, Eliot, Breton, Trockij. Risale al 1977 la seconda edizione, in collaborazione con Walter Binni, del Movimento surrealista, I poeti del Novecento e la raccolta saggistica Questioni di frontiera. Scritti di politica e di letteratura 1965-1977. A novembre dello stesso anno, quando cambia la direzione del “Corriere della Sera”, Fortini interrompe la collaborazione. Intanto a Siena continua il corso dell’anno precedente discutendo nei seminari “Un’idea di Dante” di Gianfranco Contini e “Linguaggio e silenzio” di Steiner. Nel maggio del 1978 si reca in Inghilterra per tenere una conferenza all’Università del Surrey, a Brighton, dal titolo Dei confini della poesia e nello stesso anno vengono tradotte da Michael Hamburger una scelta di poesie tratte da “Una volta per sempre” e “Questo muro” mentre Einaudi raccoglie i suoi primi tre libri di poesia sotto il titolo Una volta per sempre. Poesie 1938-1973. Nel 1979 prosegue in modo assiduo la collaborazione al manifesto, ma un suo saggio pubblicato sui Quaderni Piacentini a proposito del Doppio diario di Giaime Pintor suscita molte polemiche determinando la frattura con Luigi Pintor direttore del manifesto’ e il rapporto termina bruscamente. Lavora nel frattempo ad un saggio su Noventa, tiene il corso all’università dedicato alle principali teorie della letteratura e in Francia, per i “Cahiers du cinéma” esce “Les chiens du Sinai” nell’edizione Albatros con la versione francese dei “Cani del Sinai”. Nel febbraio del 1980 viene pubblicata la plaquette intitolata Una obbedienza con l’introduzione di Andrea Zanzotto e durante l’estate esce la raccolta di saggi Per Franco Fortini. Contributi e testimonianze sulla sua poesia con gli interventi di Alberto Asor Rosa, Cesare Cases, Mario Luzi, Pier Vincenzo Mengaldo, Giovanni Raboni e Vittorio Sereni. Nei primi mesi del 1981 è a Parigi per preparare un corso su Manzoni e frequenta assiduamente la Bibliothèque Nationale. Si reca in seguito in Inghilterra e per qualche giorno è a Cambridge e a Londra. Nell’aprile dello stesso anno subisce una perquisizione da parte della Questura nella casa di via Legnano per le indagini in corso sulla “lotta armata” senza alcun risultato e da ottobre, terminata la collaborazione a “Il Messaggero”, riprende quella con il “Corriere della Sera”. Scrive Un vero veduto dalla mente su richiesta di Walter Binni, un testo autobiografico per le "Notizie e dichiarazioni di scrittori (1911-1917)" raccolte per la “Rassegna della letteratura italiana” e inizia a tradurre Milton. Nel 1982 continua la collaborazione con il “Corriere della Sera” diretto da Alberto Cavallari e a giugno dello stesso anno pubblica una scelta delle proprie versioni poetiche intitolata Il ladro di ciliegie e altre versioni di poesia mentre lavora alle traduzioni dei racconti di Kafka e dei versi giovanili di Proust. Nel 1983 muore l’amico Sereni e a lui lo scrittore dedica sul “Corriere della Sera” Un dialogo che non è finito. Lavora intanto a una Storia della traduzione dal “Conciliatore” a oggi e ad un’introduzione a Michelet. A novembre, in occasione dell’invasione da parte dell’esercito degli Stati Uniti dell’isola di Grenada, scrive sul “Corriere della Sera” l’articolo Quei morti strascinati con la faccia in giù, che suscita aspre critiche. Il quinto libro di versi: Paesaggio con serpente Nel gennaio del 1984 tiene una serie di conversazioni sulla Radio della Svizzera Italiana su autori e poeti italiani e ad aprile dello stesso anno esce il quarto libro di poesie intitolato Paesaggio con serpente. Invitato da Bruce Merry come visiting professor all’Università di Witswatersrand, Johannesburg, si reca a maggio in Sudafrica dove rimarrà fino a giugno tenendo lezioni e seminari su Leopardi, Dante, Lukács. Al rientro in patria interrompe la collaborazione con il Corriere della Sera e inizia quella con Panorama. Intanto continua le letture, pubblica una serie di versi destinati ad una nuova edizione dell’"Ospite ingrato" e realizza una plaquette intitolata Memorie per dopodomani nella quale raccoglie tre scritti del 1945, 1967 e 1980. All’inizio del 1985 pubblica Insistenze. Cinquanta scritti 1967-1984 e da aprile inizia a collaborare al L’espresso. In giugno gli viene assegnato il premio Montale-Guggenheim per la raccolta di poesie Paesaggio con serpente. In ottobre muore Calvino e Fortini pubblica su L’espresso il ricordo intitolato Quel che ci unisce, quel che ci divise. Viene intanto pubblicato dall’editore Marietti L’ospite ingrato primo e secondo. Tra gennaio e marzo del 1986 si reca più volte a trovare i detenuti per reati politici nel carcere di San Vittore e in primavera è a Palermo per il premio Mondello. Giunge intanto il momento della sua messa fuori ruolo come docente e l’Università di Siena organizza in quella occasione un seminario intitolato “Metrica e biografia. La ricerca poetica, critica e ideologica di Franco Fortini”. Esce nel frattempo La lotta mentale. Per un profilo di Franco Fortini di Romano Luperini che costituisce un importante punto di riferimento della bibliografia su Fortini poeta e intellettuale. In occasione del convegno su Giacomo Noventa che si tiene a Venezia e a Noventa di Piave, Fortini pubblica in forma di preprint un saggio scritto nel '79-80 intitolato Note su Giacomo Noventa. Esce intanto la plaquette I confini della poesia e il testo della prolusione tenuta nel dicembre del 1981 all’Università di Siena: La poesia ad alta voce. A novembre viene invitato a Lione da Remi Roche e Bernard Simeone per una conferenza e vengono intanto pubblicate, da Simeone e Jean-Charles Vegliante, una ricca scelta di poesie tradotte in francese con il titolo Une foìs pour toutes. Poésie 1938-1985 che comprende anche lo scambio epistolare tra Fortini e Roche. Alla fine dell’86 Einaudi pubblica la sua traduzione di Nella colonia penale e altri racconti di Kafka. Il periodo dal 1987 al 1990: il recupero degli scritti e l’opera della critica Esce nel luglio del 1987 una nuova serie di saggi sulla letteratura italiana dal titolo Nuovi Saggi italiani e a settembre una raccolta di versi scartati dalle prime due raccolte insieme ad inediti con il titolo Versi primi e distanti 1937-1957. In novembre si reca in Canada e negli Stati Uniti dove tiene una conferenza di teoria della letteratura alla Harvard University e a Toronto seminari e letture. Al rientro in Italia riprende la collaborazione con il Corriere della Sera e inoltre collabora all’Espresso e al Manifesto mentre procede al recupero di prove narrative disperse e inedite. A novembre esce la seconda monografia ad opera di Remo Pagnanelli. Nel gennaio del 1988 compie un viaggio con la moglie Ruth nei Grigioni e ad aprile si reca in Israele a trovare la figlia adottiva Livia che vi abita da un anno. In quell’occasione scrive un racconto dal titolo Un luogo sacro che sarà raccolto nel 1990 in Extrema ratio. Alla fine di maggio, nell’ambito dei festeggiamenti per il ritiro dall’insegnamento universitario, si inaugura a Siena una mostra intitolata “Franco Fortini:cinquant’anni di lavoro” e viene proiettato il film con la regia di Riccardo Putti “E vorreste non parlassero...”. Sempre nell’ambito dei festeggiamenti vengono pubblicati in suo onore da Luperini una miscellanea di saggi intitolata Tradizione/ traduzione/ società. Saggi per Franco Fortini, mentre a cura di Carlo Fini esce Indici per Fortini che contiene la bibliografia degli scritti, la guida ai soggetti dell’opera saggistica, una notizia biografica, l’antologia e la bibliografia della critica. Nel 1989 Einaudi pubblica la nuova edizione di Verifica dei poteri che contiene una premessa scritta alla fine del 1988. A maggio chiude definitivamente con il “Corriere della Sera” a causa di uno scontro con il direttore Ugo Stille che non vuole pubblicare un suo intervento sulla politica dello Stato d’Israele nei confronti della Palestina. L’articolo su Israele e Palestina uscirà con il titolo Lettera agli ebrei sul “Manifesto” il 24 maggio. Il 12 settembre viene pubblicato sul supplemento satirico “Cuore” dell’"Unità" il testo “Comunismo” scritto in seguito alla caduta del muro di Berlino. Gli ultimi anni: 1990-1994 In questo periodo Fortini continua a collaborare al Manifesto e all’Espresso e dal giugno 1992 al supplemento della domenica del Sole 24 ORE. Fino al 1992 ritorna ogni anno a Siena per tenere seminari e lezioni ai corsi di Storia della critica letteraria tenuti da Giuseppe Nava. Nell’inverno tra il 1989 e il 1990, tiene a Napoli una serie di 4 seminari dal titolo "Realtà e paradosso della traduzione poetica", organizzata dall’Istituto di Studi Filosofici per iniziativa del Professore Gargano, dei cui atti esce un’edizione universitaria (University College London, 2004), a cura di Erminia Passannanti. Nel febbraio del 1990 si reca a Napoli per un seminario sulla traduzione presso l’Istituto superiore di studi filosofici e a maggio partecipa a Siena ad un convegno dal titolo "1960-1990: le teorie letterarie, il dibattito metodologico e il conflitto delle poetiche". Nello stesso anno si reca a Londra per una lettura di poesie e durante l’estate lavora sul Tasso. A novembre Garzanti pubblica Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine e nel febbraio del 1991 esce, a cura di Paolo Jachia in stretta collaborazione con Fortini stesso, Non solo oggi. Cinquantanove voci, che estrae dai saggi e articoli una specie di dizionario fatto di parole-chiave del suo lavoro intellettuale. Nel 1992 compie durante l’anno alcuni viaggi per partecipare ad importanti convegni: ad aprile è a Toronto, a fine giugno a Dublino, nell’ottobre, dopo Vienna, è a Cracovia e a novembre a Lugano. Nel 1993, sempre curato dal giovane critico Jachia, esce Fortini. Leggere e scrivere che ripercorre in forma di colloquio, dall’infanzia in poi, le letture e le passioni intellettuali dello scrittore. Nell’aprile dello stesso anno viene pubblicato da Einaudi Attraverso Pasolini che comprende una piccola parte dell’opera ideata anni prima e annunciata come “in preparazione”, opera che uscirà postuma. A giugno viene ricoverato d’urgenza all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano per un intervento chirurgico. Gli viene diagnosticato un tumore al colon che non può essere rimosso. Si riprende lentamente e ritorna ad Ameglia ma l’11 settembre deve essere nuovamente operato. L’intervento ha luogo nell’ospedale di Barga, in provincia di Lucca. Il 5 ottobre viene dimesso e dopo un breve periodo ad Ameglia rientra a Milano. Muore il 28 novembre 1994 e la salma viene inumata presso il cimitero di Montemarcello ad Ameglia. Il sesto libro di versi: Composita solvantur A febbraio del 1994 viene pubblicato il suo sesto e ultimo libro di poesie dal titolo Composita solvantur (alcuni testi anticipati, con versione francese a fronte di J. Ch. Vegliante, su Les Langues Néo-Latines 265, 1988). A novembre è ricoverato all’Ospedale Sacco di Milano, dove muore la notte del 28. Archivio e biblioteca personale Prima di morire, dona alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena il suo archivio privato, di cui sono parte lettere, manoscritti, inediti, disegni e pitture. Nel 1995, dietro approvazione del Consiglio di Facoltà, si è costituito il Centro Studi Franco Fortini, i cui fini sono la promozione della sua opera, edita e inedita, e lo studio del suo lascito. Fra gli strumenti del centro, il periodico “L’ospite ingrato”, pubblicato con scadenza semestrale dell’editore Quodlibet, e disponibile in rete “L’ospite ingrato” Rivista del Centro Studi Franco Fortini Attività di paroliere Scrisse anche alcuni testi per canzoni: suoi sono, pur se non compare nei crediti, i versi iniziali che costituiscono l’incipit di Domenica e lunedì di Angelo Branduardi, suo allievo di liceo; scrisse inoltre una versione del canto socialista L’Internazionale, più fedele al testo originale rispetto al libero adattamento di E. Bergeret (che è la più diffusa in Italia), Quella cosa in Lombardia di Enzo Jannacci e un Inno nazionale (parodia dell’Inno di Mameli). Opere Libri e raccolte * Foglio di via e altri versi, Einaudi, Torino, 1946 (edizione critica e commentata a cura di Bernardo De Luca, Quodlibet, Macerata, 2018) * Agonia di Natale, Einaudi, Torino 1948; seconda edizione Giovanni e le mani, prefazione di Giovanni Raboni, Einaudi, Torino, 1972. * Sei poesie per Ruth e una per me, tipografia Lucini, Milano, 1953. * Una facile allegoria, Edizioni della Meridiana, Milano, 1954. * In una strada di Firenze, Edizioni Linea grafiche, Milano, 1955. * Asia maggiore. Viaggio nella Cina, Einaudi, Torino, 1956. * I destini generali, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1956. * Dieci inverni (1947-1957) Contributi ad un discorso socialista, Feltrinelli, Milano, 1957. * Sestina a Firenze, Schwarz, Milano, 1959. * Il movimento surrealista, Garzanti, Milano, 1959. * Poesia e errore, Feltrinelli, Milano, 1959. * Poesia delle rose, Libreria Antiquaria Palmaverde, Bologna, 1962. * Sere in Valdossola, Mondadori, Milano, 1963. * Tre testi per film, Edizioni Avanti!, Milano, 1963. * Una volta per sempre, Mondadori, Milano, 1963. * Profezie e realtà del nostro secolo. Testi e documenti per la storia di domani, Laterza, Bari, 1965. * Verifica dei poteri. Scritti di critica e di istituzioni letterarie, Il Saggiatore, Milano, 1965. * L’ospite ingrato. Testi e note per versi ironici, De Donato, Bari, 1966. * I cani del Sinai, De Donato, Bari, 1967: nuova edizione Einaudi, Torino, 1979 con una Nota 1978 per Jean– Marie Straub; nuova edizione con in appendice F, Fortini, Lettera agli ebrei italiani, Quodlibet, Macerata, 2002. * Ventiquattro voci per un dizionario di lettere, sottotitolo di copertina Breve guida a un buon uso dell’alfabeto, Il Saggiatore, Milano, 1968. * Ventiquattro poesie 1961-1968, S.I.E., (1969). * Questo muro, Mondadori, Milano, 1973. * Saggi italiani, De Donato, Bari, 1974. * La poesia di Scotellaro, Basilicata, Roma, 1974. * Poesie scelte (1938-1973) a cura di Pier Vincenzo Mangaldo, Oscar Mondadori, Milano, 1974. * I poeti del Novecento, Laterza, Bari, 1977. * Questioni di frontiera. Scritti di politica e di letteratura 1965- 1977, Einaudi, Torino, 1977. * Una volta per sempre (Foglio di via – Poesia e errore – Una volta per sempre– Questo muro) Poesie 1938-1973, Einaudi, Torino, 1978. * Una obbedienza, introduzione di Andrea Zanzotto, Genova, Edizioni San Marco dei Giustiniani, 1980. * Il ladro di ciliegie e altre versioni di poesia, Einaudi, Torino, 1982. * Memorie per dopodomani. Tre scritti 1945 1967 e 1980, a cura di Carlo Fini, Quaderni di Barbablù, Siena, 1984. * Paesaggio con serpente, Einaudi, Torino, 1984. * Inesistenze.Cinquanta scritti 1976-1984, Garzanti, Milano, 1985. * Dei confini della poesia, Edizioni l’Obliquo, Brescia, 1986. * La poesia ad alta voce, a cura di Carlo Fini, Taccuini di Barbablù, Siena, 1986. * Note su Giacomo Noventa, Marsilio, Venezia, 1986. * Nuovi Saggi italiani 2, Garzanti, Milano, 1987. * Versi primi e distanti 1937-1957, All’insegna del pesce d’oro, Milano, 1987. * La cena delle ceneri & Racconto fiorentino, prefazione di Mario Spinella, Claudio Lombardi Editore, Milano, 1988. * La morte del cherubino. Racconto 1938, a cura di Carlo Fini, Taccuini di Barbablù, Siena, 1988. * Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine, Garzanti, Milano, 1990. * Versi scelti 1939-1989, Einaudi, Torino, 1990. * Diario tedesco 1949, Piero Manni, Lecce, 1991. * Non solo oggi. Cinquantanove voci, a cura di Paolo Jachia, Editori Riuniti, Roma, 1991. * Attraverso Pasolini, Einaudi, Torino, 1993. * Composita solvantur, Einaudi, Torino, 1994. * La guerra a Milano. Estate 1943. Edizione critica e commento a cura di Alessandro La Monica, Pisa, Pacini Editore, 2017. Edizioni postume * Poesie inedite, a cura di Pier Vincenzo Mengaldo, Einaudi, Torino 1995 * Trentasei moderni. Breve secondo Novecento, prefazione di Romano Luperini, Manni, Lecce 1996 * Disobbedienze 1. Gli anni della sconfitta. Scritti sul Manifesto 1985-1994, prefazione di Rossanna Rossanda, manifestolibri, Roma 1997 * Dialoghi con Tasso, a cura di Pier Vincenzo Mengaldo e Donatello Santarone, Bollati Boringhieri, Torino 1998 * Dissobedienze II. Gli anni dei movimenti. Scritti sul Manifesto 1972-1985, manifestolibri, Roma 1988 * Franchi dialoghi, F. Fortini– F. Loi, Manni, Lecce 1998 * Il dolore della verità: Maggiani incontra Fortini, a cura di Erminio Risso, Manni, Lecce 2000 * Le rose dell’abisso, a cura di Donatello Santarone, Bollati Boringhieri, Torino 2000 * Disegni Incisioni Dipinti. Catalogo ragionato della produzione pittorica e grafica di Franco Fortini, a cura di Enrico Crispolti, Quodlibet, Macerata 2001 * I cani del Sinai, Quodlibet, Macerata 2002 * Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-1994, a cura di Velio Abati, Bollati Boringhieri, Torino 2003 * Un giorno o l’altro, Quodlibet, Macerata 2006 * Lezioni sulla traduzione, Quodlibet, Macerata 2011 * Capoversi su Kafka, Hacca, Matelica 2018 Traduzioni in volume * G. Flaubert, Un cuore semplice, Edizioni “Lettere d’oggi”, Roma 1942 * C.F. Ramuz, Statura umana, Edizioni di comunità, Milano 1947 * P. Éluard, Poesia ininterrotta (Illustrazioni di Bruno Cassinari), Einaudi, Torino 1947 * S. Kierkegaard, Timore e tremore (Lirica dialettica di Johannes de Silentio), prefazione di J.Wahl, Edizioni di Comunità, Milano 1948 * A. Döblin, Addio al Reno (in collaborazione con Ruth Leiser), Einaudi, Torino 1949 * A. Gide, Viaggio al Congo e ritorno dal Ciad, Einaudi, Torino 1950 * B. Brecht, Madre Courage e i suoi figli (in collaborazione con Ruth Leiser) Einaudi, Torino 1951 * B. Brecht, Santa Giovanna dei macelli (in collaborazione con Ruth Leiser), Einaudi, Torino 1951 * M. Proust, Albertine scomparsa, in Alla ricerca del tempo perduto, Einaudi, Torino 1951 * S. Weil, L’ombra e la grazia, introduzione di G. Thibon, Edizioni di Comunità, Milano 1951 * S. Weil, La condizione operaia, introduzione di A. Thévenon, Edizioni di Comunità, Milano 1952 * M. Proust, Jean Santeuil, Einaudi, Torino 1953 * S. Weil, La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso la creatura umana, Edizioni di Comunità, Milano 1954 * P. Éluard, Poesie. Con l’aggiunta di alcuni scritti di poetica, Einaudi, Torino 1976 * J.W. Goethe, Goetz von Berlichingen (in collaborazione con Ruth Leiser) in: Teatro tedesco dell’età romantica, Edizioni RAI, Torino 1956 * A. Einstein, Idee e opinioni (con la consulenza di Camillo Losurdo), Schwarz, Milano 1957 * B. Brecht, Il romanzo da tre soldi (in collaborazione con Ruth Leiser), Einaudi, Torino 1958 * B. Brecht, Poesie e Canzoni, (in collaborazione con Ruth Leiser), bibliografia musicale di G. Manzoni, Einaudi, Torino 1959 * B. Brecht, Storie da calendario, (in collaborazione con Ruth Leiser), Einaudi, Torino 1959 * R. Queneau, Zazie nel metrò, Einaudi, Torino 1960 * L. Goldmann, B. Pascal e J. Racine, (in collaborazione con Luciano Amodio), Lerici, Milano 1961 * A. Frénaud, L’agonia del generale Krivitski, Il saggiatore, Milano 1962 * H.M. Enzensberger, Poesie per chi non legge poesia. Trenta poesie (in collaborazione con Ruth Leiser), Feltrinelli, Milano 1964, Milano * P. Huchel, Strade strade (in collaborazione con Ruth Leiser), Mondadori, Milano 1970 * J.W. Goethe, Faust, I meridiani, Mondadori, Milano 1970 * B. Brecht, Poesie di Svendborg seguite dalla Raccolta Steffin (con una introduzione del traduttore), Einaudi, Torino 1976 * M. Proust, Poesie, Einaudi, Torino 1938 * F. Kafka, Nella colonia penale e alti racconti (con una nota del traduttore), Einaudi, Torino 1986 Opere in collaborazione * Olivetti 1908-1958, a cura di L. Bigongiari, testi di F. Fortini, Olivetti, Ivrea 1958 * Gli argomenti umani. Antologia italiana per il biennio delle scuole superiori, di A.Vegezzi e F. Fortini, Morano, Napoli 1969 Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Fortini

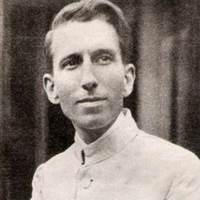
Guido Gustavo Gozzano (Torino, 19 dicembre 1883 – Torino, 9 agosto 1916) è stato un poeta, scrittore e autore di fantascienza italiano. Il suo nome è spesso associato alla corrente letteraria post-decadente del crepuscolarismo. Nato da una famiglia benestante di Agliè, inizialmente si dedicò alla poesia nell’emulazione di D’Annunzio e del suo mito del dandy. Successivamente, la scoperta delle liriche di Giovanni Pascoli lo avvicinò alla cerchia di poeti intimisti che, poi, sarebbero stati denominati “crepuscolari”, accomunati dall’attenzione per “le buone cose di pessimo gusto”, con qualche accenno estetizzante, il "ciarpame reietto, così caro alla mia Musa", come le definì ironicamente lui stesso. Morì a soli 32 anni, a causa del cosiddetto mal sottile, termine caduto in disuso che stava ad indicare la tubercolosi polmonare che lo affliggeva.


Torquato Tasso (Sorrento, 11 marzo 1544 – Roma, 25 aprile 1595) è stato un poeta, scrittore, drammaturgo e filosofo italiano. La sua opera più importante, conosciuta e tradotta in molte lingue è la Gerusalemme liberata (1581), in cui vengono cantati gli scontri tra cristiani e musulmani durante la prima crociata, culminanti nella presa cristiana di Gerusalemme.

Mi chiamo Nicola Rosafio. Ho da sempre la passione per la poesia. Scrivo di rapporti umani, amori finiti o impossibili. La mia scrittura è semplice,avendo fatto studi tecnici, ma proprio per questo arriva a tutti, sperando di sortire le emozioni che solo l’arte puo’ dare, più di tutto la poesia.

Nasco a Ceprano (Fr), il 2 luglio del 1965. Trasferito a Roma nel 1972, qui cresco e la Capitale diventa la mia città. Fin da giovane si fa sentire la voglia di scrivere. Più di un romanzo fantasy iniziato, ma mai nessuno finito. La passione per la lettura è forte. Per lo più romanzi, fantasy, gialli, fantascienza, qualche saggio e la passione per quelli storici, soprattutto ambientati nell'antica Roma. I racconti di Danila Comastri Mintanari diventano fonte di ispirazione. Scriverò il primo racconto ad ambientazione storica, Arcanum, auto pubblicato su Amazon. Inizio nel frattempo a buttar giù qualche poesia, niente di che. Una decina di anni fa'inizio a scrivere in maniera più serrata. Sempre auto pubblicati prendono luce L'anima scritta, poi l'anima nel cuore e uno per un pubblico più adulto...Sotto i vestiti l'anima. Solo nel 2022 parte un progetto che vedrà pubblicato da Francesco Tozzuolo Editore il primo libro "vero", Raccolta di pezzi d'anima. Ed ora eccomi qua. Sinceramente cerco persone che sappiano giudicare i miei scritti. A me tutto ciò che scrivo pare pessimo, aspetto il giudizio di chi è sicuramente migliore di me
“Senza poeti, senza artisti, gli uomini sarebbero presto stanchi della monotonia della natura.” —Guillaume Apollinaire
“La poesia è il fuoriuscire spontaneo di sentimenti potenti: essa trae origine dall'emozione raccolta in tranquillità” —William Wordsworth